|
SETTE MODI DIVERSI PER INIZIARE UNA STORIA
Calogero Diotallevi non era certo un nome molto adatto ad uno scrittore di libri per ragazzi. Per questo aveva accettato senza protestare lo pseudonimo di Zio Remo impostogli dall’editore. Non ci teneva poi tanto ad essere noto sotto il suo vero nome; non era un esibizionista e l’appellativo di Zio Remo, con cui tutti i ragazzini ormai lo conoscevano e lo chiamavano, gli bastava per renderlo felice. La cosa cui più teneva era quella di scrivere dei bei racconti; trovare soggetti interessanti, intrecciare trame avvincenti. Non è facile scrivere per i giovani come taluni credono. “Be’, in fondo, - pensano i più - cosa ci vuole a scrivere un libro per dei marmocchi? Il loro cervello è abituato a bersi tutto”. Che ci provassero un poco e avrebbero capito che non è per nulla facile. Il difficile per Zio Remo, una volta trovato l’argomento, era l’inizio. “Chi ben comincia è già a metà dell’opra”, diceva un proverbio. E lui voleva subito essere a ‘metà dell’opra’, come quel mattino, seduto davanti al suo elaboratore elettronico. Si trattava di un semplice Personal Computer con incluso un progamma di video-scrittura poco sofisticato; ma lui non voleva chiamarlo computer, all’americana, bensì con termini italiani. “Se esistono nella nostra lingua, perché non usarli?”, sosteneva sempre. Zio Remo chiamava quindi elaboratore elettronico il suo computer. Prima di iniziare a battere sui tasti Zio Remo era solito costruirsi una scaletta da seguire suddivisa in capitoli (anche se poi, scrivendo, la fantasia lo dirottava verso altri orizzonti). Poi cercava il genere, una scelta per lui sempre difficile, quasi tragica. E per superare la ‘tragicità della scelta’ aveva trovato un trucchetto letterario: prima di decidere quale genere seguire, scriveva sull’argomento scelto il primo capitolo del futuro romanzo adattandolo ai vari generi. Alla fine avrebbe scelto tra i primi capitoli scritti quello che gli pareva più congeniale e adatto alla storia che aveva in mente e poi proseguiva nei capitoli successivi, lasciando che la sua fantasia si sbizzarrisse sul tema. Più di una volta gli era capitato, come era accaduto al proverbiale asino di Buridano, di non sapersi decidere e allora si affidava al caso. Pronto a ricominciare, se non se la sentiva più di continuare, scegliendo un altro primo capitolo. Quel giorno Zio Remo si sentiva in vena. Si sedette davanti all’elaboratore elettronico, fece crocchiare le dita per renderle più agili e poi cominciò a digitare sulla tastiera:
SCALETTA Capitolo primo
- Il protagonista, di nome Giulio, prende spesso la corriera per recarsi dai nonni dove di solito trascorre tutti i fine settimana. - Durante il percorso assiste a... o gli capita di ... - Descrizione della scena. - Personaggi. - Ad un certo punto capita un incidente... o qualcos’altro... - Reazioni dei presenti. - Reazioni di Giulio.
Una scaletta molto breve. L’essenziale per dare l’avvio. Zio Remo la rilesse e la trovò banale. Ma proprio qui sta l’abilità dello scrittore, si disse: vivacizzare il banale e rendere appetibile e interessante una storia. Per prima cosa, ritenne opportuno scegliere il genere e, si sa, i generi in campo letterario non sono pochi: spaziano dall’avventura, all’umorismo, al giallo, alla fantascienza, alla fiaba-fantasy, all’horror, alla storia, ai ricordi del passato e ad altro ancora. Difficile scegliere. - Come al solito li proverò tutti - borbottò - e, per ognuno, scriverò il primo capitolo. Poi deciderò quale scegliere - concluse. Si soffermò a guardare la scaletta poco invitante. Rifletté alcuni minuti per mettere a fuoco le idee e poi cominciò a battere sui tasti.
TITOLO DEL LIBRO (per ora lasciamolo in bianco)
Genere: Avventura
Capitolo primo La corrida
La vecchia corriera arrancava sbuffando lungo la strada che dal mare si inoltrava nell’entroterra per raggiungere i vari paesi costruiti nel fondo valle le cui case più vecchie sorgevano lungo le sponde di un torrente, mentre le poche abitazioni nuove si ergevano a mezza costa in mezzo a terrazze digradanti e a folte macchie di pini e di uliveti. Il paese dove abitavano i nonni era fatto di case vecchie strette, raggruppate attorno ad un castello diruto in cui nidificavano merli e corvi. Lo abitavano per lo più persone anziane perché i giovani, poco propensi a lavorare la terra, avevano scelto le cittadine lungo la costa per trovare lavori meno faticosi. Solo i vecchi erano rimasti, come cozze abbarbicate agli scogli. Non si allontanavano dai luoghi in cui erano nati e vissuti e, nel caso dei suoi nonni, nessun allettamento, nessuna preghiera da parte dei suoi genitori li avevano stanati dalla loro casa di mattoni rossi per venire ad abitare in città. Di questo Giulio gliene era, un poco egoisticamente, grato perché gli permetteva ogni sabato di lasciare le vie piene di smog per andare a godersi l’aria fresca e pulita della campagna, la calma e la serenità che per sei giorni aveva sognato quando, col capo ciondolante per la noia, guardava il cielo azzurro attraverso le finestre della sua classe. - Giulio, che fai? Studi forse il volo degli uccelli?- lo rimbrottava spesso il maestro, riportandolo alla realtà, mentre i suoi compagni ridacchiavano. E sì, Giulio in quei momenti sognava. Sognava la casa dei nonni e le corse sui prati. Sognava proprio come in quel momento, mentre rivedeva mentalmente il prato che da poco la corriera si era lasciata alle spalle dove pascolavano alcune mucche. Fu il vociare confuso dei passeggeri e il brusco arresto della corriera giunta al capolinea a riportarlo alla realtà. Giulio si guardò attorno e vide la piazza dove la corriera si fermava e dove solitamente il nonno lo attendeva, fumando un sigaro. Ma quel giorno non poté vederlo perché sulla piazza stava accadendo qualcosa di strano e di insolito. Dal finestrino si vedeva molta gente correre a destra e a sinistra, senza una meta precisa, col viso stravolto, quasi fosse inseguita da qualche mostro. L’autista, che si era ben guardato dall’aprire le porte, osservava la scena dal parabrezza mentre i viaggiatori si erano affacciati ai finestrini per cercare di capire che cosa stava succedendo. Le grida di coloro che correvano per la piazza non permettevano di comprenderne la causa. - Arriva! Fate attenzione! - Chiudetevi in casa e sbarrate le porte! - E’ infuriato e soffia come un mantice! - Sì, sì, l’ho visto io raschiare il selciato. Le pietre schizzavano da ogni parte! Chi o che cosa fosse a causare tanto tumulto non era facile capire, finché da una stretta viuzza non sbucò una massa nera, enorme che, dopo aver raggiunto il centro della piazza si arrestò. Giulio riconobbe subito il ’mostro’. L’aveva visto molte volte durante le sue scorribande per la campagna e non gli era mai parso pericoloso, sebbene attorno a lui fosse stato costruito un solido recinto di pali. Chissà che cosa lo aveva fatto infuriare tanto da mettere in pericolo la gente del paese. Il ‘mostro’ era Pablito, il toro nero che Giacinto custodiva poco fuori del paese. Giulio non aveva mai capito a che cosa servisse. L’aveva persino chiesto al nonno. - Nonno, che se ne fa Giacinto di Pablito se non lo aggioga mai all’aratro per arare la terra? - Non è mica un bue! I tori non servono per arare i campi. - E allora a che servono? Nonno Giuseppe aveva guardato verso la moglie prima di rispondergli e nonna Cati gli aveva fatto un impercettibile segno di diniego, che era sfuggito al nipote. - Tu non conosci Giacinto, - farfugliò il nonno. - Quello è un esibizionista e siccome in paese nessuno possiede un toro, lui vuole essere superiore a tutti dimostrando che ne ha uno. Giulio si era accontentato della risposta e ora guardava Pablito che, come qualcuno aveva gridato, sbuffava e soffiava dalle froge nuvolette di fumo. Era proprio ‘indragato come un Minotauro’, pensò, ricordando l’espressione usata da un suo compagno di classe per dire che uno era infuriato al massimo. Pablito dal centro della piazza si guardò attorno e fissò un gruppetto di giovanotti che si erano rifugiati dietro i tavolini del bar. Dopo averli ben inquadrati, il toro raschiò con gli zoccoli anteriori il suolo, quasi ad arrotarsi le unghie, e poi a testa bassa partì alla carica. Incurante degli ostacoli che incontrava, sedie e tavoli che volarono da ogni parte, costrinse i malcapitati a trovar riparo in qualche androne o dietro i tronchi di alcuni platani. Visto che nulla più si muoveva il toro si fermò e prese a guardarsi attorno con gli occhi iniettati di sangue. Poi qualcuno, memore di qualche corrida vista in televisione, cominciò ad agitare un drappo da dietro gli alberi e l’animale non si fece pregare a continuare a caricare qualsiasi cosa si muovesse. Al riparo dentro la corriera Giulio cominciò a divertirsi. Non aveva certo previsto di capitare in mezzo ad una corrida e la cosa gli andava a genio. Vedeva in diretta una scena che gli ricordava il film Quo vadis cui aveva assistito alcune sere prima. Purtroppo in paese non c’era nessuno a fare la parte di Ursus e capace di prendere Pablito per le corna e atterrarlo. Gli improvvisati toreri se ne stavano ben lontani, e si limitavano solo a stuzzicare l’animale. Padron Giacinto, in un angolo della piazza, con le mani tra i capelli, chiamava invano l’animale e intanto pensava a come avrebbe fatto a pagare tutti i danni fatti da Pablito. - Maledetto! Se pesco chi ha aperto il cancelletto lo strozzo! - urlava a tratti, agitando i pugni e poi rimettendosi le mani tra i capelli. Una camionetta dei carabinieri si era, intanto, fermata sulla piazza e due militi avevano imbracciato i fucili, pronti a far fuoco. - Ma che, siete matti! Non vorrete mica ucciderlo, no? - prese a gridare Giacinto. Pablito, vedendo la camionetta dei carabinieri muoversi, partì a testa bassa e, incurante di ogni cosa, affondò le corna nella ruota posteriore, sistemata sul retro dell’automezzo. Si avvertì lo scoppio dello pneumatico forato e, mentre l’animale cercava di liberare le corna, i due carabinieri raggiunsero di corsa Giacinto dietro un platano. - Telefona subito al veterinario, - ordinò il brigadiere al suo compagno, - e spiegagli la situazione. Forse lui troverà il modo di calmare quel bestione. Intanto Pablito, liberate le corna, e frastornato dallo scoppio da lui provocato, riprese a correre a destra e a manca tutto travolgendo e spaccando. Sembrava divertirsi nel prendere di mira le vetrine dei negozi e mandarle a pezzi. Tentava pure di sfondare a cornate le porte, ma quelle erano più resistenti e, tranne qualche scheggia di legno che volava via, non cedevano. - Ecco il veterinario, - disse il brigadiere, vedendo un ometto far capolino da dietro una automobile parcheggiata in piazza. L’uomo imbracciava un fucile. - Ma che fa? - esclamò Giacinto, preoccupato per il suo animale. - Mica vorrà ucciderlo lui! - Stia calmo. Se il toro doveva morire, avrebbe detto a noi di intervenire, - lo tranquillizzò il brigadiere. - Se non l’ha fatto e si è portato un fucile, saprà lui quale sia la soluzione migliore. Il veterinario si appoggiò al cofano della macchina dietro alla quale stava al riparo e cominciò a gridare: “Olé, toro, olé!” per attirare l’attenzione di Pablito. Poi prese la mira. Il toro non si fece ripetere due volte l’invito e attaccò a testa bassa. Quando si trovò a poca distanza, il veterinario sparò. Si udì solo uno schiocco. Pablito non sembrò avvertire nessun dolore e continuò nello slancio, affondando le corna nella portiera della macchina. - La mia Volvo! - urlò una voce. - Giacinto questa cornata la pagherai cara! - disse il padrone dell’auto. Il povero Giacinto affondò ancora di più le mani nei capelli. Il contraccolpo parve frastornare il povero animale. Arretrò verso il centro della piazza e cominciò a traballare sulle gambe. - Che cosa gli accade? - disse Giulio, rivolgendosi all’autista della corriera. - Era l’unico modo per fermarlo. Il veterinario gli ha sparato una siringa piena di tranquillante. Ecco, guarda. Giulio vide il toro nero traballare sempre più; vide le sue ginocchia piegarsi lentamente e poi le gambe cedergli di schianto. Pablito si abbattè a terra dove rimase immobile scalciando sempre più lentamente. - Ecco, ora è finita - disse il veterinario, lasciando il riparo della Volvo ammaccata. - Ora potete imbracarlo in qualche modo e riportarlo nel recinto. La corrida è finita, signori. Le porte della corriera si aprirono e tutti corsero a vedere l’animale steso a terra. Anche Giulio si unì agli spettatori.. - Ti è piaciuto lo spettacolo? - gli disse una voce conosciuta. Il ragazzo si voltò e sorrise al nonno. - Ne avrai cose da raccontare ai tuoi compagni al rientro in classe. Vieni, andiamo a casa. Nonna ci aspetta. Comincerai a raccontarla a lei questa avventura.
Zio Remo rilesse quanto aveva scritto. Giunto alla fine, pensò: “Beh, forse si potrebbe far di meglio. In fondo non è che l’inizio di quella che potrebbe essere una lunga storia. Comunque il primo capitolo c’è. Vedremo come proseguire con i successivi e quali altre avventure escogitare. Direi ora di cambiare genere. E se provassi con l’umorismo?
Genere : Umorismo
Capitolo primo Il vecchio della corriera
Con un cenno della mano Giulio, affacciato al finestrino della corriera, salutò sua madre. Come ogni sabato l’aveva accompagnato alla corriera che lo avrebbe portato dai nonni per passare un breve fine settimana. - Mi raccomando, Giulio, non fare arrabbiare il nonno e ubbidisci alla nonna. - Sta tranquilla, mà. - La donna scosse la testa poco convinta e poi si allontanò lentamente. Giulio si sedette a fianco di un signore anziano, baffuto, il quale teneva in bocca una corta pipa spenta. Davanti a lui c’era una signora grassoccia, dal volto rubizzo solcato da venuzze rosse. Teneva sulle ginocchia un cesto tutto chiuso in cui qualcosa si muoveva a tratti: probabilmente un animale comprato al mercato. Al suo fianco stava un signore vestito alla tirolese con appesa al collo una macchina fotografica e tra le mani un libretto turistico. Un turista evidentemente. - E proprio questa la corriera per Pigna? - chiese. - Sì, - rispose il vecchio. - Dove va, signore? - A Pigna. Mi hanno detto che c’è un gruppo di case che risale al medioevo. Vorrei fotografarlo. Ci vorrà molto prima di arrivare a Pigna? - Dipende dalle fermate e dalla sete del nostro autista, - gli rispose il vecchio. - A lui piace far sosta anche nelle osterie. Comunque un due ore circa. Il turista si immerse nella consultazione del suo libretto. - Ha fatto buone compere? - chiese il vecchio alla donna. - Sì, ho comprato un gatto per mia figlia - rispose accennando al cesto coperto. - Ne ha voluto uno speciale così gli ho comprato un bel siamese. - Speciale - ripeta il vecchio. - Oggi per avere qualche animale speciale bisogna rivolgersi all’estero. E dire che anche qui da noi abbiamo gatti speciali. - E quali? - si intromise Giulio che di gatti se ne intendeva. Erano i suoi animali preferiti. - Ragazzo, hai mai sentito parlare dei Testatonda? - E vedendo che Giulio scuoteva il capo, continuò: - Il Testatonda (o Felis nerviensis come lo hanno classificato gli zoologi) appartiene ad una razza speciale che vive solo in questa valle. Purtroppo è una specie in estinzione. La sua particolarità consiste nel non avere le orecchie e le vibrisse. Vedi, ragazzo, i gatti possono procurarsi il cibo solo cacciando e le prede o le avvertono ascoltandone i rumori con le loro sensibili orecchie; oppure le scoprono intercettandole con le vibrazioni che percepiscono con le vibrisse, quelle che tutti chiamano baffi. Se ne sono privi, per loro sono guai perché non possono procurarsi il cibo. Sono gatti un poco simili a quelli dell’Isola di Man che sono senza coda. Ma la coda serve a poco mentre orecchie e vibrisse sì. - Non ne ho mai sentito parlare - disse la donna. - Lei ne ha visto qualcuno? - Per la verità sì. Ne ho visto un paio alcuni anni fa. Oggi è difficile vederli sia perché ne sono rimasti pochi, sia perché sono timidi e rifuggono dal contatto con gli uomini. Ne hanno timore e perciò vivono nelle macchie dei boschi. - E come mai sono privi di orecchie e vibrisse? - chiese il turista che aveva ascoltato e pareva indeciso a credere al vecchio. - A causa di una maledizione gettata su di loro da un eremita. Così dice una leggenda. La corriera che, nel frattempo, si era messa in moto, attraversava il fondo valle pianeggiante che divideva il mare dai primi contrafforti delle colline. - Vedete quei ruderi laggiù? - disse il vecchio che continuava a parlare con la pipa tra i denti. - Laggiù qualche secolo fa abitava un eremita, un sant’uomo che viveva col poco cibo che qualche contadino gli portava. La sua sola compagnia era una coppia di gatti. La leggenda dice che erano animali molto pigri i quali, invece di cacciar topi, rubavano il cibo al loro padrone. Un giorno l’eremita, stanco di vedere la sua ciotola vuota, si adirò e li cacciò maledicendoli. “Razza di fannulloni e ladri, - disse - andrete raminghi tra i boschi e poiché non volete usare orecchie e baffi per la caccia, i vostri figli nasceranno privi di entrambi.” I due poveri animali scomparvero nel bosco e dopo un paio di anni alcuni cacciatori dissero di aver visto dei gattini privi di orecchie e vibrisse. - Sarei curiosa di vederne uno. Non conoscevo questa rarità, - disse la donna. Per un poco nessuno parlò. La corriera arrancava salendo attraverso vigneti e uliveti. A tratti faceva sosta per far scendere o salire qualche passeggero, poi riprendeva la marcia. - Ci sono anche altre rarità in questa valle, - riprese il vecchio togliendosi di bocca la pipa. - Avete mai sentito parlare delle tarnagasse? - Tarnagasse? - disse Giulio. - E che cosa sono. - Uccelli, anche questi in estinzione. Purtroppo, ragazzo mio, qui da noi il WWF fa assai poco e non si cura della nostra fauna. E dire che la tarnagassa è un uccello molto particolare e varrebbe la pena di salvaguardarlo. - Non ho mai sentito questo nome - si intromise il turista, - e dire che sono quasi un esperto di ornitologia. Che cosa avrebbero di strano queste tarnagasse? - Vede, signore, le tarnagasse (Linneo le chiamò col nome latino di Perdix claudicans) vivono da secoli nella nostra valle. Altrove non so. Sono uccelli grossi come piccioni, dalla testa tonda e dal becco molto appuntito e duro che serve loro per scovare i vermi sottoterra o nella corteccia degli alberi. Hanno un piumaggio il cui colore varia dal rossiccio al cinerino. La loro stranezza consiste nell’avere una zampa, quella sinistra, lunga il doppio di quella destra. - E come fanno a camminare? - chiese Giulio. - Devono trovare il terreno adatto. Le tarnagasse vivono solo sui pendii molto scoscesi e rocciosi, dove possono appoggiarsi con la zampa più lunga sulla parte inferiore della roccia e con la più corta su quella superiore, così il corpo rimane parallelo. Solo che sono costrette a muoversi sempre in una sola direzione e non possono girarsi... - E se desiderano cambiare direzione e vogliono tornare indietro? - Non possono perché se si girano perdono l’equilibrio e cascano giù per il pendio con fatali conseguenze. - E allora sono costrette ad andare sempre avanti? - volle sapere la donna. - Mica detto. Se vogliono tornare indietro camminando, spiccano il volo e vanno a cercare un pendio dalla parte opposta della valle. In parole povere se vogliono andare verso i monti camminano sfruttando i pendii rocciosi che si trovano sulla parte destra della valle; se, invece, vogliono dirigersi verso il mare usano quelli che si trovano sulla parte sinistra. - Mai visto animali simili - disse il turista tirolese.- É sicuro di quello che dice o si sta inventando tutto a beneficio del nostro ragazzino qui presente? Il vecchio battè la pipa sul palmo della mano facendone uscire alcune briciole di tabacco annerito. - Signore, - rispose serio in volto - lei ha mai letto Dante? L’Alighieri? - Si lo conosco abbastanza. - Allora ricorderà un verso del suo poema. Lo scrisse dopo aver visto le tarnagasse quando venne in visita da queste parti. Nell’Inferno Dante, parlando di un’erta scoscesa che stava percorrendo in compagnia di Virgilio e descrivendo come si poteva camminare lungh’essa, dice: “Si che il pie’ fermo era sempre il più basso” per indicare che, per camminare lungo ripidi pendii, l’uomo deve tenere sempre una gamba allungata per reggersi e accorciare, invece, l’altra per poter rimanere in equilibrio. Ebbene, le tarnagasse non hanno bisogno di accorciare una gamba perché ce l’hanno già corta. Evidentemente la citazione dantesca dovette togliere ogni dubbio al turista tirolese. - E perché sono in estinzione e non se ne vedono quasi più? - La caccia e la prelibatezza della loro carne. Un tempo nella valle era famoso il timballo di tarnagasse rosolate nel vino rossese. I buongustai venivano da ogni parte per gustarlo. Questa la causa della loro quasi completa estinzione. - E come si cacciano? - volle sapere Giulio. - Non deve essere facile arrampicarsi lungo le pareti scoscese per catturarle. - Buona domanda, ragazzo. Con le tarnagasse non servono i fucili e neppure le trappole. Basta semplicemente chiamarle dal basso ad alta voce. - Non capisco: perché dal basso? - Vedi, le tarnagasse sono uccelli estremamente curiosi. Come le gazze sono attirate da ciò che luccica, le tarnagasse, invece, sono attratte dal richiamo. Quando se ne vede qualcuna che cammina su un pendio, basta lanciare un grido di richiamo e quella, curiosa per natura, si volta verso il basso, staccando la gamba corta dal terreno e perdendo l’appiglio. Non trovando più dove appoggiarla, la tarnagassa precipita e muore battendo la testa sulle rocce sottostanti. - O bella questa! - fece la donna, infilando la mano nel cestino per calmare il gatto che aveva incominciato a miagolare. - Che peccato non poter più gustare oggi un bel timballo di tarnagassa! - disse con un sospiro il vecchio, guardando attraverso il finestrino, forse alla ricerca di qualche esemplare ancora esistente. - Pazienza! Vuol dire che oggi mi accontenterò di uova in camicia e di piselli ripieni, Me li ha promessi la mia Clelia. Ottima cuoca mia moglie! Anche Giulio guardò fuori. Lui tarnagasse non ne aveva mai viste e, guardando il volto rugoso del vecchio, si chiese se sotto i baffi cespugliosi non aleggiasse un sorriso sornione. Gatti senza baffi e senza orecchie; uccelli con una gamba lunga e una corta! Gli sembravano una bella presa in giro, ma nessuno aveva riso alle parole del vecchio; anzi il turista tirolese lo aveva ascoltato con interesse, specie dopo la citazione dantesca. Che si fosse divertito a prenderli in giro tutti quanti? La voce della donna lo riscosse dai suoi pensieri. - Uova in camicia! E come si cuociono? - E’ semplice. Si prendono le uova e si mettono a bollire per alcuni minuti, poi si sbucciano, si tagliano a fettine e si cospargono di olio e sale. - Ma quelle sono semplici uova sode! - E chi ha detto il contrario. - Lei ha detto uova in camicia: la camicia dov’é? - Non crederà mica che la mia Clelia metta la camicia alle uova, no! Quella la indosso sempre io. Di solito, quando mi metto a tavola, mi tolgo la giacca per cui mangio le uova in camicia. Non è forse così? - spiegò ridendo il vecchio. La donna scoppiò a ridere e così pure il turista. ‘Allora ho ragione io a pensare che quello lì ci ha raccontato un sacco di frottole per prenderci in giro’ - disse Giulio tra sé e sé. - E i piselli ripieni? - Eh no, quelli sono veri. Sulle uova in camicia ho voluto fare una battuta, ma i piselli ripieni la mia Clelia me li cucina veramente. - Piselli ripieni di che? - chiese Giulio. - Come si fa a riempire i piselli. - Una volta che conosci il trucco è semplice, ragazzo. Ti spiego. Tu vai a scuola e qualcosa di botanica ti avranno pur insegnato. Saprai, quindi, che i piselli, il cui nome vero è Pisum sativum, appartengono al gruppo dei dicotiledoni, cioè a quelle piante che hanno il seme diviso in due parti. Se tu apri il seme di un pisello, troverai che l’interno è formato da due semisfere al centro delle quali c’è una minuscola cavità. Ecco, quella è la parte da riempire. - Ma ci sta poco dentro! - Non sono mica ravioli! In quelli ci metti carne e verdura; nei piselli ripieni ci devi mettere qualcosa di particolare e cioè l’olio speziato. La donna ascoltava attentamente. - L’olio speziato - spiegò il vecchio - si ottiene diluendo in un cucchiaio d’olio d’oliva della polvere di paprica, della polvere di noce moscata, di finocchio, di anice, di cumino, di zenzero e un po’ di zafferano. Si ottiene una specie di unguento profumatissimo. Ecco, quello è il ripieno: un ripieno liquido che viene trattenuto dai due emisferi del pisello. - E come si fa a introdurlo nel pisello. - Questo è il segreto. Bisogna usare una siringa per iniezioni con un ago un poco grosso. Si riempie la siringa con l’olio speziato e se inietta una goccia del liquido in ogni pisello. E’ una bontà, ve lo assicuro! - Ma quanto tempo ci vuole per riempire tanti piselli. - Il tempo che occorre. Un buon cuoco sa essere paziente. Son tre giorni che la mia Clelia non fa altro che riempire i piselli. Ciò detto il vecchio si rimise la pipa spenta in bocca e riprese a rosicchiare il cannello. La corriera era intanto giunta nella piazza del paese dove abitavano i nonni e Giulio, salutati i presenti, scese. - Fatto buon viaggio? - gli chiese il nonno che lo stava aspettando. - Ottimo. Un signore anziano ci ha raccontato molte cose interessanti. Guarda, è quello che ti sta salutando dal finestrino. - Il nonno si voltò e rispose al saluto. - Lo conosci, nonno? - E chi non conosce Giacò. Nella valle è quasi un mito. - Ci ha raccontato un mucchio di cose: dei gatti Testatonda, delle tarnagasse delle uova in camicia... - E ci scommetto che vi ha anche parlato della specialità di sua moglie: i piselli ripieni. - Lo sapevi anche tu come si confezionano? - Qui nella valle lo sanno tutti, - rispose il nonno, cominciando a ridere.
Anche zio Remo rise tra sé e sé. Far ridere i suoi lettori era per lui un piacere. Chissà che altro avrebbe potuto o saputo inventare se avesse scelto quel genere per continuare la storia. L’argomento era, comunque, da tener presente.
Genere: Giallo Capitolo primo Furto in economato
Seduto comodamente, Giulio, aspettando con pazienza la partenza della corriera che lo avrebbe portato al paese dei nonni, ripensava agli avvenimenti dell’ultima settimana: la partenza dei genitori, entrambi giornalisti, inviati in missione nel Medio Oriente; il suo momentaneo trasferimento presso i nonni e, soprattutto quanto era accaduto a scuola il giorno prima. L’economo era stato aggredito nel suo ufficio e rapinato di quattro milioni, la somma che aveva appena prelevato dalla banca per far fronte ad alcune scadenze, e il suo migliore amico era stato arrestato con l’accusa di furto. Il tam-tam scolastico, un sistema di voci attraverso il quale si veniva a conoscenza di quanto accadeva nelle varie classi, gli aveva fornito una panoramica generale dell’accaduto. Ma a Giulio non bastava. Figlio di giornalisti, era abituato ad esaminare le notizie e a sondarle fino ad arrivare, per quanto possibile, alle cause che avevano determinato un evento. E poiché si sentiva coinvolto in prima persona (pensava al fermo del suo amico Sandro portato in questura per accertamenti), aveva persino comprato - cosa per lui inusuale - il giornale che riportava l’accaduto. Guardò dal finestrino e, visto l’autista ancora appoggiato al bancone del bar davanti a cui la corriera faceva sosta, si appoggiò allo schienale e apri il giornale sulla pagina della cronaca locale. L’articolo occupava buona parte del foglio. Non accadeva tutti i giorni che avvenisse una aggressione con furto in una scuola media e Brighenti, il cronista locale, un giornalista molto scrupoloso, amico dei suoi genitori, si era sbizzarrito nel riportare puntigliosamente tutti i fatti.
AGGRESSIONE E FURTO A SCUOLA Fermato uno studente
Ventimiglia. Una svolta forse conclusiva hanno assunto le indagini sul grave fatto accaduto presso la Scuola Media’Regina Margherita’. Come abbiamo comunicato nell’edizione di ieri, l’economo GioBatta Papini, al ritorno dalla banca dove aveva prelevato la somma occorrente per pagare alcune fatture arretrate, fu aggredito nel suo ufficio da uno sconosciuto il quale, dopo averlo colpito con un corpo contundente, fuggì dopo essersi impossessato di una busta contenente quattro milioni. A trovare il corpo svenuto dell’economo è stata la bidella. Trasportato all’ospedale in stato di coma non poté rilasciare nessuna dichiarazione alla polizia subito avvertita. Solo nel tardo pomeriggio una studentessa, Simona Allevi, del terzo anno della scuola media, si presentò agli inquirenti. Disse che nel momento dell’aggressione passava per caso nel corridoio dove si trovano tutti gli uffici. Stava per recarsi in segreteria per consegnare un documento. La Allevi solo di recente si è iscritta essendosi i suoi genitori trasferiti da poco nella nostra città. La studentessa si è presentata spontaneamente all’inquirente, il tenente D’Urso della locale sezione di polizia, per fare la deposizione. “Mi trovavo in fondo al lungo corridoio dove ci sono gli uffici e alcune aule, quando ho visto aprirsi una porta. Un ragazzo è balzato fuori e, dopo aver sbattuto l’uscio, si è diretto correndo verso l’altra estremità del corridoio, dove ci sono le scale che portano al pianterreno. “ Ha sentito rumori sospetti? “ No. Ero appena entrata e poi non avrei potuto perché l’ufficio dell’economo si trova oltre la metà corridoio. Mi è, comunque, sembrato strano che uno studente si comportasse in quel modo. Però non erano fatti miei. “ E’ sicura che fosse uno studente? “ E chi altri potrebbe essere in una scuola. “ Poi, che ha fatto? “Io, niente. Mi sono recata in segreteria per consegnare alcuni documenti. Solo dopo che la bidella ha scoperto il corpo svenuto dell’economo, mi sono ricordata di quel ragazzo e ho pensato fosse meglio presentarmi a voi. “ Giusta decisione. Ti ricordi com’era quel ragazzo, che so? il viso, la statura, i vestiti, il modo di camminare... “Era un ragazzo come tanti altri. Non l’ho visto in faccia perché è scappato dalla parte opposta. Posso solo dire che sarà stato alto un metro e settanta, uno e ottanta. Circa il modo di camminare non saprei perché correva. “ Quindi l’hai solo visto di schiena? E com’era vestito. “ Be’ su questo punto sono più sicura: indossava un paio di blue-jeans e un cardigan di color chiaro con un bordino a righe blu tutto intorno al collo, ai polsi e alla parte inferiore del cardigan. Dopo questa deposizione fatta a caldo dalla testimone, il tenente D’Urso ha subito sguinzagliato alcuni agenti col compito di individuare chi, nelle varie classi, indossava un abbigliamento simile a quello descritto. E’ risultato che sei studenti corrispondevano alla descrizione. Dopo aver conferito col questore e avvertite le famiglie, i sei ragazzi sono stati invitati a presentarsi in questura con l’obbligo di indossare gli indumenti che avevano al momento dell’aggressione per un confronto all’americana. Ma, messi di schiena di fronte alla testimone, la Allevi non è riuscita ad individuare il giovane che aveva visto nel corridoio. Solo stamane il colpo di scena. Durante un sopralluogo più accurato nell’ufficio dell’economo, un agente ha trovato sotto la scrivania un bottone dorato. E’ bastato quell’indizio per individuare subito il colpevole. Dopo aver visionato il filmato girato durante il confronto all’americana, il tenente D’Urso notò che al cardigan dello studente S.G. mancava un bottone. Gli altri erano simili a quello trovato nell’ufficio dell’economo. Interrogato a lungo lo studente S.G., di quindici anni, non ha ammesso nulla. Si è limitato a difendersi dicendo che al momento dell’aggressione lui si trovava in palestra, in quel momento deserta, in attesa di una ragazza. “ Quale ragazza? “ Non lo so. Entrando in classe quel mattino ho trovato un biglietto sul mio banco fissato con una puntina da disegno. C’era scritto ‘Ti aspetto alle 9 in palestra. Una che ti ama’ “ E non sai chi è? “ No. “ In palestra è venuta qualche ragazza? “ Non è venuto nessuno. Qualcuno mi ha giocato uno scherzo. Tutti sanno che mi vanto di essere un dongiovanni. “ Ce l’hai ancora il biglietto? “ Sì, eccolo. La polizia non ha ancora chiuso il caso, sebbene tutti gli indizi e la prova del bottone mancante siano contro lo studente. Giulio ripiegò il giornale e rimase pensoso. Non si era nemmeno accorto che la corriera si era messa in moto. Aveva letto l’articolo, ma non l’aveva convinto. Conosceva troppo bene Sandro e non lo riteneva capace di un simile delitto. E poi c’era qualcosa nella sua mente che lo tormentava, anche perché non riusciva a ricordarla. Guardò davanti a sé e vide un giovane seduto. Indossava pure lui un cardigan chiaro, tutto bordato di nero. Un indumento assai comune. La corriera si fermò e il giovane, che evidentemente doveva essere giunto a destinazione, si alzò. Giulio lo vide di schiena. Poi il giovane si girò verso di lui per dirigersi verso l’uscita posteriore. “Ma quello che indossa non è un cardigan” pensò. “E’ un semplice maglione bordato di nero ed è privo di bottoni. Come ha fatto la studentessa ad affermare categoricamente che si trattava di un cardigan se aveva visto solo la schiena del giovane che scappava? Non poteva trattarsi di qualcuno che indossava un semplice maglione?” Per un istante Giulio sentì il volto avvampare. Aveva trovato un appiglio, quello che gli avvocati chiamano un indizio che può far nascere ‘un ragionevole dubbio’. Ma il ricordo del bottone del cardigan di Sandro sul luogo del delitto lo riportò alla realtà. Se Sandro non era il colpevole, chi lo aveva messo sul luogo del delitto? Fu forse lo scossone della corriera che aveva preso una buca a fargli ricordare il particolare sepolto nella sua mente, quel particolare che non voleva venire a galla. Si ricordò all’improvviso di aver notato il giorno prima dell’aggressione che al cardigan dell’amico mancava l’ultimo bottone, quello in basso. Probabilmente Sandro non ci aveva neppure fatto caso perché quando ci si abbottona senza guardare, una volta abbottonato l’ultimo bottone se non se ne trovano altri sotto le dita non si fa alcun caso all’asola rimasta vuota. Giulio si sentì alle stelle. Aveva trovato qualcosa che la polizia ancora non sapeva. Ne avrebbe parlato all’amico di suo padre, il cronista del giornale.
Dopo aver messo il punto a fine capitolo, Zio Remo si congratulò con se stesso.” Come trama per un giallo promette bene - si disse - perché lascia molti interrogativi aperti. Chi è la studentessa che confonde i maglioni con i cardigan? Chi ha inviato il biglietto a Sandro? Come è finito il bottone sotto la scrivania? Chi ce l’ha portato?” Sviluppi promettenti. Ma vediamo ora il genere che stenta a decollare nell’immaginario dei ragazzi.
Genere: Fantascienza
Capitolo primo In volo sulla città
Giunto davanti all’ampio piazzale della Galatick Bank, adibito all’atterraggio degli elicotteri privati e degli elibus, Giulio guardò in alto per vedere se l’elibus di linea era in arrivo. Poche altre persone erano presenti alla fermata sia perché era sabato, sia perché i pochi uffici aperti avevano già ripreso il lavoro e, a quelli ora gli elibus di linea avevano già scaricato impiegati e operai perciò nell’attesa, oltre a lui, c’era solo una bionda tutta fasciata da una grande tuta in fibra acrilica, un ragazzetto che si divertiva a giocare con un apparecchio per videogiochi e una fanciulla con zainetto in spalla che probabilmente andava a trascorrere il fine settimana fuori città, Anche lui andava, come ogni sabato, a trovare i nonni in campagna. Puntuale come al solito l’elibus arrivò e scese lentamente sino a posarsi sulla piattaforma di vetroresina.. Ripartì semivuoto e Giulio ebbe l’opportunità di scegliersi un posto vicino ad un oblò dal quale poteva vedere tutta la città sottostante. Uno scenario che non cessava mai di destare la sua curiosità. Dapprima volse la sua attenzione alle ampie strade con molte corsie dove correvano veloci le macchine spinte da motori solari e guardò i passanti fermi sui marciapiede mobili che li trasportavano fino a destinazione. Ma ciò che più lo affascinava era lo spazio intorno a lui punteggiato da piccoli jet privati, simili a minuscole bolle volanti, da scooters antigravitazionali, da aereotaxi che disegnavano spettacolari traiettorie nel cielo intersecandosi, incrociandosi e sfiorandosi pericolosamente. Pericolosamente fino ad un certo punto perché una specie di airbag speciale fasciava ogni mezzo. Se per caso si scontravano, rimbalzavano lontano uno dall’altro come due palle da bigliardo senza alcun danno a uomini e cose. Giulio aveva letto su un libro che, secoli addietro, esistevano minuscole automobili monoposto, circondate da una spessa corona di caucciù, le quali, procedendo a bassa velocità su una pista di ferro, si urtavano tra di loro con grande divertimento dei guidatori. Nessuno si faceva male come ora non accadeva nulla ai piloti e ai passeggeri, sebbene la velocità fosse talvolta notevole. Gli airbags assorbivano qualsiasi urto. In verità, che non succedesse nulla non era del tutto esatto: infatti, bastava che uno dei due piloti si dimenticasse di inserire il congegno antiurto perché qualcuno ne uscisse con qualche costola ammaccata. Giulio era affascinato da quei velivoli. Gli ricordavano gli oggetti volanti del suo videogame preferito i quali spesso, quando sbagliava nel dirigerli, si scontravano tra di loro, esplodendo in una fiammata. E, talvolta si divertiva a sbagliare volutamente la manovra. - Ma guarda quei due piloti da strapazzo! - mormorò, vedendo un minijet entrare in collisione con un aereotaxi. - Chissà quale dei due ha dimenticato di inserire il comando airbag! Sfortunatamente l’elibus sul quale viaggiava proseguì la sua corsa, impedendogli di vedere i due mezzi volanti rimanere sospesi a mezz’aria in fase di antigravità, e i due piloti, anch’essi con tute antigravitazionali, uscire dalle rispettive cabine, cominciare a discutere standosene anch’essi sospesi nel vuoto per stabilire la colpa e insultarsi a vicenda. Non di rado capitava che venissero a vie di fatto sino al sopraggiungere delle forze di polizia su veloci automotocicli aerei, spinti da potenti razzi a idrogeno liquido. Gli agenti della Spacepolice, oltre a dividere i contendenti, provvedevano ad allontanare i numerosi curiosi che, fermati i loro apparecchi, si ammassavano all’intorno per godersi la scena. Era divertente osservare chi rimaneva coinvolto in un incidente aereo e non di rado capitava che gli spettatori, oltremodo interessati e partecipi, si divertissero ad incitare i contendenti impegnati in un match di boxe spaziale e a scommettere qualche credito su uno dei due. Anche se non l’aveva vista immaginò la scena e sorrise. La ragazza con lo zainetto, seduta davanti a lui, credendo che il sorriso fosse per lei, lo ricambiò. Giulio si sentì a disagio. - Dove vai? - gli chiese. - Dai nonni, come ogni sabato e tu? - All’astroporto, anch’io come ogni sabato. L’astroporto! Il sogno di Giulio. C’era stato una volta sola ed era rimasto affascinato davanti a una fila di razzi pronti per la partenza. Suo nonno l’aveva portato a vedere il traffico aereo e se non l’avesse trascinato via non si sarebbe più mosso di fronte a quello spettacolo. Era impressionante vedere la lunga scia di fuoco che scaturiva dai jet posteriori e ancor più le manovre antigravitazionali, che i razzi in arrivo facevano per riuscire a posarsi dolcemente sulla pista. - Devi partire? - le chiese Giulio. - Purtroppo sì. Tutti i sabati mio padre deve andare sulla stazione polare orbitante e mi vuole con sé. E’ ingegnere astrofisico e si occupa di motori transgravitazionali. Una noia! “Una noia, dice lei!”- pensò Giulio con una punta di invidia. “E pensare che io darei non so che cosa per salire su un razzo!” - Non ti piace viaggiare sui razzi? - Proprio no. Preferirei passare una giornata a terra, in mezzo ad un prato. - Io, invece, sono costretto a passare tutti i sabati e le domeniche nei prati, nella tenuta di mio nonno. Una pizza! Si guardarono e scoppiarono in una risata. - Nessuno è mai contento della sua vita - disse lei. - Peccato non poterci scambiare i ruoli. - Vuol dire che sabato prossimo potremo raccontarci quello che ci è capitato, no? Che ne dici? - propose Giulio. Si scambiarono velocemente gli indirizzi perché l’elibus aveva raggiunto la torre di attracco in prossimità dell’astroporto dove si fermava per una breve sosta. Giulio salutò la ragazza e, attraverso l’oblò, la guardò allontanarsi con un pizzico di invidia. Poi aprì la cupoletta sistemata sopra il suo sedile e guardò verso l’alto. Sopra di lui i due soli che illuminavano e riscaldavano il pianeta rosso brillavano di luce bianca.
Zio Remo rilesse il breve capitolo e si sentì insoddisfatto. Non c’era azione. - Per la verità - borbottò a voce bassa - di fantascienza finora ce n’è ben poca, a parte gli apparecchi volanti, l’antigravità, l’accenno ai razzi e la presenza dei due soli su un pianeta rosso. Ma si può sempre lavorare di fantasia in seguito. La via verso l’infinito e la magia dei razzi col muso puntato verso le stelle l’aveva aperta la ragazza. Bastava seguirla. “Proviamo con un altro genere: la fiaba, ma la fiaba per grandi: la fantasy, una parente della fantascienza.
Genere: Fiaba-Fantasy Capitolo primo Lotta col drago
Da due anni ormai percorreva quella strada, da quando cioè, terminate le elementari, si recava in campagna dai nonni per trascorrervi il fine settimana. Il percorso della corriera dalla città al paese dove la mamma era nata non cambiava mai e lui ormai conosceva ogni punto del percorso, ogni albero, ogni svolta, ogni cascinale. Gli piaceva la calma della campagna, le passeggiate attraverso i boschi, la pesca alle trote nel torrente dove il nonno lo portava spesso. Ciò che, invece, non gradiva era la levataccia del sabato mattino per raggiungere la corriera che partiva alle sette. Quella successiva delle undici non gli conveniva perché accorciava la sua permanenza. E Giulio con i nonni ci stava bene e volentieri. Per cui faceva buon viso a cattivo gioco. Unica consolazione era quella di potersi riaddormentare durante il percorso e di svegliarsi quando la ruvida mano dell’autista, di cui era diventato amico, lo scuoteva per avvertirlo che erano arrivati a destinazione. Una volta seduto comodamente, anche se il sedile era un poco duro e si sentivano le molle, il sonno arrivava subito. In quell’ultima settimana, da quando aveva letto un romanzo sulle avventure di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, del Mago Merlino e della perfida Fata Morgana, non faceva altro che sognare mondi incantati e fatati pieni di mostri, draghi, incantesimi, maghi, perfide regine e principesse rapite. Gli bastava solo chiudere gli occhi e via negli anni bui della storia senza date in cui ogni evento magico e surreale era possibile. Anche quel mattino aveva chiuso gli occhi... e subito si era ritrovato in mezzo ad un’ampia radura, ai piedi di un’alta roccia in cui si apriva una grotta. Proprio lì Martin, un troll suo amico e protettore, aveva visto entrare con fare sospetto Morgana, la perfida maga che, si diceva, avesse sottratto la spada Excalibur custodita nella sala dove si riunivano i Cavalieri di Re Artù per aggiungerla ai tesori che aveva accumulato. E sebbene i sospetti fossero caduti su di lei, Morgana era riuscita a convincere tutti della sua innocenza. Tutti tranne lui, Julius, il cavaliere dall’armatura dorata. Dopo quanto gli aveva detto Martin, era sicuro di trovare la spada insieme ai tesori che Morgana custodiva nella grotta. E a riportarla nella Sala dei Cavalieri ci avrebbe pensato lui. L’armatura dorata per lui e la bardatura per la sua cavalcatura, il fido Nuvola di Fuoco, gliela aveva procurata il troll suo amico, facendola foggiare nella fucina dei Titani. Entrambe avevano la caratteristica di resistere ad ogni attacco, anche il più violento. - Ti servirà, amico - gli aveva detto il troll. - Ne avrai bisogno perché Morgana sa difendersi e ha posto a guardia dei suoi tesori il drago Xiim. Quel mattino anche Martin il troll, ben nascosto in mezzo al bosco, arrampicato su un’alta quercia dalla quale poteva assistere al combattimento, guardava l’amico fermo davanti alla grotta. - Xiim, se non vuoi che venga dentro a prenderti e trascinarti per la coda come un vile coniglio, esci! - Julius aveva lanciato la sfida e ora attendeva. Un brontolio cupo, dapprima sommesso e poi sempre più forte tanto da tramutarsi in un urlo continuo, fu la risposta del drago. Xiim aveva accettato la sfida. E si mostrò. Con la sua mole ostruiva tutta l’apertura della grotta mentre la testa raggiungeva l’estremità della rupe. Sormontata da due corna arricciate, e ricoperta da un carapace che nessuna spada o lancia avrebbe potuto attraversare, fissava dall’alto con i suoi occhi feroci, iniettati di sangue, il suo antagonista. Dalla bocca il mostro saettava una lingua biforcuta che passava e ripassava sui denti quasi a voler pregustare un imminente pasto. Ritto sulle zampe posteriori, tozze e possenti, agitava quelle anteriori, più corte, ma non meno micidiali per gli artigli di cui erano dotate. Le apriva e le chiudeva sul petto quasi a voler invitare il cavaliere ad un mortale abbraccio. Due lunghe ali attaccate alle spalle si agitavano producendo un vento che faceva piegare i rami degli alberi tutto attorno. Nel vederlo Martin il troll cominciò a tremare e con lui tremarono tutte le altre creature del bosco, raccolte ai margini della radura per assistere al combattimento. C’erano i pelosi coboldi, gli elfi, gli gnomi dalla gobba puntuta, i centauri nani, i liocorni, i lutini. Ognuno di loro chi in un modo chi in un altro avevano avuto a che fare con le arti magiche di Morgana e molti dei loro compagni erano caduti sotto gli artigli del drago Xiim. Ora stavano in attesa con la segreta speranza che quel giovane temerario avesse la meglio su quell’orrendo e mostruoso gigante alato che rendeva loro impossibile la vita nel bosco. Julius nel vedere il drago immobile, sicuro di sé, pronto alla lotta, si rese conto della difficoltà del suo compito e dell’impossibilità di poter perforare con la spada quel corpo ricoperto di scaglie più dure dell’acciaio. Ma non se avesse usato la lancia e se la punta di ferro, avesse trovato uno spazio tra di esse. E lo spazio esisteva. Glielo aveva svelato il troll. - Dirigi la punta della tua lancia proprio sotto la gola e cerca di affondare il colpo. Lì scaglie non ce ne sono perché altrimenti il drago non potrebbe piegare la testa in avanti. Punta alla gola, Julius, e avrai successo. Quanto il troll vide il suo amico, per nulla spaventato, spronare, lancia in resta, Nuvola di Fuoco verso il suo avversario e vide la lingua di fuoco che saettò improvvisa dalla bocca del drago, chiuse gli occhi. Ma ciò non gli impedì di udire l’orrendo clangore della corazza di Julius e della bardatura che proteggeva Nuvola di Fuoco quando incontrarono il corpo di Xiim, duro al par di una roccia. Il contraccolpo lasciò Julius tramortito, smarrito per un istante, tanto che cadde a terra.... e si svegliò. Giulio si ritrovò sul pavimento dell’autobus, incastrato tra due sedili, con il suo amico autista che cercava di tirarlo su. - Stai bene, Giulio? - gli chiese premurosamente quando lo ebbe fatto di nuovo sedere sul sedile. - Sì, signor Antonio... ma che è successo? - Il solito pirata della strada. Mi si è parato di fronte all’improvviso con la sua moto ed ho dovuto sterzare contro un muretto. Se mai riesco a mettergli le mani addosso... - Poi dopo aver ancora chiesto al ragazzo se si sentiva bene e averne avuto conferma andò a rassicurarsi che altri passeggeri non avessero riportato ferite. Alcuni volonterosi scesero dall’autobus per dare una mano all’autista e il mezzo, con la parte anteriore ammaccata, riprese il cammino. Per qualche chilometro Giulio ascoltò i commenti di chi gli stava vicino. Poi se ne disinteressò: in fondo si era trattato di un banale incidente, di quelli che ogni giorno avvengono lungo le strade. Per cui ripensò al suo sogno, al duello che era iniziato tra il cavaliere Julius e il drago Xiim. Chissà quale era stato l’esito. La cosa lo incuriosiva e per saperlo c’era un solo modo... riaddormentarsi. E fu quello che fece. Chiuse gli occhi... e il viaggio verso i mondi incantati, verso i regni fatati dove la magia e i sortilegi erano una cosa comune, riprese. I mondi magici riapparvero davanti ai suoi occhi e si ritrovò a fianco di Nuvola di Fuoco.
“Questo genere promette bene e potrebbe essere allettante - pensò Zio Remo. - In fondo le fiabe hanno sempre divertito grandi e piccini: i primi quando le raccontano e i secondi quando le ascoltano. - Zio Remo approvò col capo. - Potrebbe essere un’idea continuare su questa tema.” Ma proviamone anche un altro che va di moda, sebbene produca un po’ di batticuore. Ma si sa: ai ragazzi piace aver paura e prendersi di tanto in tanto qualche bello spavento. Rafforza l’adrenalina nel sangue, sostiene qualcuno. Sarà pure così: io ci credo poco, ma val la pena di tentare anche questo genere.
Genere: Horror
Capitolo primo Una cesta piena
Quando si recava dai nonni, Giulio era solito godersi il paesaggio, anche se la strada percorsa dalla corriera, ormai la conosceva a menadito. Ma lungh’essa c’era un punto che gli era poco congeniale. Era quando l’automezzo costeggiava il muro di un cimitero e si fermava proprio di fronte all’entrata, come un comune carro funebre, per far scendere o salire qualche donna in visita ai suoi defunti. A Giulio la fermata davanti al cimitero decisamente non era mai piaciuta. Il basso muretto che circondava le tombe lasciava vedere dal finestrino dell’autobus lunghe file di lapidi, alcune sontuose, altre meno. In molti casi le tombe erano soltanto contrassegnate da una semplice croce di legno che il tempo, le intemperie e i tarli avevano intaccato. Ma il percorso era quello e lui non poteva certo cambiarlo per cui, volente o nolente, doveva accettarlo. Quel giorno le persone in attesa alla fermata erano poche. Oltre ad una anziana signora con due ceste di insalatina novella, porri, carote e altre verdure che parevano appena colte, c’era solo Sandro, il becchino. Era raro che Sandro prendesse la corriera. Preferiva mandare sua moglie a far compere nel vicino paese. A lui piaceva solo starsene in mezzo ai morti, seguire le cerimonie funebri, scavare le tombe e poi ricoprirle di terra. A Giulio quel mestiere dava una strana impressione e gli ricordava le azioni di un cane rognoso che seppellisse le ossa per poi tirarle fuori a piacere. E di cane rognoso il becchino Sandro aveva pure l’aspetto. Magro, segaligno, era sempre pallido, col viso tirato, gli zigomi sporgenti quasi a voler bucare la pelle flaccida. i capelli lisci che sembravano appiccicati al cranio come se fossero unti con chissà quale grasso. La pelle rugosa, vecchia anzitempo, pareva cascargli di dosso, tanto che Giulio pensò che prima o poi doveva cadere per terra a brandelli. Il becchino, di certo in ossequio ad una nota serie televisiva, era stato soprannominato Mortisio per lo strano odore che aleggiava sempre intorno a lui. Le rare volte che si recava nel paese non parlava con nessuno. Scambiava solo quelle poche parole necessarie per indicare ai commercianti la merce da acquistare e poi se ne ritornava al suo amato camposanto a scavar tombe o a pulire avelli. Forse per questo Mortisio puzzava sempre di morto. Quando l’uomo si sedette davanti a lui, Giulio avvertì subito l’odore, anzi quel mattino sembrava più intenso del solito. Teneva sulle ginocchia un cestino ricoperto da un drappo sulla cui pulizia ci sarebbe stato molto da ridire. A Giulio sarebbe piaciuto cambiar posto, ma non voleva dimostrare la sua diffidenza con un atto di scortesia nei confronti del becchino e poi al suo fianco si era seduta la donna anziana con la sporta piena di verdure. Probabilmente non conosceva il becchino e, dopo aver sistemato le due ceste di verdura su un sedile vuoto, cercò di attaccar discorso tanto per ingannare la noia del tragitto. - Vado al mercato a vendere delle verdure. Ci va pure lei? - chiese indicando con un dito il paniere posato sulle ginocchia dell’uomo. - Humm - grugnì il becchino senza degnarla di uno sguardo. Ma quella, per nulla seccata per la risposta o meglio per la non risposta, proseguì: - Che vende, formaggi? - chiese incuriosita. - Be’, sì, ci sono pure quelli - rispose l’uomo. - E sono in buona compagnia. La donna non si accorse del ghigno, subito represso, apparso sul volto del becchino. Giulio lo vide e rabbrividì. Gli sembrò strano che Mortisio avesse risposto. - Di che si tratta? Gorgonzola o formaggio fermentato? - continuò la donna, incuriosita per l’odore nauseabondo che proveniva dal cesto. - Anche e ci sono pure dei sanguinacci in salamoia. Giulio torse la bocca. Guardò i due, la donna in particolare. Sembrava trovarsi a suo agio, nonostante la puzza proveniente dal cestino D’improvviso, gli venne in mente la lezione tenuta il giorno precedente dal professore di scienze. Si era soffermato a lungo a descrivere il corpo umano utilizzando un manichino di plastica riproducente uno scheletro. L’argomento non era stato dei più divertenti, specie quando aveva parlato della macerazione dei cibi che entrano nello stomaco e a tutte le metamorfosi che subiscono. Guardando il becchino, pensò al modo che costui avrebbe usato per trattare l’argomento. Chi meglio di un becchino poteva sapere qualcosa del corpo umano, dal momento che spesso assisteva alla chiusura delle bare o, preparando fosse per i nuovi defunti, dissotterrava da profonde buche scavate nella terra ossa rotte, femori frantumati, teschi e altro ancora? Qualcuno gli aveva raccontato che talvolta i corpi non fossero ancora decomposti totalmente e la pala, sfondato quanto ancora rimaneva della cassa, assi marcite e maleodoranti, affondava in una melma verdastra brulicante di lunghi vermi biancastri. “Dio che schifo!” - pensò. “Per fortuna che a tenere la lezione sul corpo umano era stato il prof, persona assai simpatica. Comunque, a pensarci bene, se al suo posto ci fosse stato quel becchino, chissà quali sensazioni avrebbe suscitato e quale spasso nell’udire i gridolini di paura e di schifo di alcune sue compagne, schizzinose sì, ma sempre curiose e avide di sensazioni particolari. Comunque Giulio non insistette oltre nella sua visione. L’autobus aveva subito ripreso la sua marcia con una accelerata. Probabilmente anche all’autista la fermata davanti al cimitero garbava poco. Però, a pensarci bene, che c’era di pauroso nel fermarsi di fronte al camposanto? In fondo, i poveri defunti se ne stavano tranquilli all’ombra dei cipressi e sotto le zolle senza disturbare nessuno. Perché averne paura? Giulio, pensando al muro di cinta del cimitero, si chiese: “A che serve un muro? Tanto i morti non possono più uscire e quelli che vivono fuori non hanno nessuna voglia di andarci. E quando gli tocca andarci in una bara, non se ne rendono più conto. Ma guarda tu che strani pensieri mi vengono stamattina!” La mattinata non era peraltro allegra e induceva a pensieri strani e morbosi. Le nubi erano basse e a tratti banchi di nebbia spinti dal vento rendevano la visibilità scarsa. E fu la nebbia la causa principale dell’incidente che accadde poco dopo. Un banco più spesso e caliginoso degli altri invase all’improvviso la carrozzabile e l’autobus tamponò un camioncino che aveva improvvisamente rallentato per la scarsa visibilità. L’urto violento riportò Davide alla realtà. Tutti i viaggiatori furono catapultati in avanti e il cestino cadde dalle ginocchia del becchino sul pavimento, rotolò nel corridoio tra i sedili e sparse tutto attorno il suo contenuto. Quando Giulio si rialzò e guardò in basso, cominciò a urlare. Sul pavimento non c’erano forme di gorgonzola, di pecorino e tanto meno sanguinacci puzzolenti. Davanti a lui stava una testa mozza con il sangue nerastro tutto raggrumato attorno al collo e i capelli impiastricciati di liquame puzzolente. Un occhio, uscito dall’orbita, penzolava all’altezza del naso, ancora attaccato ad un lembo di pelle. L’altro era rotolato poco lontano. Una mano mozza, verdastra, puzzolente, lasciava intravedere brandelli di carne dove pascolavano alcuni vermi biancastri e altri scuri. Ossa di vario tipo con pezzi di carne putrida ancora attaccati erano sparsi all’intorno. L’anziana donna, nel vedere quegli orrori e in particolar modo la testa e gli occhi che davano l’impressione di guardarla, svenne. Giulio si precipitò verso l’autista, sempre urlando. Gli chiese di aprire la porta. Scese di corsa e cominciò a vomitare. Mortisio, da parte sua, con calma, si era messo a raccattare quanto si era sparso a terra, lo aveva risistemato nel cesto e lo aveva di nuovo ricoperto col drappo rosso. Poi si era guardato attorno per gustarsi lo scompiglio che il contenuto del cesto aveva creato. Aveva sulle labbra uno strano sorriso e pareva che col suo atteggiamento dicesse: “Bè, che avete tanto da stupirvi: fossi stato un ortolano come questa signora avrei messo nel cesto cavoli e patate. Io sono un becchino, dunque...”
“Mamma mia che roba! - pensò Zio Remo nel rileggere il pezzo. - Ma possono piacere queste cose ad un ragazzo? Molti dicono di sì: anzi alcuni editori sfornano libri di questo genere in migliaia di copie e i ragazzi li comprano e li leggono avidamente. Che i nostri giovani siano depravati o sono solamente avidi di sensazioni morbose? Mi dispiace per loro, ma difficilmente sceglierò questo genere per il racconto che ho in mente. Comunque, a pensarci un istante: che ci faceva il nostro becchino con quei macabri resti? Dove si recava o a chi li avrebbe consegnati o venduti? A pensarci, l’inizio della storia pone alcuni interrogativi cui varrebbe la pena di rispondere” Zio Remo si guardò attorno e lo sguardo gli cadde su un gruppo di libri di storia perfettamente allineati in uno scaffale. ‘Toh! - si disse - e se provassi con un genere serio come la storia?’ Chiuse gli occhi e si mise a meditare finché non inquadrò la vicenda, o almeno l’inizio di quella che avrebbe potuto diventare una storia interessante.
Genere: Storia
Capitolo primo Uno strano viaggio
Da quando il giorno prima la radio aveva trasmesso la notizia e un certo Badoglio aveva annunciato a tutti gli italiani che l’Italia aveva chiesto l’armistizio agli Angloamericani, suo padre aveva cominciato ad agire e a ragionare in un modo del tutto imprevisto. Mentre in tutto il caseggiato e per le vie della città la gente si riversava per le strade urlando di gioia per la fine della guerra, lui si era messo freneticamente a preparare due valigie, dove aveva riposto vestiti della moglie e del figlio. - Voi due domattina partirete per il paese. Ho già telefonato ai nonni e vi aspettano. - Ma Giovanni, che dici? Ora che la guerra è finita... Suo padre aveva bruscamente interrotto la moglie. Non l’aveva mai fatto. - Lucia, tu e Giulio domattina partirete! E non discutere! - L’ordine era perentorio. - Ma che temi ora! La guerra è finita. - Sua madre non capiva l’atteggiamento di suo padre e non sembrava disposta a cedere facilmente. - Questo lo dici tu, Lucia. Io non ci credo. Sembra finita ma lo sarà solo quando anche i tedeschi chiederanno l’armistizio. Ma quella è gente che non chiede nulla. - E allora? - E allora partirete - aveva concluso perentorio, senza spiegare il suo pensiero. E così, quel mattino, sistemate le valigie sulla reticella, lui e sua madre si trovavano sulla corriera in attesa che partisse. Davanti a loro stavano seduti due giovani i quali volgevano attorno uno sguardo se non spaurito, almeno sospettoso. Entrambi indossavano abiti che davano loro un aspetto goffo in quanto si vedeva subito che non erano della loro misura. Pantaloni troppo larghi, maniche delle giacche lunghe. Uno aveva una camicia di qualche numero più della sua misura; all’altro si vedevano i bottoni tirare la stoffa. Parlottavano a bassa voce tra di loro in un dialetto che Giulio non riusciva a comprendere. Aveva solo intuito che doveva trattarsi di calabrese o giù di lì. Finalmente la corriera si avviò sputacchiando dal tubo di scappamento un fumo denso che subito il vento di mare disperse. Giunti all’altezza del bivio di Nervia dove la strada si biforca in due tronchi, uno per Bordighera e Sanremo e l’altro per percorrere tutta la Val Nervia fino a Buggio, la corriera svoltò a sinistra e cominciò a costeggiare gli orti e le poche serre rimaste lungo le rive del torrente. Ne erano rimaste decisamente poche perché gli ultimi bombardamenti avevano distrutto tutto o quasi. Giulio conosceva a menadito quella strada per averla percorsa sia in corriera sia in bicicletta e il panorama non gli interessava più. Era attratto dai due giovani trasandati i quali, invece, si guardavano attorno con curiosità quasi non avessero mai percorso quella strada. - E’ la prima volta? - chiese sua madre cui non piaceva restare a lungo in silenzio. - Prego, signora? - Domandavo se è la prima volta che percorrete questa strada. - Sì - disse quello che aveva risposto e che sembrava il più disinvolto. - Da poco ci troviamo in queste zone. Il nostro reggimento era di stanza a Ventimiglia, ma dopo l’annuncio di ieri... - Siete militari? - Eravamo. - Non capisco. - Da ieri, dopo l’annuncio di Badoglio in tutte le caserme si è sparsa una sola voce: “Si torna a casa. Tutti a casa e subito”. Noi militari l’abbiamo presa alla lettera e, gettata la divisa, abbiamo indossato abiti civili, quelli che la gente ci ha donato. Giulio capì la ragione di quelle giacche, camicie e pantaloni così strani. - E perché non aveva tenuto le divise? Il giovane guardò il suo compagno che fece spallucce. - Abbiamo dovuto perché si è sparsa la voce che i tedeschi ce l’abbiano con gli italiani e con l’esercito che ha chiesto l’armistizio. Dicono che non ci perdoneranno mai di averli abbandonati. Ecco perché è pericoloso indossare una divisa. C’è il pericolo di essere arrestati e deportati in Germania. - Quindi voi tornate a casa? - No, signora. - Continuo a non capire. - Vedete, signora, le nostre case si trovano in Calabria e non è possibile raggiungerle... - Forse a nuoto - disse l’altro giovane con un sorriso triste. - Non scherzare Toni - lo redarguì. E poi continuando il discorso, spiegò: - Tra noi e le nostre case c’è la linea Gustav, presidiata dai tedeschi. E’ impossibile oltrepassarla senza essere catturati. - E allora dove andate? - Fin dove ci porta la corriera. Là qualcuno ci attende. - E indicò col dito il Monte Toraggio che si intravedeva sullo sfondo. Giulio guardò la madre che, a sua volta, si guardava attorno smarrita. La corriera intanto si avvicinava alle Casermette, una serie di costruzioni che ospitavano alcune compagnie di soldati, costruite dopo Dolceacqua, e con preoccupazione e curiosità il ragazzo osservava uno strano via vai che rallentava la corsa della corriera. Lungo la strada, a destra e a sinistra della carreggiata due lunghe file di carri, carretti, carriole, biciclette o persone a piedi si dirigevano in sensi opposti. Quelli che ritornavano in paese erano carichi, uomini e mezzi, di sacchi, sacchetti, brande, attrezzi, mentre gli altri si spintonavano per arrivare subito chissà dove. - Ma che sta succedendo? - chiese mia madre. - Quello che si temeva - rispose il giovane. - Tutti i soldati hanno abbandonato le caserme. Tutti i locali sono rimasti incustoditi e la gente ne approfitta. - Ma questo è un furto! - Signora, dopo la fame di tutti questi anni, ognuno pensa a se stesso. In fondo si tratta di cose che tutti loro hanno contribuito a pagare. - Ma è pericoloso! Nelle caserme ci sono anche le armi. - Oh quelle per il momento non interessano ancora nessuno. Di certo in seguito... - Come sarebbe a dire? - Sarebbe a dire, signora, - intervenne il giovane che sembrava taciturno, - che la guerra non è finita, anzi, ora ne incomincia una nuova: una guerra a tre. - A tre! - Sì, quella degli italiani contro i tedeschi; quella degli italiani contro gli italiani e quella degli italiani e dei tedeschi contro gli Angloamericani. A passo d’uomo la corriera passò davanti alle Casermette. Lì il caos era indescrivibile. Giulio vide due file ininterrotte di gente, una che entrava con sacchi, gerle, ceste vuote e l’altra che usciva carica di casse di gallette, di sacchi di farina, di pellame, di scarpe, di indumenti, coperte, materassi, brande e altro. Poi la corriera cominciò a lasciarsi alle spalle il caos e riprese a correre più rapidamente, risalendo la strada che portava a Isolabona dove il nonno li attendeva. Lo trovarono in attesa in piazza alla fermata della corriera. Scaricarono le due valigie e, salutati i compagni di viaggio, li seguirono con lo sguardo finché l’automezzo non sparì oltre il Santuario di Nostra Signora delle Grazie. A casa trovarono la nonna intenta a confabulare con un giovane in divisa militare - Che vuole? - chiese il nonno. - Mi ha chiesto se voglio scambiare la sua divisa con qualche abito smesso, Io non so che fare. - Dagli quel vestito che si trova nel baule e aggiungi anche una camicia e una sciarpa di lana, ne avrà bisogno lassù. - E dei suoi vestiti che ne facciamo. - Bruciali. Giulio guardò verso il Toraggio, il monte che sovrastava tutta la valle. In basso c’era Buggio dove si stavano dirigendo i suoi due compagni di viaggio. Chissà se anche quel giovane che barattava la sua divisa era diretto lassù. Sembrava che il nonno lo sapesse.
Zio Remo appoggiò la schiena alla sedia e spostò indietro le spalle muovendole ripetutamente per sciogliere i muscoli rimasti troppo immobili nella stessa posizione. Si stiracchiò e poi fece il riassunto dei generi che aveva scelto per il suo nuovo romanzo. Sette temi iniziati; sette primi capitoli. Potevano bastare per una scelta e come trampolino di lancio. Lo allettava il numero sette cui attribuiva misteriosi significati. Ma sentiva che qualcosa ancora mancava. Sentiva di doverne aggiungere ancora uno, un genere indefinito che potesse abbracciarli tutti e al tempo stesso lasciare la porta aperta ad altri? Però in questo caso non serviva il primo capitolo: occorreva cominciare dalla fine e scrivere l’ultimo. ‘Una buona idea,’ si disse Zio Remo, chinandosi sulla tastiera del computer.
Genere: (non precisato e da definire)
ULTIMO CAPITOLO Nostalgia
Lo scrittore sospirò e ripensò alla sua infanzia. Giulio il ragazzo di cui aveva parlato e di cui aveva raccontato le avventure, il protagonista dell’inizio delle varie storie, molte delle quali in seguito completate, era lui. Alcune delle vicende raccontate erano vere altre frutto dei suoi sogni e delle sue fantasie; altre ancora erano verosimili. Ovviamente non aveva chiamato il protagonista col suo vero nome: Calogero non sarebbe stato in sintonia col personaggio. Molti anni erano trascorsi, ma, tutte quelle vicende non erano mai uscite dalla sua memoria e spesso lo avevano accompagnato, riaffiorando da un lontano passato, come in una specie di flash-back, così lo chiamano gli inglesi. Noi italiani lo chiamiamo poesia dei ricordi (poesia, anche se i fatti sono talvolta poco piacevoli). Si tratta di una parte della vita che riaffiora: sono volti e cose dimenticate, mai perdute perché vengono in mente quando uno meno se l’aspetta. Rammentava la ragazza del racconto di fantascienza, incontrata sull’elibus (per la verità l’aveva incontrata sulla corriera), se ne era improvvisamente innamorato e in seguito le aveva pure scritto una lettera meditata a lungo e scritta con la passione dei quindici anni (ma mai spedita). Il nome? Perso nei meandri della memoria. Chissà dov’era in quel momento. Ormai era diventata una donna e doveva aver dimenticato il compagno di viaggio che l’aveva guardata con occhi sognanti. Probabilmente per lei il suo era rimasto soltanto un volto tra i tanti e forse neppure quello. Una parte dei brani raccontati appartenevano a fatti veri: tranne, ovviamente, quelli di fantascienza e di fantasy, inventati di sana pianta, quello del Cavaliere di re Artù e quello della testa e della mano mozza fuoriusciti dalla cesta del becchino. Mortisio, però, era effettivamente esistito ed era stato il becchino del paese dei suoi nonni. Un uomo per la verità timido, impacciato e servizievole: come quella volta che aveva trasportato nella cesta un coniglio già spellato e una gallinella spennata al parroco del paese. Quando, dopo l’urto della corriera, erano rotolati sul pavimento, non avevano impressionato nessuno. L’incidente con l’autobus, quasi sempre presente in ogni storia, si era verificato una volta sola, ma era stato l’espediente di cui si era servito per legare tra loro i vari brani raccontati. Ora, lo scrittore, barba e capelli bianchi, occhiali con spesse lenti per aiutare gli occhi stanchi, si trovava di nuovo sulla corriera, felice di ripercorrere la strada che conduceva alla vecchia casa dei nonni dove l’attendeva suo figlio, sua nuora e suo nipote. Il percorso non era cambiato: solo le case dei paesi attraversati erano invecchiate e qualche negozio non c’era più. La piazza in cui il toro Pablito si era esibito in una spettacolare corrida era rimasto uguale. Uguale il paesaggio in cui il vecchio burlone si era divertito a introdurvi uccelli immaginari come le tarnagasse, i gatti Testatonda senza orecchie e senza baffi o a immaginare contorni favolosi di piselli ripieni. Luoghi ideali dove altri ragazzi con un po’ di immaginazione avrebbero potuto dar libero sfogo alla fantasia per vivere altre avventure mozzafiato, da brivido o per assaporare momenti di gioia e di piacere. Tra tutti quei primi capitoli ne aveva scelto uno: l’ultimo, per diverse ragioni. Prima di tutte perché aveva vissuto sulla sua pelle quei due lunghi anni dopo l’armistizio e poi perché i ragazzi come suo nipote dovevano sapere. Scese sulla piazza del paese, aspettò che la corriera si perdesse in fondo alla strada e poi si avviò verso la casa dei nonni dove era atteso. Mentre camminava udì il rumore di un tamponamento. ‘Un incidente come quello delle mie storie’, pensò, ma non si prese la briga di voltarsi.
“LA POULE A’ L’OEUF D’OR”
A chi le chiedeva perché avesse voluto battezzare la sua rinomata salumeria intitolandola ad una gallina, sia pure capace di deporre uova d’oro,, mettendo sopra l’ingresso una vistosa insegna con la scritta in francese e un ancor più vistoso disegno di una gallina intenta a deporre un grosso uovo col guscio di color giallo, la signora Maria rispondeva: “Perché il francese dà un tono al mio negozio e perché sin da quando me l’hanno raccontato da bambina, ho sempre desiderato avere una gallina che facesse le uova d’oro”. Una gallina simile non l’aveva mai posseduta, ma un negozio bene avviato sì e i prosciutti, i salami, il formaggio e tutto il resto, l’oro glielo fornivano quotidianamente attraverso i numerosi clienti. Madame Marì, come da anni veniva chiamata nel quartiere, era un donnone il cui peso corporeo era più vicino ai cento che ai novanta chili. Piccola di statura, aveva braccia e gambe simili alle forme di prosciutto e di mortadella esposte in vetrina o penzolanti dai ganci fissati nel soffitto; la pelle era rosea come quella dei porcellini e il volto, eternamente sorridente, aveva due guance così soffici e grasse da invogliare chiunque a stringerle tra l’indice e il pollice e a tirarle per farle ganascino. Il petto prorompente, di certo non gonfiato con silicone, ballonzolava quando rideva e ancor più quando si chinava a tagliare lardo e prosciutto o a prendere con delicatezza le uova di giornata per avvolgerle in fogli di giornale. - Beata lei, Madame Marì, il sole le sorride anche quando è nuvolo – le diceva qualche cliente. E lei gli rifilava un sorriso, il pacchetto con gli acquisti e la ricevuta fiscale… quando non la dimenticava. Tra i suoi clienti più affezionati, almeno per nove mesi all’anno, c’erano tutti gli studenti della vicina scuola media. Puntualmente si presentavano ogni giorno o prima che iniziassero le lezioni, oppure durante l’intervallo mattutino per farsi fare un panino al prosciutto o alla mortadella o al salame. - Madame Marì, pan carré con prosciutto, per favore! - A me un tramezzino al formaggio. Più formaggio che tramezzino, Madame Marì. - Please, miss Mary, for me un hot dog! – chiedeva qualche ragazzino in vena di sfoggiare le sue conoscenze linguistiche. - Ma parla come mangi, figlio mio, - rispondeva. – E vorrei che qualcuno mi spiegasse perché gli americani hanno chiamato un panino farcito hot dog, cane caldo! Non l’ho mai capito. Fossero cinesi! Almeno quelli i cani li mangiano davvero. Talvolta era lei stessa a prendere in giro i suoi giovani clienti. - Madame Marì, vorrei un bel panino con la coppa. - Perchè, hai vinto una gara di corsa? – E giù una bella risata. Accadeva talvolta che fossero i clienti ad avere la battuta giusta. - Madame Marì, mi dà un bel panino con la marmellata? - La vuoi con marmellata Arrigoni? - No, questa mattina ho un po’ di mal di pancia: non la voglio ‘A rigoni’, me la dia in ‘tinta unita’. La pregiata salumeria di Madame Marì era diventata un punto di ritrovo dove non ci si annoiava mai. Quel mattino, forse per la pioggia battente, i clienti non erano numerosi e i pochi presenti, temendo di bagnarsi oltre il lecito, se ne stavano a parlottare con la padrona o tra di loro anche dopo aver effettuato tutte le spese. - Signor Verdini, come sta suo figlio? Ho saputo che la settimana scorsa è caduto dalla motocicletta. Sta bene? – chiese Madame Marì, rivolgendosi ad un cliente che da anni veniva nel suo negozio. - Per bene sta bene. Si lamenta solo di non poter mangiare. Nella caduta ha strisciato tutto il viso sull’asfalto e si è malamente sfigurato la bocca e il naso. Hanno dovuto fasciargli tutta la testa. Sembra una mummia; gli si vedono solo gli occhi. - Che peccato! Chissà come sarà dispiaciuto il suo Ciro! Gli piacevano tanto i tramezzini al prosciutto e i bigné! - Effettivamente essere nutriti con fleboclisi per via endovenosa non deve essere divertente, - osservò una signora. - Che dice! – ribatté il signor Verdini, - oggi quel sistema non si usa più. - Ah no? E come fanno a nutrirlo?- si informò la signora. Evidentemente non conosceva il signor Verdini e la sua fama di scherzare su tutto e su tutti, in quel caso anche sull’incidente del figlio. - Si tratta di un nuovo metodo venuto dall’America: si chiama ‘alimentazione per enteroclisi analetica’. - E in che consiste? - E’ molto semplice: si somministrano i cibi, purché siano liquidi, tipo minestrine in brodo, latte, caffè, tè, per via anale, mediante clistere… La donna lo guardò stupita. - Per clistere! - Per clistere. Solo che mio figlio si lamenta sempre: dice di non sentire alcun gusto. E giù una bella risata collettiva, di fronte alla faccia seccata della donna presa in giro. Ma poi rise pure lei. Il suono del telefono smorzò le risate, mentre Madame Marì si apprestava a rispondere - Parlo con Madame Marì della salumeria “La poule à l’oeuf d’or”? - Sì, questa è la salumeria “La poule à l’oeuf d’or”. Sono la padrona, mi dica. - Vorrei sapere se vendete anche delle uova. - Certo che vendiamo uova, se no perché avrei dato quel nome al mio negozio! - Ed è proprio per questo che l’ho scelto. Vede, Madame Marì, io ho uno zio anziano al quale tengo assai e che curo come un bambino. Giorni fa si è preso il raffreddore del fieno e il dottore gli ha consigliato di sorbirsi ogni giorno tre uova purché siano fresche. Io sto, appunto, cercando delle uova fresche. Mi assicura che le sue lo siano? Vede, l’albume delle uova, dopo due giorni, perde la transamminasi… - Perde cosa? - La transamminasi. Non mi chieda che cos’è perché non lo so. Il dottore ha detto così: ecco perché io desidero delle uova molto fresche, freschissime anzi. Le ha? - Certo che le ho. Tutte le dozzine che desidera. Io non compero le uova all’ingrosso. Ho un pollaio fuori città da cui mi fornisco ogni mattina. Glielo posso mettere per iscritto: la mie uova sono di giornata. Si fidi. Suo zio avrà tutta la transamasi… transamminasi che la sua febbre richiede. Quanto gliene metto da parte? - Allora posso star sicuro che siano freschissime? - Di giornata – ripeté un poco seccata Madame Marì cui quella telefonata cominciava a pesare. - Bene, allora, Madame Marì, mi ascolti attentamente: scelga l’uovo più grosso che ha in negozio, l’afferri delicatamente tra l’indice e il pollice e poi, sempre con estrema delicatezza e con movimento rotatorio se lo infili nel deretano passando in mezzo ai glutei. – Alle parole seguì una interminabile, grassa risata. Non appena la salumiera realizzò il concetto di quanto il suo interlocutore aveva detto, diventò rossa come un peperone e cominciò ad inveire: - Villano, maleducato, sporcaccione, disgraziato, deficiente… Dall’altra parte della linea l’ignoto interlocutore continuò a ridere sguaiatamente e poi riattaccò. - Che le succede, Madame Marì, - chiese premurosamente il signor Verdini, vedendola paonazza in viso e sul punto di farsi venire un colpo apoplettico. – Si calmi! E ci racconti. Noi abbiamo solo sentito le sue risposte e, da quanto mi è parso di capire, qualcuno le ha chiesto delle uova fresche. Perché se la prende tanto? - Perché me la prendo! Ma perché quel disgraziato farabutto mi ha preso in giro, divertendosi alle mie spalle. Ha insistito per avere delle uova fresche, freschissime, di giornata; mi ha parlato di un suo zio ammalato, della transa…, non mi ricordo più cosa, del medico e quando gli ho chiesto quante uova voleva, mi ha risposto di prenderne una e di ficcarmela… Sì, ecco, proprio dove pensa lei. - Mio dio che gente volgare c’è a questo mondo! E non ha capito dalla voce chi possa averle fatto lo scherzo? - No. Poteva esser un uomo come una donna. Dalla voce non l’ho capito. - E ora che fa? - Che faccio? Seguo il suo consiglio: adesso prendo un bell’uovo tra il pollice e l’indice e invece di mettermelo dove lui mi ha detto, lo picchio leggermente sul bancone e me lo ciuccio. Così, signor Verdini, diversamente da suo figlio, io il gusto lo sentirò. Eseguì, si sorbì un uovo e poi concluse l’episodio con una bella risata. In fondo si era trattato solo di uno scherzo, seppure un poco volgare Di fuori la pioggia infuriava e nessuno se la sentiva di affrontarla per cui i discorsi si incentrarono su scherzi che qualcuno dei presenti aveva subito. E il tempo passò piacevolmente. All’improvviso il telefono squillò di nuovo e tutti si voltarono verso l’apparecchio. Madame Marì lo guardò con sospetto, poi, pensando si trattasse di un cliente vero, alzò la cornetta. - Pronto? Parlo con la salumeria di Via Costanzi? - Sì, signore. - Potrei parlare con la padrona? - Sono io, per servirla. Con chi parlo? - Sono un agente… - Oh mio Dio! – lo interruppe la salumiera – sarà mica della Finanza? Un suo collega è già venuto la settimana scorsa e ha trovato tutto in regola. - Si rassicuri, signora, non sono della Finanza. Sono il brigadiere Imposimato della locale Caserma dei Carabinieri. - L’ascolto, brigadiere. - Le spiego subito la ragione della mia telefonata. Da una serie di denunce presentate da diversi commercianti di questa zona, ci risulta che qualche male intenzionato si diverte ad effettuare per puro divertimento delle telefonate anonime, talvolta anche volgari. Poiché il fatto si ripete ormai quotidianamente, nell’intento di scoprire il colpevole, la Tenenza dei Carabinieri, d’accordo con la Centrale Telefonica della SIP, ha messo in atto una serie di controlli di apparecchi a rischio, tra cui quello del suo negozio. Ebbene ci è stato poco fa comunicato che al numero del suo apparecchio telefonico è stata effettuata una telefonata anonima…. - Sì, è vero! – lo interruppe Madame Marì cui, nonostante avesse fatto buon viso a cattivo gioco, era rimasta con la rabbia in corpo. - Ecco, signora, vorrei sapere se, come i suoi colleghi commercianti, lei intende sporgere denuncia - Lo voglio, ma non so contro chi. - Contro ignoti. - D’accordo, brigadiere. Però non mi è possibile venire nel suo ufficio perché il mio negozio rimane aperto tutto il giorno, tranne una breve pausa per il pranzo. - Per questo non c’è problema: io sono autorizzato a raccogliere le denunce anche per telefono. Le trascrivo, stendo il verbale e poi un nostro agente passa nel suo negozio per farglielo firmare. - Quand’è così, mi dica che cosa debbo fare. - Solo rispondere alle mie domande. Dunque, lei come si chiama? - Sono la signora Marianna De Dominici, meglio conosciuta nel quartiere come Madame Marì. - Nata? - A Cuneo. - Quando? - Vuol proprio saperlo? – chiese la salumiera. Non ci teneva a dire l’età specialmente in presenza dei clienti. Poi, abbassando la voce, sussurrò: il sei aprile del trentacinque. - Mi dica la ragione sociale, sì, be’ , il nome della sua salumeria. - La Poule à l’oeuf d’or – rispose parlando in perfetto francese. - Non poteva usare un nome italiano! – si lamentò il brigadiere. Forse non conosceva il francese. - Sa com’è! La pubblicità ha le sue esigenze e un nome straniero fa sempre colpo. - Farà colpo ma mi mette in difficoltà nello scrivere. Sia gentile signora, me lo compiti parola per parola. Madame Marì avrebbe fatto volentieri a meno di perdere tempo al telefono. Essendo però i clienti pochi e avendoli già serviti, cominciò sospirando, a compitare. - Brigadiere, scriva le lettere P come Padova, O come Otranto, U come Udine, L come Livorno, E come Empoli. Si pronuncia ‘pule’. Questa è la prima parola. La seconda è A come Ascoli, poi uno spazio. L come Livorno, poi un apostrofo, OE attaccati… - Come attaccati! – chiese il brigadiere. - Appiccicati, incollati, stretti l’uno all’altro come due innamorati che si baciano. I francesi scrivono così. - E come si legge? - Ha presente il muggito di una mucca? Ecco si legge così, come se fosse un suono compreso tra la U e la O. - Sarà come dice lei! Io scrivo poi lei firmerà la sua deposizione e se ho sbagliato correggerà. Continui. - Dopo OE attaccati metta una U come Udine e una F come Firenze. L’ultima parola è composta da una D come Domodossola, apostrofata, poi una O e infine una R come Roma. Ha scritto? - Sì, adesso mi racconti la sua conversazione con l’anonimo. - E’ presto detto: quell’individuo mi ha chiesto se vendevo della uova e se le mie uova erano fresche. Ho risposto di sì. Lui mi ha spiegato che le uova non servivano a lui, ma erano per un suo zio colpito dalla febbre del fieno… - E’ proprio sicura che abbia detto ‘febbre del fieno’? - Sì, sono sicura. - E non si è insospettita? La febbre da fieno non è una malattia invernale! Non si manifesta in questa stagione. - Ora che mi ci fa pensare, è vero! Doveva venirmi il sospetto tanto più che non ho mai sentito che la febbre del fieno si curi con le uova fresche. - Per la verità, - disse il brigadiere – l’albume serve a far calare la trasamminasi. - L’ha pure detto quel mascalzone. Ha parlato di quella cosa lì, la transamasi come dice lei. Mi spiega cos’è? - E’ una cosa lunga, signora. Lasci perdere e continui - C’è poco da aggiungere. Quel mascalzone ha continuato ad insistere sulla freschezza delle uova. Io gli ho detto che le mie erano di giornata e di mia produzione… - Perché, lei fa le uova? - Brigadiere, che dice! – sbottò la corpulenta salumiera, scoppiando a ridere. - Mi scusi, signora, intendevo chiedere se lei ha un allevamento privato di galline. - Sì, ho un grosso allevamento e produco uova, cioè le producono le galline – precisò Madame Marì. - Concluda, signora, - Ecco, quando ci siamo messi d’accordo sulla freschezza delle mie uova, gli ho chiesto quante gliene dovevo mettere da parte e lui mi ha risposto… - La prego, signora, - la interruppe il brigadiere – sia precisa su questo punto e mi riferisca tutte le parole dell’anonimo interlocutore. - Cercherò di ricordarmi. Mi ha detto: “Se sono fresche come dice, scelga l’uovo più grosso, l’afferri delicatamente tra l’indice e il pollice e, sempre con estrema delicatezza se lo ficchi nel deretano, passando in mezzo ai glutei. Dall’altra parte del telefono ci fu una lunga pausa tanto che la salumiera disse: - E’ ancora lì, brigadiere? - Sì, signora, sono sempre all’apparecchio. Stavo pensando alle sue parole perché quello che mi ha comunicato è di grande importanza. - Io non la vedo. - Ma la vedo io! Sino ad oggi abbiamo cercato il colpevole nel luogo sbagliato. Credevamo che fosse un individuo volgare e ignorante e abbiamo svolto indagini tra i delinquenti comuni. Invece si tratta di un individuo, volgare sì, ma istruito. Come minimo deve aver frequentato le scuole superiori. - Come fa a dirlo? - E’ semplice! Ha usato la parola ‘transamminasi’ che pochi conoscono. Parlandole di dove mettere l’uovo, non le ha detto, come sarebbe stato logico per una persona ignorante: “se lo ficchi nel…” - Ho capito, brigadiere! - Ha detto ‘nel deretano’, passando tra i ‘glutei’. Un ignorante non avrebbe usato le parole ‘deretano e glutei’. Ne esistono altre assai più volgari. - Ho afferrato il suo ragionamento, brigadiere. - Bene, allora concludiamo. Prima di battere a macchina il verbale mi preme sapere ancora una cosa: l’ora della telefonata. - Questa posso dirgliela con sicurezza perché appena ho riappeso il microfono ho guardato l’orologio. Erano le diedi e dodici. - Dieci e dodici, - ripeté il brigadiere. – Adesso sono le dieci e trenta. Sono passati esattamente diciotto minuti. Quindi, considerando che la temperatura media del corpo umano si aggira dai trentasette ai trentotto gradi, che il tempo di diciotto minuti, come precisato nei più accreditati testi di culinaria, è largamente sufficiente, io la consiglierei, Madame Marì, di usare delicatamente il pollice e l’indice della mano destra, di afferrare, sempre con estrema delicatezza, l’uovo, di estrarlo dal deretano e, passando tra i glutei, di soppesarlo attentamente. SI ACCORGERA’ CHE ADESSO E’ SODO. – E seguì una lunga sarcastica risata. Madame Marì, padrona della pregiata salumeria “La poule à l’oeuf d’or”, lasciò cadere il microfono, si accasciò a sedere su una seggiola e, inebetita, si voltò a guardare i clienti con occhi stralunati. Fuori continuava a diluviare.
Potrei cominciare con "C'era una volta...", ma la formula è troppo abusata, per cui sarebbe opportuno cercarne una nuova, tanto più che il tempo in cui vive il gatto di cui vi voglio raccontare la storia è molto lontano da quello in cui Perrault ambientò il suo racconto. Il Castello di Carabas non c'è più e non esistono neppure discendenti del famoso Marchese di Carabas, dell'orco, del Re e di sua figlia... perché di questi tempi re, principesse e marchesi scarseggiano. Gli orchi poi (almeno quelli di tipo antico) sono spariti. E' per questa ragione che ho scelto una formula più legata al presente per raccontarvi la storia di un giovane e del suo gatto.
Viveva qualche anno fa a Genova un anziano pensionato, padre di tre figli e padrone (si fa per dire) di un bel gattone dal pelo rosso di nome Igor, che aveva l'abitudine di dormire tutto il giorno, tranne il tempo che dedicava alla caccia dei topi, quello destinato ai pasti quotidiani (perché lui i topi li cacciava ma non li mangiava) e quello indispensabile per pulirsi e lisciarsi il pelo con misurate e sapienti leccatine. L'anziano pensionato, molti anni prima, quando era stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, fatto innumerevoli calcoli sulla consistenza della sua liquidazione, della sua pensione e su quanto aveva risparmiato durante gli anni di lavoro, si era reso conto che non avrebbe mai potuto comprare una casa per sè, per i suoi figli e per Igor, per cui aveva ripiegato sull'acquisto di una roulotte e di una vecchia, asmatica Fiat che aveva però ancora la forza di trascinare la sua carcassa semi arrugginita e una roulotte, seppure per brevi tratti. C'era sì da pensare al costo della benzina che aumentava di continuo, all'olio che si consumava rapidamente nei cilindri quasi si trovasse in una padella per friggere, alle pastiglie dei freni, che in una città a saliscendi come Genova si squagliavano come gelati al sole, e poi c'era ancora il bollo della circolazione e il costo della patente. Ma, a conti fatti, erano ben poca cosa in confronto ad un affitto mensile e poi erano costi che incidevano solo marginalmente sul bilancio familiare perché l'anziano pensionato non aveva acquistato la roulotte per scorrazzare su e giù per la penisola in cerca di posti nuovi. Genova col suo mare e le colline alle spalle era troppo bella per allontanarsene. E il tempo per lui, i suoi figli e il gatto era trascorso piacevolmente. D'estate portava la sua casa su ruote sulle alture circostanti, in posti ombreggiati, dove si poteva respirare un po' d'aria fresca, pulita e godere di un panorama superbo sulla città sottostante, sul porto e sul mare che ai raggi del sole lameggiava come una lastra d'argento. Seduto su una sdraio, a fianco della roulotte, con una bottiglia di vinello leggero immersa in un secchio pieno d'acqua attinta da qualche vicina sorgente, centellinava lentamente il suo bicchiere di vino, assaporandolo piano piano. E, intanto, guardava i tetti di ardesia della città e si divertiva a cercare i palazzi dove aveva lavorato per anni, chino su una scrivania piena di scartoffie o davanti a una macchina per scrivere e sorrideva. Sorrideva senza cattiveria, pensando ai suoi ex colleghi, sudati, che faticavano davanti alle nuove macchine, a quei computer che si diceva facessero male agli occhi. D'inverno andava a parcheggiare in spazi aperti, vicino alla spiaggia o su promontori dove la strada finiva con qualche piazzola spaziosa, in zone che, sebbene battute dal vento, erano pur sempre esposte per tutta la giornata ai raggi del sole che provvedeva a riscaldare l'interno della roulotte. Di notte bastava avvolgersi nelle coperte e lasciarsi cullare dalle onde che frusciavano sulla spiaggia o dal sordo rumore dei marosi che battevano contro gli scogli quando il mare era in tempesta. Il mare infuriato era uno spettacolo stupendo, terribile e affascinante al tempo stesso. Si vedevano i marosi innevati rincorrersi l'un l'altro e, simili a galletti rissosi, alzare la cresta in prossimità della riva per poi avventarsi con furia spaventosa verso la scogliera, quasi a volerla distruggere. Ma non ci riuscivano mai o forse ci sarebbero riusciti dopo anni di rabbia furibonda. Si disintegravano, invece, in una specie di bianca parete argentea, tutta spruzzi e bollicine, che, dopo essersi levata verso il cielo, ricadeva sugli scogli inondandoli per ampio tratto di schiuma biancastra. Ma non sempre il mare era infuriato. C'erano delle giornate invernali piene di sole in cui era piacevole guardare il blu che si fondeva con l'orizzonte e i raggi del sole che facevano sfavillare l'ampia distesa quasi fosse una lastra di metallo lucente. In fondo per l'anziano pensionato la vita non era affatto triste, anzi scorreva piacevole, specie quando se ne andava a pesca sugli scogli con una canna da lui costruita con dei flessibili bambù colti in un giardino. Chi in quei momenti non l'abbandonava mai era Igor, che lo seguiva passo passo sia per affetto e sia per interesse. Ai figli la pesca non piaceva e poi tutti e tre avevano altro a cui pensare e non avevano certo il tempo, come solevano dire al padre quando li invitava a seguirli, di "insegnare il nuoto ai vermi appesi all'amo". E inoltre non volevano far parte di quella schiera di persone citata in un proverbio ligure che recita: "Pescaù de cana, cacciaù de viscu e purtaù de Cristu i sun i trei ciù belinùi che g'ha au mundu" e che tradotto significa: chi pesca con la canna o va a caccia usando il vischio o nelle processioni religiose porta il Crocifisso non è altro che un babbeo ed essere un babbeo o 'un belinùn' come dicono a Genova, non piace a nessuno. Il vecchio pensionato, per la verità, sapeva che chi la pensava a quel modo erano persone che non apprezzavano la tranquillità di una giornata passata in riva al mare, in piena solitudine e meditazione. Igor, dopo che il vecchio si era sistemato sul suo scoglio preferito, con la pastura da gettare ai pesci da una parte e le esche vive dall'altra, gli si metteva al fianco e chiudeva gli occhi per dormire. Per la verità in quei momenti dormiva con un occhio solo. L'altro lo teneva sempre aperto e pronto a cogliere l'argenteo luccichìo del pesce quando, appeso all'amo, usciva dal mare. Solo allora se ne usciva dal suo abituale torpore e, svegliandosi di colpo, era subito pronto a chiedere al padrone con voce miagolante: - Dai, padron mio, buttalo qui! Mi sento un tale languorino allo stomaco! - Igor, sei il solito ingordo, - lo rimproverava quello. Ma poi il pesce glielo dava lo stesso. Nei giorni in cui il mare era agitato, il vecchio si divertiva con altri pensionati a giocare a bocce su un terreno che avevano liberato dalle erbacce e che avevano lisciato alla perfezione, togliendo persino le pietruzze più minuscole per impedire che deviassero le bocce lanciate verso il pallino. Igor, non appena gli vedeva prendere le bocce dal bagagliaio della Fiat, gli si affiancava, lo seguiva come un cagnolino e rimaneva ai margini del campetto in attesa che toccasse al suo padrone accostare la boccia al pallino. Lo guardava mentre la lanciava con perizia e, vedendola rotolare, la seguiva per gioco, allungandole qualche zampata per farla deviare dalla traiettoria con grande gioia degli avversari e col disappunto del vecchio pensionato. - Igor, figlio degenere d'una gatta pazza! - gridava inseguendolo. - Possibile che ti diano fastidio solo le mie bocce? - Poi gli correva dietro, ma il gatto con un balzo si rifugiava su un muretto e si sedeva a guardare, incurante della rabbia del padrone, una rabbia che subito sbolliva e permetteva al gatto di riprendere la sua attività di disturbo. - I figli del pensionato vivevano col padre nella roulotte e se anche ci stavano un poco stretti, non si lamentavano affatto perché nessuno chiedeva loro di pagare la pigione. Era solo sufficiente che si preoccupassero di conservare in buono stato la casa mobile. - L'ambiente era limitato e i confort erano quelli che erano, ma in una città in cui è difficile trovare alloggi o quando si trovano bisogna pagarli a peso d'oro, sapere di avere un tetto sopra la testa è già una benedizione. Eppoi nessuno di loro aveva intenzione di invitar amici e se ne capitava qualcuno si faceva in fretta a tirar fuori un tavolino pieghevole e le sedie per far quattro chiacchiere all'aperto o per giocare a carte. Se poi il tempo era nuvolo e minacciava pioggia, con tutti i bar che si trovavano lì vicino, non c'era che l'imbarazzo della scelta. Unica preoccupazione dei tre fratelli era quella di intervenire nel lavori di pulizia della loro casa ambulante, rabberciando i malanni che il tempo e l'usura dovuta alla salsedine provocavano. E poi c'era anche la vecchia Fiat a cui pensare. I compiti erano stati equamente divisi. Al primogenito toccava il compito di occuparsi della roulotte: provvedeva a lavarla esternamente, a togliere la ruggine, a riverniciarla, a pulire l'interno. Il secondogenito, maniaco di motori - lavorava saltuariamente in una officina meccanica - si occupava della Fiat, facendo in modo che il motore fosse sempre in buono stato e funzionante, che la batteria fosse carica, che non mancasse l'olio, l'acqua e la benzina. Il più giovane faceva le commissioni e si occupava di Igor, spazzolandogli il lungo e morbido pelo affinché non lo seminasse per tutta la roulotte o nell'auto. Talvolta il gatto dormiva sul tetto della Fiat, ma per lo più preferiva i cuscini della roulotte e il sedile posteriore della macchina. Igor aveva l'abitudine di farsi gli unghioli affondandoli dove capitava. Il suo padrone gli aveva sistemato in un angolo una tavoletta di legno dolce su cui avrebbe potuto arrotarseli senza fatica. Ma si sa, i gatti fanno sempre quello che vogliono loro e Igor era un gatto di primordine perciò le unghie le affondava dove gli pareva, con preferenza nei cuscini e nelle poltrone, nel dorso dei pochi libri sistemati in un basso scaffale e nelle gambe di un tavolino che recavano i segni di profondi solchi sempre di fresca data. Se avesse potuto se li sarebbe anche fatti sul tetto della roulotte, ma per sua sfortuna quello non era di legno. Gli anni passarono lentamente e un giorno il vecchio pensionato se ne andò. La morte lo colse benignamente mentre stava seduto su uno scoglio a pescare e si addormentò per sempre con la canna in mano. Nessuno se ne accorse: solo Igor gli tirò i pantaloni per avvertirlo che il galleggiante era andato sott'acqua e che qualche pesce aveva abboccato. Ma al vecchio ormai non gliene importava più di tanto. Il gatto era rimasto a lungo a guardarlo. Non capiva perché se ne stesse immobile a guardare l'orizzonte. 'Forse pensa troppo', si disse e cominciò a miagolare per attirare la sua attenzione. Gli leccò persino la mano che reggeva la canna, ma le dita non si mossero e la canna rimase rigida. Solo la punta sottile e flessibile si piegava verso il basso, tirata dal pesce che aveva abboccato. Il suo strano gniaulìo attirò l'attenzione di alcuni pescatori seduti poco lontano e di altri che rattoppavano le reti. Si misero a chiamare per nome il vecchio, poi si avvicinarono e subito capirono quello che era avvenuto. Si formò un capannello di gente. Qualcuno andò ad avvertire i figli. Dopo un bel funerale non rimase altro ai tre fratelli che dividersi l'eredità del vecchio e andarsene ognuno per la sua strada. Non ci fu bisogno di alcun notaio. I pochi soldi vennero divisi in parti uguali. Al figlio più grande toccò la roulotte che aveva curato per tutti quegli anni; il secondo si prese la Fiat, sua di diritto per averla curata da sempre, e al cadetto toccò Igor. Ben poca cosa in verità. Per un giovane senza lavoro e senza casa e ancor più senza né arte ne parte, ricevere un animale in dote è poco più di niente e per di più un impiccio, anche se si tratta di un gatto capace di tirarsi da solo fuori dai guai e di cavarsela in ogni situazione. Abbandonarlo a se stesso? Nemmeno a pensarci: Igor era uno della famiglia e per il giovane era un compagno insostituibile, un amico sincero con cui parlare e a cui confidare tutte le proprie disgrazie. - E adesso che si fa? - gli chiese il giovane, vedendo i suoi fratelli allontanarsi assieme, uno al volante della Fiat e l'altro dentro la roulotte. - Siamo rimasti soli, amico mio. E soli si trovavano in quell'ampio piazzale rimasto vuoto, di fonte a un mare increspato. - Mai perdersi d'animo e mai gettare la spugna! - gli rispose il gattone rosso. E il giovane lo guardò stupito. - Chi ti ha insegnato la frase 'gettare la spugna'? - L'ho sentita in TV mentre due pugili si davano botte da orbi. - Hai ragione, Igor, non la getteremo. Con i soldi dell'eredità Igor e il suo padrone vissero qualche mese in una modesta pensioncina, vicino al porto, risparmiando più che poterono; ma un brutto giorno i soldi finirono e il giovane si ritrovò a dover dormire sotto una barca, tormentato di continuo da una fame boia che gli faceva ribollire lo stomaco e gli torceva gli intestini. In quei momenti, anche a costo di lasciarci i denti, avrebbe morsicato uno stoccafisso secco e legnoso, di quelli duri come pietre, che vedeva spesso sbarcare dalle navi che provenivano dal nord e che se ne stavano accatastati nei magazzini del porto, accuratamente tenuti sotto chiave. Di sicuro avrebbe trovato il sistema di entrare in uno di essi, rompendo semplicemente il vetro di qualche finestra, ma gli era sempre ripugnato rubare. "Si deve avere rispetto per la proprietà altrui" gli aveva insegnato suo padre; ma quando la pancia ribolle e non hai nulla per calmarla, chi ti potrebbe rimproverare di aver messo da parte (almeno per qualche momento) i buoni principi? Il giovane aveva spesso rubacchiato qualche mela dai banchetti del mercato all'ingrosso; aveva anche frugato tra la frutta che i commercianti scartavano perchè ammaccata e quindi invendibile, ma pur sempre commestibile per uno come lui che aveva fame, e in quelle occasioni si era vergognato di sè, pensando che tutti puntassero gli occhi su di lui e lo considerassero alla stregua di un barbone. Un giorno Igor, seduto sulla coda, cogliendo negli occhi spiritati del padrone, che da giorni aveva mangiato solo dei pezzi di pane raffermo, uno strano sguardo, fece un balzo indietro ed esclamò: - E no, padron mio! Quelle idee te le devi togliere dalla mente. Se hai fame non pensare a me che sono bello grasso perchè do la caccia ai topi e, in mancanza d'altro, me ne cibo. Lo so anch'io che qui attorno vive gente che non disdegna stufatini con carne di gatto. Non pensare di imitarli perché poi ti ritroveresti ancora con la fame e senza più il tuo amico Igor. Il giovane si riscosse dai suoi tristi pensieri. In effetti aveva pensato ad uno stufatino di carne, ma non certo di carne di gatto e si rammaricò che Igor avesse solo potuto pensarlo. - Sì, ho una fame boia, amico, ma come ti è potuta venire una simile idea? - lo rimproverò. - Sai com'è! La fame gioca spesso cattivi scherzi. - Rassicurati, non fino a questo punto. Chi mi resterebbe poi per amico? - Non pensi ai tuoi fratelli? - Oh quelli! Pensano solo a se stessi. E poi non vivono più a Genova. Con un balzo Igor gli saltò sulle ginocchia e cominciò a fare le fusa. Rimasero in silenzio a guardare le macchine che passavano veloci lungo la stradale. Tutto ad un tratto il giovane sentì le unghie di Igor pungergli la pelle. - Ahia, mi fai male! - protestò - Vedi, padron mio, - gli rispose il gatto senza minimamente preoccuparsi della lamentela, - mi è venuta una straordinaria idea. E' da tempo che sto pensando a come modificare in meglio la nostra situazione e ciò che sto meditando è veramente una geniale idea. Ma tu mi devi aiutare. - A far che? - A trovar soldi. - Ma, Igor, ti rendi conto di quello che dici? Se potessi trovar soldi non starei qui a rodermi per la fame. - Sta tranquillo, non ti chiedo grandi somme. Il tuo contributo consisterà solamente nel trovare una modesta sommetta per comprarmi un paio di occhiali. Al resto penserò io. - Degli occhiali!! - fece il giovane guardandolo stupito. - E a che ti servono. - Tu non ci pensare: a che servono lo so io. Tu pensa solo a procurarmeli e i tuoi guai saranno risolti. - Ma dove li trovo i soldi per comprarti gli occhiali? - A ben pensarci - disse il gatto - non c'è neppure bisogno di soldi. Potresti chiedere gli occhiali direttamente a quel tuo amico, quel 'vu cumprà' che li vende a poco prezzo un piazza Banchi. Per qualche giorno ritengo che potrà prestartene un paio. - E se il tuo piano non funziona? - Gli restituisci gli occhiali e nessuno ci rimette nulla. E bada bene che ne voglio un paio con le lenti trasparenti, non colorate. Mentre il gatto parlava, il giovane pensò ad una fiaba che gli aveva raccontato sua madre quando era bambino e disse: - Igor, a che razza di imbroglio stai pensando? E poi, sei sicuro di voler proprio degli occhiali o non sarebbe meglio comprare un paio di stivali con un cappello piumato? Sai, il tuo antenato... - Altri tempi quelli! - lo interruppe il gatto. - Allora la dignità e il prestigio di un individuo erano riposti nell'abbigliamento. Oggi sono riposti negli occhiali. Chiunque li inforchi diventa subito un'altra persona, acquista importanza, suscita fiducia. Insomma, facciamola breve e trovami un paio di occhiali. - Se proprio lo vuoi. Il giovane non insistette oltre, tanto più che non si trovano facilmente dei 'vu cumprà' che vendono stivali, mentre ne trovi molti che vendono occhiali di ogni genere. E, guarda caso, il suo amico di Banchi glieli avrebbe prestati. Lo trovò a fianco di un’edicola di giornali, intento a ballare davanti ad un tappettino steso a terra su cui facevano bella mostra collanine, amuleti, anelli, borse, borsette e occhiali. Il negretto danzava al suono di una radiolina e continuò a saltellare mentre ascoltava le richieste del giovane. Fu un accordo curioso che conclusero ballando di fronte alla gente che li guardava stupita e poi si allontanava scuotendo la testa. L'indomani Igor, munito di un paio di occhiali nuovi sistemati sul naso, ritto sulle zampe posteriori e con l'aria di un ragioniere indaffarato ed efficiente, passeggiava lungo le banchine del porto, guardandosi attorno come se cercasse qualcosa di preciso. Quando giunse all'altezza dello yacht 'Esmeralda', si fermò vicino alla passerella e gridò: - Ehi di bordo, c'è qualcuno? - Me diga, sior! - gli rispose un uomo in maglietta bianca, a strisce rosse, calzoncini corti e un berretto di lana in testa. - Me diga? - ripeté. Prima di andare al molo dove era attraccata l' 'Esmeralda', Igor aveva fatto una visitina a Trilli, la gatta della Capitaneria di Porto, una vecchia conoscenza dalla quale aveva appreso molte cose sullo yacht e sul suo padrone per cui, di fronte a quell'uomo che gli aveva risposto, aveva fatto un cenno con la testa ed era salito a bordo, tenendo una cartellina di plastica sotto una zampa. L'aprì e fece finta di leggere. - Se non erro, lei è veneziano, vero? E' il custode, il nostromo e il tutto fare di bordo e si chiama Nane, dico bene? - O guarda! El dise ben! Mi sì, son de Venèsia, de Malamocco: se n'è accorto anca elo? - E questa è l'imbarcazione del commendator Tiscornia, vero? - aggiunse Igor con fare sussiegoso. - Sior, sì; xe la barca de paron Tiscornia. - Lo sa che il commendatore è partito per una lunga vacanza nel Sud America e non tornerà che a dicembre? - Sior sì che lo so. Me despiase... - Non v'è nulla di cui dispiacersi, mio buon Nane - disse Igor sedendosi su una sdraio senza essere stato invitato. - Sono a conoscenza di tutto - aggiunse chiudendo la cartella. - Ho parlato con lui prima che partisse ed era presente anche suo nipote. - El fio de so fratelo? No lo cognosso, ma, siben, caro vu, ho sentìo che xe un puto d'onor. - Sì proprio lui, un vero gentiluomo, e lo conoscerà presto, Nane. - Ben. Certo che xe un gran onor... - Vedrete, Nane, è un giovane a modo, anche se non tiene molto alla forma e all'abbigliamento. Poi, cambiando improvvisamente discorso, chiese: -Sapete in quale città dell'America è andato il commendatore? - Lustrissimo, sì: xe andao a Maracaibo. - Una gran bella città. - disse Igor. - Me despiase, ripeté Nane, - no la cognosso. A mi me piase solo Venèsia. - Bene, fece Igor - e mi scusi, Nane, se non mi sono ancora presentato. Sono Igor de Felix, uno dei ragionieri del commendator Tiscornia e il mio incarico è quello di comunicarle che sino al ritorno del commendatore l' 'Esmeralda' è stata affidata a suo nipote, il Marchesino De Lollis. Verrà oggi stesso a prenderne possesso. E mi raccomando, se qualcuno le chiederà a chi attualmente appartiene l' 'Esmeralda', risponda pure che appartiene al Marchesino De Lollis, capito? - Sior, sì, per servirla. Sa, par mi un paron vale l'altro e se il paron la vol così, ghe userò atto de respèto. Igor, lasciato Nane che si era messo a strofinare il mancorrente della passerella di bordo, si era diretto verso un modesto bar dove il suo padrone stava in impaziente attesa. Il giovane aveva visto quel mattino Igor inforcare gli occhiali, specchiarsi in una vetrina, prendere un’andatura eretta su due zampe e dirigersi verso il porto. Il gatto non gli aveva detto nulla dei suoi progetti. - Meno sai, meglio è, padrone. - Ma non mi metterai mica in qualche guaio! - La mia intenzione è proprio l'opposto. Voglio procurarti un tenore di vita che nemmeno te lo sogni. - Per questo ci vorrebbe un sacco di soldi. - Abbi fiducia. Tu aspettami al bar e non ti preoccupare. Il giovane aveva fiducia, ma era preoccupato lo stesso. Si rincuorò solo dopo che ebbe visto Igor entrare nel bar, sorridendo sotto i baffi. I due confabularono a lungo. Il giovane dapprima fece resistenza, ma alla fine accondiscese a fare quello che il gatto gli chiedeva. Un'ora dopo il sedicente Marchesino De Lollis, padrone di Igor, seguendo alla lettera gli ammaestramenti del fedele gatto, si insediava a bordo dell'imbarcazione che visitò da un capo all'altro. Nane l'aveva seguito passo passo, illustrandogli i vari locali e il giovane ce la metteva tutta per non lasciar trapelare il suo stupore, la sua curiosità e la sua ammirazione di fronte a quel gioiello di yacht che doveva essere costato un patrimonio. Guardandolo di sottecchi, Nane non sapeva come giudicarlo perché i vestiti che il giovane indossava erano alquanto dimessi. Ma non era compito suo dar giudizi sui padroni, per cui concluse filosoficamente i suoi pensieri: "Xe un de quei puti ben arlevai che no xe cattivi, anco se mal vestì." E lo lasciò dopo avergli indicato la cabina migliore. Nel frattempo Igor, sempre con la sua aria di ragioniere indaffarato, era corso alla volta del capannone della Società Levantina di Esportazione-Importazione. Si trattava di un ampio capannone che sorgeva all'inizio del molo cui attraccavano le navi porta-containers. In quel momento ve n'era una arrivata il giorno prima dal Giappone. Davanti al capannone stavano accatastati blocchi di containers pieni di merci disparate in attesa di essere caricati su camion. Igor si aggirò fra gli scaricatori, cercando di individuare chi si occupava della direzione dei lavori, finché non si imbatté nel sovrintendente al quale, con aria di comando, disse: - Chi è il suo superiore? Dove posso trovare l'amministratore generale il Marchesino De Lollis? - Mai sentito nominare, - gli rispose il sovrintendente, un omaccione panciuto, con dei bicipiti da lottatore e il cervello poco sviluppato. - Qui non ci sono amministratori. Qui ci sono solo io ad occuparmi di tutto. - Ma questo capannone non appartiene al commendator Tiscornia? - Sì, ma lei chi è? - Sono il ragioniere Igor de Felix, ragioniere capo della Levantina. Ecco le mie credenziali. Mise sotto il naso dell'uomo una cartellina alla quale il sovrintendente diede solo una occhiata distratta. - Quindi non sa, - riprese il gatto - che l'amministratore generale della Società Levantina è il nipote del proprietario, il Marchesino De Lollis? - Se lo dice lei! - Certo che lo dico io - disse Igor con piglio deciso. - E' sicuro di non averne mai sentito parlare? - Non l'ho mai visto. - Sappia allora che lo vedrà spesso. Anzi, la informo che verrà tra poco per un’ispezione per conto della Società. Tenga i registri a sua disposizione. E da oggi, se lo ricordi, l'amministratore generale della Società Levantina è il Marchesino De Lollis e lo potrà trovare a bordo dello yacht del commendator Tiscornia, all'ancora nel porto. Ciò detto, il gatto corse all' 'Esmeralda' per avvertire il padrone della sua nuova carica. Lo aiutò ad indossare un abito adatto alla sua posizione, che trovò nel ben fornito guardaroba del commendator Tiscornia, e lo accompagnò fino al deposito, facendogli molte raccomandazioni sul suo modo di comportarsi. Nel vederlo passare tutto impettito nel suo abito grigio chiaro, col papillon a pois simile ad un pipistrellino appeso alla camicia e che andava su e giù seguendo il movimento della gola quando il giovane ingoiava la saliva (e per la tensione che avvertiva la ingoiava di continuo), i camalli del porto si fermavano a guardarlo, chiedendosi chi fosse e che cosa ci facesse un giovane così elegante in mezzo ai containers, alle casse di stoccafisso e baccalà, immerso in quell'acre odore di salsedine mista a profumi di spezie e di pesce che fasciava ogni cosa. Durante il tragitto Igor non smise un istante di fargli coraggio. - Orsù,- lo rincuorava, vedendolo titubante, - si tratta semplicemente di fare la parte del padrone. Tieni sempre presente che sei tu a comandare e che chi comanda ha sempre ragione, anche quando sbaglia. Quindi non avere alcun timore se ti scappa qualche fesseria. Di' pure quello che vuoi, ma parla sempre con sicurezza come se tu stessi dando un ordine; poi osserva, ispeziona dappertutto; e non dimenticare di fare qualche appunto qua e là. Le cose perfette non esistono e sebbene tu di importazioni ed esportazioni non capisci nulla, potrai lo stesso notare che qualcosa potrebbe essere cambiata. Fallo notare a chi ti sta attorno. Ah, dimenticavo: prima di venir via, controlla qualche registro e firmalo qua e là tanto per dare l'idea che il padrone sei tu e poi ritorna sullo yacht. Mi farò vivo presto. E senza tener più conto della sua dignità di gatto ragioniere, corse via su quattro zampe alla volta del lungo molo dove solitamente attraccavano le petroliere. Quel mattino alla Capitaneria di Porto aveva saputo che la "Golden Petrol" era arrivata dal Golfo Persico il giorno prima ed era in attesa di essere scaricata. Lungo il molo un gruppo di operai si dava da fare per sistemare grossi tubi e per allacciarli a bocchettoni posti sulla coperta della petroliera. Tutt'attorno il porto ferveva per molteplici attività di carico e di scarico. Lunghe teorie di camion si avvicendavano intorno ai capannoni e dai traghetti, che venivano dalle isole o che erano in procinto di partire, fuoriuscivano o entravano auto, camion, pullman. Igor giunse proprio nel momento in cui il direttore della Petrol Oil Company stava chiedendo al capitano quando sarebbe iniziata la fase di scarico del greggio e con chi dovesse accordarsi per le modalità di pagamento dell'intero carico. L'uomo sembrava aver molta fretta e Igor sapeva, per averlo spesso notato, che chi ha fretta tende a sorvolare su molte cose, ad evitare ogni pignoleria, a trascurare i controlli, per cui, sistemati per bene gli occhiali sul naso e assunta la posizione eretta, si presentò con un'aria così sicura che infondeva fiducia al solo guardarlo. - E' lei il direttore della Petrol Oil Company - Sono io. Con chi ho l'onore di parlare? - Sono il dottor de Felix, Igor de Felix. Sono il fiduciario della Società Levantina di Importazione ed Esportazione e ho l'incarico di occuparmi della transazione circa la sistemazione e il pagamento dell'intero carico di greggio. - Non l'aspettavo così presto! Lo scarico inizierà domani. Con la Levantina eravamo rimasti d'accordo che il suo incaricato sarebbe arrivato domattina con i documenti. - E' esatto. Ma si è verificata una circostanza favorevole che la Levantina non può non sfruttare. Ecco la ragione della mia presenza anticipata. Occorre che la transazione e il versamento dell'importo preventivato siano effettuati oggi stesso. Il direttore sembrava perplesso. Ma prevalse la fretta e la considerazione che per una società vale sempre il detto "Il tempo è denaro". E Igor lo conosceva per averlo sentito pronunciare da un gatto del Cheshire, incontrato per caso dietro l'Hotel Bristol, un hotel per VIP dove il padrone, un magnate del petrolio, era ospite da qualche giorno. Con una pronuncia perfetta il gatto del Cheshire aveva appunto detto "Time is money" e, visto che il povero Igor, gatto genovese, non aveva capito niente, glielo aveva tradotto in un italiano un po' stentato, ma comprensibile. - Ha con lei i documenti? - chiese il direttore. Il gatto esibì una cartella con alcuni fogli dattiloscritti che quella mattina, prima che si aprissero gli uffici, aveva prelevato presso la Capitaneria di Porto, entrando comodamente in compagnia della sua amica Trilli, senza che la guardia di turno li fermasse e uscendone poco dopo con una cartella piena di documenti sotto il braccio. E chi mai avrebbe fatto caso ad un gatto ... anche se portava un fascicolo con sè, aveva un bel paio di occhiali sul naso e si strusciava contro una gattina che faceva la vezzosa! - Ciao, Trilli, - le aveva detto. - Ti ringrazio per l'aiuto e a buon rendere. - Lo sai che per te mi farei in quattro, - gli aveva risposto Trilli languidamente. Igor aveva strofinato il suo naso contro quello di lei ed era corso via. La cartella conteneva tutti gli incartamenti necessari allo sdoganamento e alla compravendita del petrolio. Fu proprio quelli che consegnò al capitano della petroliera e al direttore della Petrol Oil Company, i quali si limitarono ad un controllo superficiale e poi, dato che entrambi avevano voglia di concludere subito l'affare in quanto il capitano non vedeva l'ora di andarsene in qualche bar a godersi una bella birra ghiacciata e il direttore della Petrol era sul piede di partenza per le vacanze. firmarono i documenti. - Su quale banca dovrò far accreditare l'importo concordato? - chiese il direttore. - Sul Credit Suisse di Lugano - rispose prontamente Igor che aveva imparato a memoria quel nome. - Accrediti la somma sul conto del Marchesino De Lollis. Le ho segnato il numero del conto bancario sul contratto. Il Marchesino De Lollis è il nuovo amministratore generale della Società Levantina. - Sarà fatto - rispose il direttore. Si recarono tutti negli uffici della compagnia dove conclusero l'operazione. Poi si accordarono con la banca svizzera e, infine, ognuno se ne andò per la sua strada. Igor era oltremodo felice. Nel giro di una giornata aveva procurato al suo padrone uno yacht pieno di ogni delizia, l'aveva fatto diventare amministratore generale di una importante società di importazione ed esportazione e gli aveva assicurato un cospicuo conto in una banca straniera. Nemmeno un grand'uomo come il mitico Paperon de Paperonis sarebbe riuscito a fare altrettanto. Fischiettando allegramente (ma i gatti sanno fischiare? Ne dubito, per quanto li possa conoscere: ma non dimentichiamo che Igor era un gatto speciale), dunque, fischiettando allegramente si avviò alla volta della 'Esmeralda' per riferire al padrone l'esito dei suoi raggiri e comunicargli la presenza a suo nome di un consistente conto su una banca svizzera. Se la prese comoda e non si mise a correre come al suo solito. Si tolse però gli occhiali che, per tutto quel tempo gli avevano dato un certo fastidio. Durante il tragitto trovò pure il tempo di divertirsi a dare la caccia ad un topolino che gli aveva attraversato la strada. Lo rincorse per un tratto; lo acchiappò, giocò un poco con lui e poi, mentre stava istintivamente per ucciderlo (in fondo faceva parte della sua natura!) ci ripensò. Troppa fatica far fuori quel sorcetto e troppa fatica mangiarselo con tutti quei peli ispidi che gli sarebbero rimasti sullo stomaco. Era preferibile farsi comprare dal padrone una scatoletta di Sheba contenente un profumatissimo e raffinato cibo per gatti. Per cui allungò una zampata al sorcetto che rotolò via e si allontanò un poco intontito, ma vivo. Quando giunse allo yacht, si accorse con piacere che anche il suo padrone non aveva perso tempo ad ambientarsi e a stringere nuove amicizie. Lo trovò, infatti, in compagnia di due fanciulle, figlie di armatori che avevano le loro imbarcazioni vicine a quella del commendator Tiscornia. Se ne stavano tutti e tre seduti su comode sdraio, davanti ad un tavolino e ad un carrello su cui facevano bella mostra alcune bottiglie di champagne e leccornie assortire. Il suo padrone, sorridente e felice per la piega che aveva preso la sua vita, riempiva i bicchieri, mentre Nane, in bermuda a fiori, faceva circolare un vassoio con delle tartine al caviale. Si fa presto ad abituarsi alla bella vita! Per uno che aveva abitato per anni un una roulotte dove lo spazio era esiguo, dove si dovevano prendere le misure quando ci si trovava affiancati e dove si urtava spesso e volentieri (be', proprio volentieri no!) contro spigoli e sporgenze, trovarsi di punto in bianco su uno yacht lungo oltre venti metri, con molte cabine a disposizione, spazio a volontà e un marinaio che ti chiama 'paron mio' oppure ad ogni tuo desiderio ti risponde con un 'lustrissimo sempre a sua disposision, benedeto!', era come toccare il cielo con un dito, quel bel cielo ligure, così terso e lucente quando soffia la tramontana, solcato dal rapido ed elegante volo dei gabbiani, molti dei quali, stridendo acutamente, si posavano senza timore in coperta o sulle antenne delle navi. Che vita da nababbo! Altro che dormire sotto i ponti o sotto una barca rovesciata come gli era capitato nei mesi precedenti. Era stato un vero terno al lotto procurare gli occhiali a Igor. E da quel giorno per il gatto e per il suo padrone la vita non fu altro che un susseguirsi di ore felici, di notti dorate passate nei nights e nelle discoteche della riviera, nei Casinò di Sanremo e di Montecarlo oppure ospiti in enormi ville padronali dove venivano invitati solo coloro che possedevano forniti conti in banca. E il padrone di Igor, grazie all'abilità del suo gatto con gli occhiali, che era diventato un vero esperto della finanza, poteva contare su cospicui depositi presso banche italiane e straniere. Ma un malaugurato giorno, mentre Igor era lontano, giunse tra la posta una lettera dall'apparenza innocua che il Marchesino De Lollis lesse appena e, non riuscendo a capirla, la buttò via. Il gatto ragioniere non ne seppe mai nulla. Passò un mese e una bella mattina d'autunno, mentre il Marchesino ancora dormiva, si presentarono alla passerella dello yacht 'Esmeralda' due signori vestiti di nero, dal cappello alle scarpe, tranne la camicia che era bianca. Si fermarono sulla banchina e non salirono a bordo perché ogni natante è proprietà privata e per salire occorre il permesso del proprietario. Chiamarono. Il Marchesino, ancora insonnolito, si affacciò al boccaporto e chiese chi fossero. Quelli risposero semplicemente: - Finanza. E' lei il Marchesino De Lollis? E poiché il giovane era rimasto a bocca aperta, fu il marinaio che rispose: - Sì, siori, xe lu, par servirli. Se la vol salir a bordo el me paron lustrissimo ve darà udiensa. Quelli salirono e si diressero subito verso la cabina di comando dove Igor conservava in ordine i documenti... non proprio legali dei suoi vari imbrogli. E i controlli della Finanza ebbero inizio. Da quel momento tutto precipitò, anche perché Igor, da giorni, non si era più visto. Si era messo in testa di trascorrere una vacanza con la sua amica Trilli perché gli era venuta una mezza idea di accasarsi. Il Marchesino De Lollis si affannò invano a cercarlo per tutto il porto, lo chiamò usando persino il megafono, frugò nelle stive, nei capannoni, sui pontoni galleggianti, salì sulla più alta gru per avere una più ampia visuale di tutto il porto. Anche il marinaio Nane si diede da fare, con meno impegno perché non era lui a rimetterci in quel frangente. Fu tutto inutile. Il Marchesino, 'poareto' come diceva Nane, non sapeva che è difficile trovare un gatto innamorato e non sapeva, 'poareto lu', che i gatti innamorati sono capaci di stare fuori casa anche per settimane. Finalmente i controlli della finanza terminarono. Un proverbio dice che è meglio avere un morto in casa che la Finanza alla porta. Il Marchesino De Lollis imparò a sue spese che il proverbio era esatto e si ritrovò con le manette ai polsi per essere accompagnato in prigione. Oggi si trova ancora là, in una comoda cella, dietro le sbarre, in buona compagnia (si fa per dire!). Ogni giorno Igor, che non ha trovato la compagna ideale che cercava (Trilli aveva in testa troppi grilli!) è rimasto affezionato al suo padrone e lo va a trovare passando per i tetti. Parla con lui dei bei giorni passati e gli tiene compagnia, acciambellandosi sulle sue gambe e facendo le fusa - Senti, padrone, - gli disse un giorno. - Mi è venuta una brillante idea: che ne diresti di comprarmi un paio di pedali per correre alla prossima Milano-Sanremo e ai prossimi giri d'Italia e di Francia? I compagni di cella del giovane, a conoscenza delle prodezze di Igor, applaudirono alla trovata. Già vedevano il gatto con i pedali in testa al gruppo, svettare solitario sulla Cima Coppi o superare le vette dell'Aubisque e del Tourmalet e battere i più grandi campioni, tagliando il traguardo a zampe alzate tra le entusiastiche urla dei tifosi. Quasi, quasi gli avrebbero comprato loro non solo i pedali, ma l'intera bicicletta, maglia e berrettino colorato compreso. Ma il suo padrone l'esperienza l'aveva già fatta e l'idea non lo sollecitava affatto. Gli occhiali erano bastati a fargli comprendere con chiarezza che gli imbrogli alla lunga non pagano. - Grazie, Igor, no, non te li compro - gli rispose precipitosamente. - Ne ho già avuto abbastanza di un gatto con gli occhiali e ritengo che un gatto con i pedali mi metterebbe in guai peggiori di quelli nei quali mi trovo adesso. Ti prego, lasciami riposare. Qui tra quattro mura mi sento perfettamente al sicuro. E si addormentarono entrambi.
Accadde tutto durante la notte e non se ne accorse nessuno. Ma alle sette del mattino la città di Genova era piombata nel caos. Lunghe file di macchine in entrambi i sensi di circolazione intasavano le strade da Nervi a Sampierdarena e oltre. I fumi dei gas di scappamento prodotti senza sosta dalle macchine avevano fatto saltare gli aghi delle centraline di controllo-smog e lo strombazzamento dei clacxon aveva disturbato persino frotte di passeri i quali, per trovare quiete, si erano rifugiati nei vecchi forti costruiti sulle alture della città. Cos'era successo? Una cosa da poco: tutti i semafori della città erano andati in tilt, non funzionavano più. O meglio, continuavano a funzionare, ma il rosso, il giallo e il verde erano spariti. Qualcuno durante la notte aveva rubato i colori ai semafori. - Ma che, ti sei ammattito? - gridò nel microfono il Comandante dei vigili ad un agente della stradale che gli stava telefonando e aveva appena finito di ispezionare alcuni semafori. - Come sarebbe a dire: funzionano, ma non si vedono i colori? - No, non si vedono proprio. Vede, comandante, - gli spiegò l'agente - abbiamo provato a cambiare i vetri colorati, ma hanno subito perso il colore quasi fosse stato risucchiato via: abbiamo anche provato a sostituire le lampadine normali con lampadine colorate, ma anch'esse, appena accese, sono diventate bianche. Signor comandante, c'é qualcosa che ruba i colori. Il comandante ascoltò trasecolato. Poi, riappeso microfono, siccome era un uomo di buon senso, esperto e pratico (sennò perché l'avrebbero nominato comandante!) diramò subito un ordine perentorio: ad ogni incrocio doveva essere momentaneamente collocato un vigile per regolare il traffico. Poi si recò dal sindaco per riferire e per cercare assieme una soluzione. Dal sindaco arrivò in ritardo perché dovette andarci a piedi, infatti, nonostante ci fossero i vigili ad ogni incrocio, l'intasamento era ormai completo: tutte le auto o erano ferme o erano costrette ad andare a passo d'uomo. - Quanto durerà questa situazione? - volle sapere il sindaco, preoccupato per tutte le telefonate di protesta già arrivate. - Non glielo so dire. L'ENEL ha mandato i suoi esperti per vedere se si tratta di qualche disfunzione nella linea elettrica, ma finora non hanno trovato nulla. - Per quanto tempo potremo andare avanti utilizzando i nostri vigili? - Un paio di giorni, tre al massimo. Sa, signor sindaco, i vigili sono pochi. Oggi li ho utilizzati tutti, anche quelli non addetti al traffico. Ma non possiamo costringerli a rimanere per dieci, dodici ore ad un incrocio per dirigere il flusso degli automezzi. Impazzirebbero. E poi non abbiamo altro personale con cui dar loro il cambio. Nell'ufficio del sindaco si erano intanto radunati diversi assessori e ognuno diceva la sua. - Vietiamo la circolazione finché non si sarà trovato il guasto - propose l'assessore all'urbanistica. - Usiamo la circolazione a targhe alterne - suggerì l'assessore alla sanità. - Applichiamo il sistema delle fasce orarie - interloquì l'assessore al bilancio. L'assessore alla cultura, che di traffico ne masticava poco - non aveva nemmeno la macchina - se ne venne fuori con una proposta da lasciar a dir poco trasecolati i presenti. - Se perdura questo bel guaio, che ne pensate - disse - se, per evitare che le macchine intasino gli incroci, nei giorni pari facciamo viaggiare solo quelle che svoltano a destra e nei giorni dispari quelle che svoltano a sinistra? Alla proposta era seguito un silenzio di tomba. Qualcuno si era raschiata la gola e poi la discussione era stata ripresa. Ma non si approdò a nulla. Per le strade, intanto, il caos delle macchine continuava anche perché tra i vigili non c'era alcun accordo. Quando uno di essi dava con la paletta via libera, il collega, posto di servizio al semaforo successivo, dava, invece, il segnale dello stop. Agli automobilisti pareva di essere su una pista del Luna Park e qualche volta ci scappava pure lo scontro che costringeva chi lo subiva ad un violento contraccolpo contro il sedile - il classico colpo della strega - mentre chi lo aveva provocato si beccava una tremenda capocciata nel parabrezza. E allora giù moccoli a non finire, imprecazioni, insulti che si aggiungevano e accrescevano la cacofonia dei motori. Gli elettricisti dell'ENEL, dopo accurate indagini, non trovarono alcuna anomalia nella rete elettrica e inviarono al Comando dei Vigili una comunicazione in cui si diceva che il guasto non dipendeva dalla rete, ma da cause sconosciute. - Sconosciute un par di ciuffoli! - urlò il Comandante dei vigili noto perché, quando si arrabbiava, usava le espressioni più strane. - Bisogna scoprire la causa a tutti i costi! Passarono i giorni e la causa non fu scoperta. Genova divenne la città caotica per eccellenza e nessuno dalle località circostanti e dalle città vicine volle più venire in macchina. E fu un bene perché sulle strade il traffico diminuì, anche se di poco in quanto tutti i genovesi motorizzati pensavano "io la macchina l’ho e la voglio usare!" Come il Comandante dei vigili aveva previsto, gli agenti non ressero allo stress. Molti incroci rimasero incustoditi. E furono guai. - Tocca a me! - diceva un automobilista. - Io vengo da destra. - Ma che destra e destra d'Egitto! Non sa leggere il cartello? La segnaletica dà la precedenza a me, caro signore. - E chi lo dice? Questa è una corsia preferenziale - sbraitava un autista di taxi. - Non lo vede: ci sono persino i cordoli? - Lo sa dove se la può ficcare la corsia preferenziale, cordoli compresi? - rispondeva esasperato l'interloquito. Spesso scendevano dalle auto, continuavano a discutere, a insultarsi, a spintonarsi e poi a darsele di santa ragione. E non c'era neppure un vigile a dividerli perché quei pochi ancora in forze erano impegnati in qualche incrocio. Avvennero anche fatti curiosi. In Piazza Corvetto, dove confluiscono addirittura sei strade, un buontempone aveva sistemato proprio sotto la statua di Vittorio Emanuele a cavallo, una grossa lavagna, prelevata in qualche scuola, e, attorniato da una piccola folla, spiegava ai litiganti a chi spettava la precedenza, disegnando sulla lavagna e avvalendosi di accurati grafici. E alla fine chiedeva il prezzo della consulenza, rilasciando regolare ricevuta fiscale. L'idea di usare la lavagna agli incroci parve attecchire perché il giorno dopo la prima comparsa a tutti gli angoli degli incroci non controllati sorsero i cosiddetti 'maestri della precedenza'. Quando due o più automobilisti si trovavano nei pasticci perché non riuscivano a decidere chi dovesse passare per primo, invece di bisticciarsi e poi di prendersi a botte, preferivano affidare la questione al 'maestro della precedenza'. Si avvicinavano alla lavagna, ognuno esponeva la sua tesi, 'disegnava' col gesso le sue ragioni, le sosteneva, le difendeva animatamente e poi aspettava la sentenza. Quasi sempre finiva che si bisticciassero lo stesso o che prendessero a botte l'improvvisato maestro. Una volta accadde persino che a prendersi alcuni sonori schiaffoni fosse proprio un insegnante di scuola guida il quale era intervenuto per caso al fine di risolvere un complicato problema di precedenza. Ci fu poi l'idea di Pasquariello, un napogenovese - cioè un napoletano trapiantato a Genova - il quale in gioventù a Posillipo aveva imparato l'arte di fabbricare i fuochi artificiali, come bengala, botti, candele romane, girandole. Pasquariello, all'incrocio delle strade che convergono a Piazza Principe, proprio vicino alla statua di Colombo, in corrispondenza dei semafori, piazzò una serie di girandole rosse, verdi e gialle. Bastava accenderle alternativamente, prima le rosse poi le gialle e infine le verdi, per sveltire il traffico. Quando le girandole erano esaurite, si sostituivano subito con altre. Una trovata formidabile. Però servì a poco perché a intasare l'incrocio non furono più le macchine, ma i genovesi, uomini, donne e in particolar modo i bambini, accorsi a frotte per godersi quei gratuiti fuochi artificiali. Un direttore d'orchestra del Teatro Carlo Felice propose, invece, di regolare il traffico con dei segnali sonori: un lungo assolo di trombone sostituiva il rosso; un breve intermezzo di violini indicava il giallo, mentre un rullo di tamburi avrebbe indicato il verde. Però, quando si tentò di applicare quel sistema sonoro ci si accorse che per dare via libera, facendo rullare i tamburi, per gli automobilisti provenienti da una parte, bisognava contemporaneamente suonare i tromboni per fermare le macchine provenienti dall'altra, per cui i suoni si accavallavano, si confondevano e i conducenti non ci capivano nulla. Si dovette subito abbandonare l'esperimento e rimandare a teatro il direttore. I giorni intanto passavano e furono giorni tremendi per Genova, finché, ad un tratto, ci si accorse di un fenomeno inatteso il quale fece tirare un sospirone di sollievo al sindaco e al Comandante dei vigili. La gente, stanca del caos cittadino, cominciò a lasciare sottocasa o nei garage le macchine inservibili, la cui funzione era ormai solo quella di provocare rabbia e di far aumentare la pressione. E tutti si decisero ad usare altri mezzi per raggiungere il posto di lavoro o per spostarsi. Se si doveva andare vicino per fare la spesa o per shopping, si usava il cavallo di San Francesco, cioè si andava a piedi; qualcuno cominciò ad usare anche il cavallo vero. I ragazzini tirarono fuori i pattini; le biciclette diventarono a poco a poco padrone della strada. Con esse non c'era bisogno di bisticciarsi agli incroci: bastava una leggera pressione sui freni per fermarsi e per lasciar passare qualcuno e poi via a pedalare. Anzi la gente cominciò a capire come comportarsi: i ragazzini lasciavano la precedenza agli adulti sempre indaffarati o ai vecchietti lenti; gli uomini, da veri gentiluomini, impararono a cedere il passo alle signore; le signorine lasciavano la destra a chi era più anziano e così via. - Prego, signora, passi lei! - No, tocca a lei. E' lei a destra. - A tardona, ti vuoi dare una smossa? E passa che ti lascio la strada! Beh, c'era sempre qualcuno che continuava ad essere strafottente e maleducato anche se poi il passo lo cedeva lo stesso. Strano a dirsi, ma da quel momento Genova diventò una città diversa, nuova, vivibile; niente più smog, niente più fumi tossici. Le strade diventarono piste per biciclette e cavalli e, alla domenica, in Corso Italia era un piacere camminare, pedalare, pattinare. Nessun pericolo di essere investiti e di finire in ospedale. Sì, c'era sempre lo sprovveduto che per ammirare il paesaggio finiva con le ruote della bici addosso a qualcuno, ma la cosa si risolveva in una leggera ammaccatura o in uno strappo ai pantaloni o alla gonna. Danni sempre riparabili. E i vigili addetti al traffico? Beh, quelli vennero assegnati ad altri lavori. A loro rimase un solo cruccio: quello di non poter più affibbiare multe per divieto di sosta.
********************** A proposito, ma i tre colori dei semafori dove erano finiti? Nessuno lo seppe mai e dopo le prime indagini nessuno se lo chiese più. Ma io sì! Io sono curioso di natura e ho continuato l'indagine per conto mio... e sono giunto alla soluzione. Io ho scoperto chi ha rubato i tre colori: perché i colori furono effettivamente rubati. La soluzione me l'ha suggerita Igor, il mio gatto. Un giorno che era di luna buona mi informò di aver udito un suo amico lamentarsi nel sonno. Lo aveva udito borbottare che da mesi non vedeva più topi. Dalle fogne non uscivano più. Mi chiesi anch'io la ragione di quella stranezza e un giorno, dopo essermi tappato il naso con una mascherina intrisa di profumo, scesi in una fogna e tutto mi fu chiaro. Non ci crederete, ma ogni incrocio delle gallerie scavate nel ventre della città mi si presentò illuminato da un semaforo. Rimasi stupito, ma poi compresi la ragione. Vedete, i topi delle fogne sono abituati a camminare nel buio e molto spesso non vedono bene gli ostacoli, specie agli incroci delle gallerie e così prendono delle tremende capocciate nei muri. Capita anche che smarriscano la strada e si ritrovino all'aperto in qualche vicolo, dove stanno ad attenderli degli enormi gattacci con le grinfie pronte ad acchiapparli. Stanco di aver bernoccoli e al fine di evitarne altri, uno di loro propose di adottare il sistema che gli uomini usavano in superficie: quello dei semafori. Tutti approvarono e, per far più presto, decisero di rubare i colori e di costruirseli. Rosicchiarono alcuni fili elettrici sistemati nel sottosuolo, proprio quelli che portavano l'elettricità ai semafori, sistemarono i colori nei punti di maggior traffico e da quel giorno vissero anche loro felici e contenti senza più salire in superficie e rischiare di finire in bocca a qualche gatto... e quel che più conta senza dare altre capocciate nei muri delle fogne. Tutto ciò vi parrà forse strano, ma é così e se non mi credete, provate a scendere in una fogna. Vedrete che gli incroci sono tutti illuminati come le nostre strade nei giorni di Natale.
Da quando avevano deciso di costruire la diga sul Torrente della Fate a Giacò era venuto un mezzo infarto. Il suo paese sorto in fondo alla valle avrebbe dovuto essere sacrificato. Le acque della diga lo avrebbero sommerso completamente. La sua casa, la casa di suo bisnonno, di suo nonno, dei suoi genitori, la casa dove era nato, sarebbe rimasta intatta in fondo al lago: una casa per soli pesci. E così era stato. La diga era stata costruita e lentamente Giacò aveva veduto le acque sommergere tutto il paese. Gli abitanti, seppur a malincuore, avevano accettato di vivere in nuove casette costruite per loro in una località più a valle. Solo Giacò aveva rifiutato. Lui era rimasto e aveva accettato il posto di custode della diga pur di rimanere accanto ai suoi ricordi. Il lavoro era poco e il tempo lo impiegava in varie attività. Si era persino costruito una barchetta e ogni sera, al tramonto raggiungeva il punto in cui il suo paese, la sua casa, la chiesa, il cimitero erano rimasti sepolti e lì, tirati i remi in barca, si abbandonava ai ricordi. Coricato sul fondo della barca, con il volto verso il cielo, gli occhi pieni di stelle, ascoltava il silenzio della notte e i pochi rumori che giungevano sino a lui dai boschi circostanti. Nessuno abitava nei dintorni. Non c’era nessuna casa, solo qualche baita per cacciatori, per lo più diroccata, tranne poche, rabberciate alla bell’e meglio, dove i cacciatori talvolta sostavano durante le loro battute. In paese scendeva una volta alla settimana, il sabato, per far provviste e Giacò approfittava di quei momenti diversi dal consueto per scambiare qualche parola all’osteria e guardare gli amici di un tempo, assorti in interminabili partite di scopa e tresette. Quel sabato l’osteria era insolitamente affollata. Un giornalista di un noto quotidiano, in cerca di notizie curiose, stava intervistando alcune persone, registrando le loro storie. Giacò ascoltava. Molte storie le conosceva per averle sentite raccontare in passato. Quando sembrò che nessuno avesse più nulla da raccontare, Giacò, titubante, intervenne, rompendo il momentaneo silenzio. - Nessuno di voi, - chiese – ha mai sentito cantare una sirena nel lago della diga? - Quale sirena! – chiese il giornalista incuriosito. Il barista lo guardò e con un dito si batté la tempia. Giacò lo vide con la coda dell’occhio. - No, Ercole, non sono matto! Io il canto della sirena l’ho udito. Da alcune sere lo sento. - - È bionda la tua sirena? – chiese ridendo un giovanotto. - - Ho detto di averla udita cantare, non vista – precisò Giacò. - -Avrai udito il vento soffiare tra i rami degli alberi. A volte il vento fa strani rumori, - disse un vecchio cacciatore. - Non era il vento. Chi vive come me in completa solitudine conosce tutti i rumori dei boschi, il canto degli uccelli, le grida degli animali, specie di quelli notturni. Ti dico che si trattava del canto di un essere umano. - Allora era qualcuno che si aggirava di notte lungo le sponde del lago. - Era una voce femminile e non credo che una donna si avventuri da quelle parti di notte e si metta a cantare alla luna – ribatté Giacò. – E poi ho chiamato e nessuno mi ha risposto. - Non ti avranno udito. - Penso che mi abbiano udito perché appena ho chiamato il canto si è interrotto. Ma dopo un lungo silenzio ha ripreso. - Ha riconosciuto la canzone? – chiese il giornalista. - No. Le parole non si distinguevano. Anzi ho avuto l’impressione che fosse un canto senza parole, una specie di nenia, una melodia strana, melanconica, triste, piena di dolore. Il giornalista era sempre più incuriosito. Ascoltava i presenti cercando di comprenderne gli umori. Gli pareva che la maggior parte di essi pensasse che Giacò, l’uomo che viveva solitario lontano da tutto e da tutti, cominciasse ad avere delle visioni; altri ridacchiavano apertamente e se il giornalista non fosse stato presente lo avrebbero preso in giro. - So che non mi credete e che pensate ch’io sia un poco pazzo. Vi sbagliate. Ho sentito un canto sul lago e ho subito pensato ad una sirena - Di certo non era un pesce. Tutti sanno che i pesci sono muti. - E invece, talvolta, qualcuno come te straparla quando non sa quello che dice – gli rispose Giacò che cominciava da arrabbiarsi. Chissà come sarebbe andato a finire il discorso se il giornalista non fosse intervenuto con una idea che troncò sul nascere ogni discussione. - Sentite: – disse – avevo deciso di fermarmi in paese per questa notte. Vuol dire che me ne andrò col signor Giacò a fare una passeggiata in barca sul lago della diga e se troveremo la sirena farò pubblicare la storia sul giornale. La proposta fu accettata e confermata con una bevuta generale.
*********************
Il giornalista, seduto sul fondo della barca, guardava Giacò manovrare lentamente i remi. Tutto all’intorno taceva. Solo qualche raro bubbolio di un gufo, il lamento lugubre di una civetta, vari fruscii e rumori indistinti rompevano il silenzio. Nel cielo sereno una luna tonda, bianca riverberava il suo chiarore sulla superficie del lago che sembrava lameggiare sotto i suoi raggi. Il giornalista guardava i remi tuffarsi nell’acqua scura e riemergere grondanti stille che, investite dai raggi lunari, si coloravano d’argento. Parevano perle. D’un tratto Giacò rimase con i remi a mezz’aria. - Eccola! – sussurrò – la sente? È lei! La sirena. Il giornalista si riscosse dai suoi pensieri e spalancò gli occhi guardandosi attorno. Un murmure leggero cominciò a diffondersi all’intorno. Dapprima quasi impercettibile e poi sempre più chiaro. Una nenia, come aveva detto Giacò, una cantilena modulata, priva di parole, tutta musica e melodia si diffondeva, sfiorava la superficie del lago. Una melodia dal fascino strano, ammaliante, che ti avvinceva e ti stregava. Il giornalista pensò a Ulisse e alle sue sirene. Se il canto che aveva udito era simile a quello che ora i due uomini udivano non c’era da meravigliarsi se le sirene avevano il potere di stregare gli uomini. Il canto sembrava venire dalla riva e il giornalista chiese a Giacò di remare in quella direzione. Non trovarono nulla. Tutto era calmo. - Dirigiti verso il centro del lago! - ordinò il giornalista. Nulla, nessuna presenza. Eppure il canto continuava. I due uomini continuarono a spostarsi facendo giri sempre più ampi, sempre seguiti dal canto, ora più forte, ora leggero, ora ridotto a un vago sussurro. La melodia durò a lungo. Poi cessò all’improvviso. - Ecco, -disse Giacò – finisce sempre così. - Ti sei fatto qualche idea - No. In realtà Giacò una idea se l’era fatta, ma non l’avrebbe mai svelata a nessuno. La prima volta che aveva sentito la sirena si trovava proprio sopra il suo paese sommerso e il canto gli aveva ricordato un periodo felice della sua gioventù, quando faceva la corte a Ninetta. Per lui Ninetta era la più bella ragazza del paese. Aveva una voce dolce, vellutata, ammaliatrice. Quando udiva una canzone che le piaceva, non badava alle parole, si impadroniva della melodia che canticchiava durante i lavori domestici e in particolar modo in campagna, dove il suo canto si diffondeva per i campi, la valli, i prati, trasportato dal vento. Poi Ninetta era morta giovane e con lei era sparito il suo canto. Era stata seppellita nel piccolo cimitero che ora si trovava in fondo al lago. Per Giacò la sirena che cantava era Ninetta. Cantava per lui facendo emergere il canto dalle profondità, cantava per alleviare le pene e la solitudine di colui che aveva amato. Era l’idea di Giacò, ma non l’avrebbe mai rivelata a nessuno. Prima di ritornare sulla diga i due uomini fecero fare alla barca giri sempre più ampi. Ispezionarono le rive, scrutarono tra gli alberi del bosco alla ricerca di qualche luce, di un indizio. Non trovarono nulla: tutto taceva all’intorno. Per il giornalista fu giocoforza ammettere di aver udito un canto di donna, sirena o essere umano che fosse, ma di non aver scoperto nulla. Pochi giorni dopo sul giornale, nella cronaca apparve un articolo: “Una sirena canta nel lago della fate”. Si trattava di un pezzo di colore, un poco fuori del normale ma capace di stuzzicare la curiosità e la fantasia dei lettori.
*************************
Passarono anni. Il giornalista, diventato capo redattore del giornale, si era trasferito in una città in riva al mare, dove lentamente era invecchiato. Alla sirena non aveva più pensato. Una fantasia del passato, chiusa e dimenticata in mezzo ai ricordi. Altre notizie più tragiche di guerre, sommosse, uccisioni con cui veniva quotidianamente a contatto per lavoro, si erano accumulate nella sua mente dove non c’era più spazio per la fantasia. Una sera, a distanza di trent’anni dall’incontro con Giacò, stanco per una faticosa giornata di lavoro, aveva pensato di rilassarsi andandosene a passeggio lungo il litorale e si era seduto su una panchina da dove poteva vedere l’ampia distesa del mare. Era una serata tranquilla, il mare calmo pareva un lago su cui si riverberavano i raggi argentei della luna. In lontananza, quasi al limite dell’orizzonte, alcune lampare parevano lucciole. All’improvviso, la brezza che soffiava da terra portò sino a lui l’eco di un canto. Dapprima il giornalista non ci fece caso; poi di colpo la melodia riportò a galla un ricordo sopito. Il ricordo del canto della sirena. La stessa melodia priva di parole, lo stesso tono accorato, gli stessi confusi sentimenti, di gioia, di disperazione, di speranza che si intrecciavano. Si guardò attorno. Le poche villette circondate da giardini avevano tutte le finestre buie. Solo una casa a tre piani, circondata da un ampio giardino mostrava alcune finestre illuminate. Il giornalista si avvicinò al cancello e, senza pensare alla tarda ora, premette il campanello. Un uomo uscì dalla casa, attraversò il giardino e si diresse verso il cancello. Non pareva stupito della presenza di quel visitatore. - Desidera? – chiese. - Vorrei sapere chi è che canta – disse precipitosamente il giornalista senza presentarsi. - E perché? Conscio della perplessità del suo interlocutore, si presentò e raccontò succintamente la ragione della sua richiesta. L’uomo non si stupì. - Mi segua, - disse semplicemente. Aprì il cancello e si avviò verso il portone su cui spiccava una targa: “Villa Giada per anziani”. Percorsero in silenzio un corridoio. L’uomo si fermò davanti ad una porta e bussò discretamente. Il canto si interruppe e una voce invitò ad entrare. L’uomo aprì l’uscio e fece cenno al giornalista di seguirlo. La stanza era immersa nella penombra. Un abat-jour color rosso diffondeva una luce tenue, soffusa che conferiva contorni sfumati ai pochi mobili: un letto, un comò, un armadio, una toilette, un tavolino, una seggiola e una sedia a dondolo su cui stava seduta una donna anziana. Aveva un plaid sulle ginocchia e le mani un poco tremanti, appoggiate sulle gambe. I capelli bianchi erano raccolti sulla nuca in una crocchia, il viso era un poco grinzoso, gli occhi chiari guardarono i due uomini mentre un sorriso le illuminava il volto. - Signora Cesira, scusi se mi sono permesso di introdurre un visitatore a quest’ora, ma so che a lei piace la compagnia e penso che la storia che udrà sarà di suo gradimento. - Prego, si accomodi – disse l’anziana signora con una voce un poco tremula, - e mi dica. Il giornalista cominciò a parlare e il ricordo di quella notte passata con Giacò sulla barchetta, riaffiorò in tutti i suoi dettagli. La donna non lo interruppe mai. Sembrava persa nei suoi pensieri. - Una sirena! – mormorò trasognata quando il giornalista ebbe terminato di raccontare. – Una sirena, io! È il più bel complemento che mi sia capitato di udire. – Poi, con voce chiara aggiunse. - Sì, penso proprio di essere io la sua sirena di trent’anni fa: la sirena del Lago delle fate. Tacque per un istante, quasi a raccogliere pensieri sparsi e poi cominciò: - Quell’anno di trent’anni fa fu per me un periodo triste, molto triste. Poco dopo l’Epifania mio marito morì e io per trovare un poco di compagnia andai a vivere con mia sorella, suo marito e Silvia, mia nipote, una dolce ragazzina di tredici anni. Pensavo di trovare in quella famiglia un poco di pace e di serenità. Mi sbagliavo. Il matrimonio di mia sorella era in crisi, punteggiato di liti continue, di accuse quotidiane, di incomprensioni, di battibecchi feroci. Chi soffriva di più in quella situazione era mia nipote di carattere sensibile che mal sopportava di vedere i suoi genitori allontanarsi l’uno dall’altro giorno dopo giorno. Rimasi con loro per alcuni mesi e poi decisi di allontanarmi per pensare a come organizzare la mia vita. La signora Cesira tacque un istante e poi riprese. - Mio marito, sebbene non condividessi la sua passione, era un cacciatore e trascorreva il periodo della caccia in una baita vicina al lago della diga. La baita era una costruzione di due stanze rustiche ma abitabili per brevi periodi. Decisi di rifugiarmi tra quei boschi in cerca di pace. Un giorno, all’improvviso, ricevetti la visita di mia nipote. Me la trovai di fronte al ritorno da una passeggiata. Aveva uno zainetto sulle spalle, una piccola valigia in mano. Piangeva. “Sono fuggita di casa, zia, papà e mamma si sono divisi, mi disse piangendo. Il giudice ha detto che debbo vivere un poco con l’uno e un poco con l’altra. Zia, non sono una cosa che si possa spostare a piacere di qua e di là, ecco perché sono venuta da te. Solo tu mi puoi aiutare!” E aveva continuato a piangere. L’abbracciai senza sapere che cosa dire. Rimase con me per due settimane. Cercai di aiutarla. Durante il giorno facevamo lunghe passeggiate tra i boschi. Il sole, gli alberi, la natura, gli animali erano di aiuto, un diversivo per dimenticare temporaneamente una situazione cui non c’era più rimedio. Ma al tramonto del sole, col calar delle tenebre, in quella baita senza luce, illuminata dal fievole chiarore di un lumino ad olio o di una candela, dalle ombre annidate negli angoli i ricordi uscivano, ci assalivano implacabilmente. Allora mi sedevo su una panca. Silvia si accoccolava ai miei piedi, chinava il capo sulle mie ginocchia. Io le accarezzavo i capelli, le passavo una mano sulle guance e la ritiravo umida, bagnata di pianto. Silvia piangeva silenziosamente. Io non ho mai saputo trovare le parole per alleviare il dolore degli altri. Le parole mi sembravano, vuote, banali, prive del significato che si sarebbe voluto dare ad esse. Inutili. Da giovane avevo fatto parte di un coro; avevo una bella voce, così mi dicevano. Ho sempre amato il canto perché il canto è poesia e attraverso esso puoi manifestare ogni sentimento: gioia, dolore, piacere. Col canto puoi addolcire ogni cosa o anche esaltarla. Per aiutare Silvia usai il canto e mentre le accarezzavo i capelli cercavo melodie senza parole, capaci di calmarla, di cancellare il dolore che spesso l’assaliva. Cantavo canzoni senza parole che la brezza, scendendo dall’alto portava in basso, fino a sfiorare la superficie del lago, a ricoprirlo di una nebbia melodiosa. Io non me ne rendevo conto ma chi si trovava in quel momento in vicinanza del lago o addirittura su una barca poteva udirla e immaginare qualsiasi cosa. Ecco da dove veniva il canto udito da lei e da Giacò, il canto della sirena, Il canto della sirena del lago, il mio canto, - aggiunse con un sorriso che le illuminò il volto e parve cancellare ogni ruga. La signora tacque. Non c’era più nulla da dire. Mi alzai, la salutai e uscii dalla sua stanza. Immersa nei suoi ricordi parve non accorgersi che me ne andavo. Riattraversai il giardino e andai a sedermi su una panchina in riva al mare. Avevo lasciato alle mie spalle il ricordo di una sirena: l’ultima sirena della mia immaginazione. La realtà aveva distrutto la fantasia. Camminando lentamente verso casa, pensai a Giacò. Chissà se era ancora vivo! Ero felice di una cosa, felice, perché almeno lui, non avrebbe mai saputo la verità Per lui una sirena avrebbe continuato a vivere e a cantare nella sua fantasia.
Tutti lo chiamavano "Lo stagno della miseria", ma Valentino, lui solo, sapeva che non era vero: bastava saper pescare, conoscere i luoghi adatti e andarci al momento opportuno. Quanti pesci non aveva preso usando quegli accorgimenti! Le sue reti venivan su sempre piene di pesci argentei, di guizzanti trote, di viscide anguille, e destavano l'invidia degli altri pescatori. - Ma come fai, Tino? - chiedevano con una punta di invidia nella voce. - Segreto! - rispondeva allegramente. - Basta saperci fare e "Lo stagno della miseria" diventa "Lo stagno della cuccagna". Da un po' di tempo, però, Valentino non prendeva più nulla. Ogni sera calava la rete e quando, all'alba, andava a tirarla su, la trovava vuota e rotta. Le prime volte aveva pensato che qualche tronco calato sul fondo strappasse con i suoi rami scheggiati le maglie della rete e i pesci fuggissero dal buco venutosi a formare; ma poi si era accorto che non si trattava di veri strappi. I nodi che formavano le maglie erano sciolti pazientemente, uno per uno, e per un tratto bastevole a far fuggire i pesci. Una sera, stanco di non pescar più nulla e deciso a sorprendere l'autore di quello scherzo (pensava che fosse qualche pescatore invidioso a rovinargli la pesca), Valentino si appostò tra i giunchi, a poca distanza dalla rete e stette in attesa. La luna, occhieggiando tra le nubi sparse, gettava fasci d'argento sullo stagno, disegnando sopra le acque strani arabeschi. La lucentezza delle acque era tale che il giovane riusciva a vedere frotte di pesci che si dirigevano verso la rete e i movimenti dei sugheri galleggianti gli dicevano che la pesca sarebbe stata abbondante. Il pensiero di una buona retata lo allettava e avrebbe volentieri rinunciato a far la posta se non fosse stato spinto dal desiderio di cogliere sul fatto il colpevole. Decise, quindi, di aspettare. Passò la notte, giunse l'alba e lui, mezzo insonnolito e bagnato dalla rugiada, non aveva visto nessuno. "Pazienza, - si disse - sarà per un'altra volta. Ora mi conviene tirare la rete." Si pose all'opera, ma con sua grande sorpresa e disappunto, non appena cominciò ad issarla sulla barchetta, si accorse che era rotta come era già accaduto in precedenza e pesci non ve n'erano: neppure uno. C'era solo rimasta, impigliata per una zampa, una rana verde che dava strattoni per liberarsi dall'incomoda posizione. Infuriato, il giovane fece per prenderla con l'intenzione di scaraventarla sul fondo della barca, quando una vocetta disse: - Non uccidere, Valentino, non uccidere! Stupito, il giovane si guardò attorno. Non c'era nessuno. - Avrò sognato - esclamò a voce alta. - Mica stai dormendo! E allora come fai a sognare? Questa volta non c'era dubbio. Qualcuno aveva parlato. - Chi è? Chi parla? - chiese il giovane con una punta di timore nella voce. - Sono io, Valentino. Abbassa lo sguardo ai tuoi piedi. Il giovane guardò e vide la rana che, sempre impigliata, lo guardava tenendo la bocca aperta. Valentino cadde a sedere sul fondo della barca, anche lui a bocca aperta, spalancata per lo stupore. - Ma tu...tu parli! - riuscì a biascicare poco dopo. - E che c'è di strano? Ho ben la bocca come te, no? Mi sono stancata di gracidare, così ora parlo. Non avrai mica paura di me, Valentino? - No, - rispose il giovane - ma dimmi un poco: come conosci il mio nome? - Liberami dalla rete e te lo spiegherò. Il giovane eseguì e poi pose la rana sul bordo della barca. - Vedi, son molti giorni che ti osservo e ho sentito gli altri pescatori chiamarti Valentino o Tino. Ma lo sapete che voi pescatori siete dei brutti tipi? - fece la rana dopo una breve pausa, cambiando discorso. - Brutti in che senso? - Nel senso che uccidete i pesci. Che vi hanno fatto di male, eh? - Beh, niente - borbottò il giovane. - E allora perchè li catturate con le reti? Io non voglio. A Valentino, mentre la rana parlava, stava venendo in mente un atroce dubbio. - Di' un po', ranocchietta, non sarai mica stata tu a sciogliere i nodi della rete? - Certo: sono stata io - confessò quella candidamente. - O brutta bestiaccia! - si adirò il giovane, - ma capisci che, facendo così, mi metti alla fame? Io non pesco per divertimento come certuni, ma perché è il mio lavoro. Non voglio far del male a nessuno, io, e se non mi prometti di non rompere più la mia rete... La rana non rispose. Stette un poco assorta e poi disse: - Senti, Valentino, non ci avevo pensato. Capisco che non puoi fare a meno di pescare, ma non intendo nemmeno che i pesci muoiano. Quanto guadagni con la pesca? - Mah, un quarto di scudo... mezzo scudo al giorno. - Bene. Tu, ogni sera, dopo il tramonto, recati al palazzo, quello che sorge dove termina lo stagno. Vicino alla porticina che si apre nel muro del giardino troverai un vaso, dentro ci sarà uno scudo. Prendilo, è tuo. Ma non venire più a pescar nello stagno. D'accordo? E prima che il giovane potesse rispondere, la rana balzò in acqua e scomparve. Ci volle parecchio tempo prima che Valentino si riscuotesse dallo stupore e alla fine, quando ritornò in sé, pensò che fosse stato il freddo a giocargli quel brutto tiro e si ripromise di non parlarne con nessuno. Chissà che belle risate si sarebbero fatte i suoi amici se avessero saputo che aveva parlato con una rana! Ma tant'è, la sera dopo, scomparso il sole, guardandosi attorno furtivo, Valentino si avviò verso il palazzo. Era questa una costruzione con molte torri merlate e un alto muro di cinta che impediva agli estranei di entrare e di guardare all'interno. Si sapeva solo che il palazzo era abitato, ma non si sapeva da chi. La gente diceva che apparteneva ad un ricco mercante, ma nessuno l’aveva mai incontrato. Si raccontavano strane storie, dicerie fantastiche che avevano solo il potere di tenere lontani i curiosi. Ciononostante il giovane si avvicinò alla porticina del giardino. A fianco di essa, su un sedile di pietra, c'era un vaso di terracotta. Valentino si guardò attorno per vedere se c'era qualcuno e poi, spinto dalla curiosità, vi tuffò dentro la mano e la ritrasse tenendo tra le dita uno scudo d'oro. La rana non aveva mentito. Quella notte il giovane pescatore non andò allo stagno, volendo anche lui tener fede all'impegno. La sera appresso, nello stesso posto, dentro lo stesso vaso, trovò un altro scudo. E così tutte le sere che seguirono. Nei primi tempi Valentino non si curò d'altro se non di ritirare gli scudi, ma poi, curioso di sapere chi ce li metteva, volle vederci chiaro. C'era davanti alla porta del giardino un grosso albero frondoso i cui rami superavano in altezza il muro di cinta. Il giovane un mattino vi si nascose in mezzo, deciso a starci finché non avesse visto chi metteva lo scudo dentro al vaso. Passò la mattinata, venne mezzogiorno, poi il sole cominciò a calare senza che nessuno si fosse fatto vivo. Fu quando il sole stava per nascondersi dietro l'orizzonte che Valentino udì girar la chiave nella toppa, i cardini cigolare e vide una bellissima fanciulla con gli occhi lucenti al par di stelle e lunghe chiome fluenti sulle spalle come una scintillante cascata, uscire dalla porticina e mettere nel vaso uno scudo che, cadendo, tintinnò. Poi la giovane si ritrasse e scomparve dietro l'uscio. Valentino rimase abbagliato da tanta bellezza e da quella volta, ogni sera, stava là, non più per lo scudo, ma per vedere quella visione di paradiso, anche se durava solo un attimo. Passarono alcune sere e Valentino, ormai innamorato, decise di parlare alla fanciulla. Attese il momento adatto e, quando la vide fuori del giardino, balzò a terra dall'albero, dicendo: - Bella fanciulla, non temere. Dimmi chi sei, ch'io possa ringraziarti. La fanciulla lo guardò, dapprima spaventata, poi gli sorrise, ma, senza rispondere, rientrò nel giardino e richiuse l'uscio dietro di sé. Valentino si allontanò sconsolato. "Son povero, - pensava - mi ha visto così stracciato e si sarà vergognata di me. Quanto sei disgraziato, Valentino! - si commiserò. - Va', va', non sei che un povero pescatore, tornatene al tuo stagno e non sognare più. Calava la notte quando Valentino, triste, salì in barca e, remando giunse in mezzo allo stagno dove si mise a piangere lontano da occhi indiscreti. - Si può sapere che hai da piangere, Valentino? non ti basta lo scudo? - gli chiese la rana, saltando su uno scalmo. - Oh, ranocchietta, sono così infelice! E non per lo scudo ché quello mi basta e ne avanza. Ma tu non puoi capire. - Perché, son forse scema? - No, scusami, non intendevo... - E allora, che hai? - Te lo dirò: in fondo è un poco a causa tua se mi trovo in questa situazione. Da quando mi hai mandato a ritirare lo scudo davanti alla porta del giardino e da quando ho veduto chi lo mette nel vaso, io non vivo più, amica mia. Dimmi: tu conosci la fanciulla che vive nel palazzo? L'animaletto si dondolò sulle zampette prima di rispondere e poi disse: - Certo che la conosco. La vedo ogni giorno. - Ah sì? Allora dille che le voglio bene con tutta l'anima. Dille che io non vivo più se non mi parla. La rana si mise a saltellare lungo il bordo della barca senza rispondere. - Allora, glielo dirai? - Sì, posso dirglielo, ma non gioverà a nessuno dei due. - Perché? - Senti, è meglio che ti dica tutto. Alinda, così si chiama quella giovane, è ammalata di uno strano male che le impedisce di vivere tra la gente. Avrai sentito dire che il palazzo dove vive appartiene ad un ricco mercante e questo è vero: Alinda è sua figlia. Quando nacque il padre invitò a banchetto tutti gli amici i quali partirono dalle quattro parti del mondo per recarsi alla festa nel suo palazzo, non quello che tu conosci, ma un altro che si trova in riva al mare lontano da qui. Accadde che il mercante, frastornato per la nascita di Alinda, si dimenticasse di invitare Alì Jussuf, un potente emiro arabo, il quale prese la dimenticanza per uno sgarbo. Il giorno del banchetto, mentre tutti erano in festa e la culla di Alinda era circondata da una infinità di doni, l'uno più bello dell'altro, si presentò un servo dell'emiro, nero come la notte, il quale recava un bellissimo scrigno sigillato che consegnò al mercante, dicendo : "Da parte dell'emiro Alì Jussuf. Per Alinda". Poi se n'era andato prima che qualcuno potesse trattenerlo. Il mercante si era avvicinato alla culla per porre il dono a fianco degli altri, ma, preso da curiosità, volle aprirlo per vederne il contenuto. Rimossi i sigilli dello scrigno, si vide uscire una nebbiolina che circondò la culla per pochi istanti e poi sparì. Il padre e tutti i presenti si chinarono solleciti sulla culla da dove la bimba li guardava sorridendo. L'episodio fu dimenticato e solo il giorno appresso, nel riporre i regali, il mercante si accorse che sul fondo dello scrigno c'era una piccola pergamena su cui stava scritto:
"Non contare più sulla mia amicizia. Mi hai offeso non invitandomi. Sono figlio del deserto e la vendetta per me è sacra. La nebbia azzurra che si è sparsa sulla culla era fatata e una grave minaccia pende ora su tua figlia. Quando raggiungerà il ventunesimo anno, morrà, ma prima una ben più grave sciagura la colpirà. Quale? Lo saprai presto. Lascio però ad Alinda uno spiraglio di vita. Ricorda: "ALINDA POTRA' VIVERE SOLO SE MORIRA' ANNEGATA NEL SUO DOLORE. Alì Jussuf".
Non ti dico lo stupore e il dolore del mercante. Chiamò a consulto molti sapienti, convocò maghi e stregoni, ma nessuno riuscì a capire quelle parole sibilline. La rana tacque per un poco e poi aggiunse con voce accorata: - Alinda compirà ventun anni tra un mese a partire da oggi. Valentino aveva ascoltato in silenzio e alle ultime parole aveva avvertito un colpo al cuore. - E non si può far nulla? - No. Ecco perché ti ho detto che potrei rivelare il tuo amore alla mia amica, ma questo non gioverebbe a nessuno dei due. Non farebbe altro che addolorarvi di più. Con un salto la rana era saltata nello stagno e si era allontanata nelle acque cupe, lasciando il giovane ai suoi ancor più cupi pensieri. L'alba lo trovò accasciato sul fondo della barca e lo riscosse col tepore dei raggi del sole nascente. Valentino si guardò attorno. Era inutile starsene lì a pensare: occorreva agire, Afferrò i remi e spinse la barca verso la riva di un boschetto di querce dove abitava il Vecchio. Nessuno sapeva chi fosse il Vecchio, né che nome avesse e di dove venisse. Si era costruita una capanna di rami nel più folto del bosco e viveva solitario mangiando bacche e qualche volta i pesci che Valentino gli portava. Tutti sfuggivano il Vecchio per paura; solo il giovane pescatore gli era amico e poiché molto spesso il Vecchio gli aveva dato buoni consigli, si recò da lui anche questa volta. Lo trovò intento a bollire alcune erbe in una pentola di terra. Il giovane si sedette su un tronco d'albero e stette assorto nei suoi pensieri prima di parlare. - Che hai? - gli chiese il Vecchio. - Sono disperato, amico; disperato e infelice. - Che ti è successo? Valentino gli raccontò ogni cosa, poi attese. Il Vecchio continuò a rimestare la brodaglia, poi, guardandolo fisso gli chiese: - Sei disposto a rischiare la vita per la tua Alinda? - E me lo chiedi! - rispose quello con passione. - Allora sentimi bene: vedi laggiù, all'orizzonte, quella montagna, la più alta? - Sì. - Nessuno è mai riuscito a scalarla. Troverai in cima a quella montagna la risposta alla frase sibillina contenuta nella pergamena. - Ne sei sicuro? - Ti ho forse mai mentito? - No, mai. Ti ringrazio, Vecchio, e a presto. Quella sera Valentino attese in mezzo allo stagno l’arrivo della rana e quando questa si fu installata in cima allo scalmo, il pescatore la informò che sarebbe partito alla ricerca della medicina che avrebbe salvato Alinda. La rana tentò di dissuaderlo. Tutto era già stato tentato ed era inutile mettere a repentaglio la sua vita. Alinda gli voleva bene e si sarebbe maggiormente addolorata se avesse saputo che lui affrontava pericoli sconosciuti. Ma a nulla valsero le preghiere dell'animaletto. Valentino era deciso. - Non mi convinci, amica mia, domattina partirò. Dillo ad Alinda. Vado perché l'amo e se fra un mese lei morirà, morirò anch'io. Debbo tentare. Salutala per me e se io non tornassi, consolala. Addio. Il mattino seguente, prima che l'alba spuntasse, il giovane era in cammino. Quando, dopo cinque giorni, si trovò ai piedi della montagna e, alzando gli occhi, vide la massa rocciosa delle pareti ripide e ricoperte di ghiaccio innalzarsi su, su, sino alle nubi e perdersi in esse, sentì le forze venirgli meno. Gli bastò però ricordare il dolce viso di Alinda per mettersi all'opera e con una piccozza prese a far buchi nella roccia dove poter appoggiare le mani e i piedi per salire. Passarono le ore, poi i giorni. Alla roccia viva si sostituì il ghiaccio e aumentò il freddo. Di giorno il sole lo riscaldava un poco, ma le notti erano tremende. Il vento fischiava furioso nelle gole, spazzava la neve che, turbinando, l'avvolgeva in un bianco mantello. Le mani screpolate, le gambe rotte dalla fatica gli dolevano in modo indicibile. Ma Valentino continuava a salire incoraggiato dal rauco grido delle aquile, gli unici esseri viventi in quella solitudine e a quell'altezza, le uniche voci che accompagnavano la sua fatica. Dieci giorni durò l'ascesa e gli ultimi metri il giovane li fece strisciando sul ghiaccio, gemendo per il freddo e la fame. Ma era arrivato in cima. Di lassù lo sguardo spaziava sul territorio circostante. Bianche cime velate da nubi si vedevano in basso affiorare tra la nebbia e a tratti sprizzavano fasci di luce quando i raggi del sole colpivano i ghiacciai. Più in basso ancora si scorgevano verdi vallate e i nastri argentei dei fiumi parevano esili fili d'erba bagnati di rugiada. Il giovane era però stanco, troppo stanco per godersi il paesaggio e poi era salito sin lassù per un'altra ragione. "Troverai la risposta in cima alla montagna" gli aveva detto il Vecchio. Valentino si guardò attorno. Dov'era la risposta? Lassù non c'era nulla: solo ghiaccio e un enorme masso a cui si era appoggiato. Guardò attentamente. Nulla. Il Vecchio si era sbagliato e lui aveva affrontato quell’immane fatica per niente. Il pianto che aveva trattenuto per tutta la scalata, sgorgò abbondante dai suoi occhi e le lacrime, scivolando sulla roccia, si raccolsero in una piccola cavità del masso dove subito gelarono. "Dio, - pensò - poter morire qui, vinto dal dolore. Poter annegare in questo mio dolore infinito!" Ma lo sorresse la volontà di poter vedere ancora una volta la sua amata Alinda e, nonostante la fatica, riprese la via del ritorno. Trascorsero altri dieci giorni per la discesa e cinque per tornare allo "Stagno della miseria". Quando vi giunse, il sole era tramontato da un'ora e, dato che non poteva più per quella sera vedere Alinda, saltò in barca e si diresse verso il centro dello stagno. Spuntava la luna quando dei grossi cerchi che si allargavano sull'acqua, lo avvertirono che la rana stava avvicinandosi. L'animaletto, saltato a bordo, con una vocetta ansiosa chiese: - E allora, Valentino? Il giovane non rispose subito. Si prese la testa tra le mani e ve la tenne a lungo. La rana non insistette, attese che lui parlasse, anche se aveva già capito. - Non ho trovato nulla, amica mia, nulla! E' stato tutto inutile. Dimmi, come sta Alinda? - E' stata molto in ansia per te. Ha pianto ogni giorno pensandoti, ma ha anche sperato. - Ed ora come glielo dirò? - Se vuoi, posso farlo io. - No, tocca a me. Ho fatto una promessa che non ho potuto mantenere, le ho dato vane speranze, quindi io debbo cercare di consolarla. Rendimi un ultimo favore: tu sei amica di entrambi, tu la vedrai tra poco, dille di attendermi domani. - Glielo dirò. Tu, un'ora prima che tramonti il sole, trovati davanti alla porta del cancello. Non mancare perché è domani che Alinda compirà ventun anni. - Ciò detto, fuggì. Il giorno appresso, al tramonto, quando il sole si avvicinava alla cima della montagna che aveva scalato, il giovane bussò alla porticina. Questa si aprì. - Alinda, amore mio! - disse Valentino, accogliendo tra le braccia la fanciulla. - Non raccontarmi nulla, so tutto e non te ne faccio certo una colpa. So che hai tentato l'impossibile, ma se la magia di Alì Jussuf è più forte del nostro amore, allora dobbiamo arrenderci. Ma parlami, parlami di te a lungo affinché, prima di morire, possa conoscerti meglio. - Immagino che la nostra comune amica ti avrà già raccontato tutto sul mio conto. A proposito, dov'è? Alinda sorrise, poi disse: - La ranocchietta non c'è, ma la vedrai tra poco e sarà l'ultima volta perchè anche lei morirà con me, oggi. - E vedendo il giovane stupito, soggiunse: - Vedi, Valentino, io sono la rana. Ricordi quando la rana ti raccontò della pergamena di Alì Jussuf? Nella lettera l'emiro diceva che prima di morire Alinda sarebbe stata colpita da una più grave sciagura. Ebbene la sciagura, che si manifestò tre anni fa, consistette nel fatto che io mi tramutavo in rana per tutto il giorno e solo per un'ora, quella che precedeva il tramonto, riprendevo le sembianze umane. Tu, infatti, mi hai sempre vista a quell'ora, quando mettevo lo scudo nel vaso. Tra poco il sole tramonterà, amor mio, e io mi tramuterò nuovamente e sarà per l'ultima volta. A mezzanotte poi morirò. Resta vicino a me, Valentino. Tienimi stretta, così il distacco mi parrà meno crudele. Valentino la prese tra le braccia e, vedendo le lacrime cadere dai begli occhi di Alinda, prese anche lui a piangere sconsolatamente. Piansero in silenzio, piansero a lungo, teneramente abbracciati e le lacrime, mescolandosi a terra, si raccolsero in un incavo del terreno, formando una piccola pozza dorata in cui venivano a morire gli ultimi raggi del sole. Quando esso scomparve dietro la montagna, il giovane sentì la fanciulla tremare. - Lasciami - disse quella divincolandosi. - Sento che mi sto trasformando. Addio, Valentino, addio per sempre. Ti ho amato, oh se ti ho amato! Ma c'è qualcosa più forte di noi che ci separa. Addio, amore mio, e vivi ricordandomi. Si svincolò dall'abbraccio e il giovane vide Alinda raggrinzirsi, diventare piccola, sempre più piccola, finché non fu più alta di un dito. Vide la sua pelle ambrata mutar colore e assumere una tinta verde smeraldo, mentre le sue gambe e le sue mani assumevano la forma di zampette terminanti con piccole dita e il corpo diventava flaccido e molle. I lunghi capelli sparirono e il volto della fanciulla si appiattì e si allungò, mentre la bocca si allargò smisuratamente. Gli occhi uscirono dalle orbite. La metamorfosi avvenne rapidamente, troppo rapidamente perché Valentino ne avesse una esatta percezione. Quando però si rese conto di avere davanti a sé non più Alinda, ma la rana, il giovane si riscosse. - No! - gridò. - No! Se muori tu, morirò anch'io. Mi annegherò, annegherò il mio dolore nello stagno. Quasi folgorato dalla sue stesse parole, Valentino stette un attimo immobile con gli occhi sbarrati. Già un'altra volta aveva pensato di morire di dolore. "Quando?" si chiese. "Quando l'ho pensato?" "Sulla montagna" sussurrò qualcosa dentro di lui. "E che cosa avevo fatto allora?" mormorò sottovoce. "Avevi pianto" gli disse la solita voce di dentro - “e le lacrime si erano raccolte in una cavità della roccia." - Ho capito! - urlò Valentino. - Ho capito! - E, rivolto alla rana: - Io ti salverò. Abbi fede. Si guardò attorno per trovare un recipiente adatto e, visto un bicchiere, lo prese. Con quello raccolse accuratamente le lacrime che si erano raccolte nella pozza del terreno. Poi, presa delicatamente la rana tra le dita , le disse: - Non temere. Dovrai subire una prova crudele, ma l'amore che ho per te mi dice che solo così sarai salva. Il Vecchio aveva ragione a dire che sulla montagna avrei trovato la risposta. E' stata l'esperienza che ho fatto lassù, quando volevo morire, ad indicarmi la via. TU DEVI MORIRE ANNEGATA NEL TUO DOLORE PER POTER VIVERE, così diceva la pergamena. Ebbene, questo è il tuo e il mio dolore - disse, mostrando le lacrime raccolte nel bicchiere - e tu, rana, morirai qui dentro. Solo così si scioglierà l'incantesimo. Ne convieni? La rana scosse il capo su e giù. Valentino la pose nel bicchiere e lo chiuse col palmo della mano per impedirle di uscire. L'animaletto per un poco rimase immerso senza che nulla accadesse: c'era abituato a stare sott'acqua. Passò, quindi, un po' di tempo prima che cominciasse ad agitarsi furiosamente, a cercare di venir fuori, ma la mano del giovane non si muoveva. Si vedeva attraverso il vetro che l'aria di cui la rana aveva bisogno per sopravvivere stava per mancarle totalmente. Continuò ad agitarsi spasmodicamente finché con la bocca spalancata, le zampette inerti, si lasciò cadere in fondo al bicchiere dove rimase immobile. A quella vista Valentino non poté resistere oltre e cadde svenuto. Sorgeva l'alba quando rinvenne e davanti a sé, splendente, radiosa come il sole che stava per spuntare, c'era Alinda che lo guardava, gli sorrideva e gli tendeva le braccia. Il giovane l'attirò a sé e se la strinse al petto. L'amore aveva vinto.
- Brunello, figlio mio, sento che la mia vita sta ormai volgendo al termine e tra non molto me ne andrò per sempre. No, non devi piangere - disse il vecchio padre, vedendo il volto del figlio rattristarsi - la morte non è poi quella brutta cosa che tutti immaginano. Mi addolora solo il fatto di lasciarti senza alcun sostegno, ma sono sicuro che gli insegnamenti che ti ho dato ti saranno di aiuto. Il vecchio tirò un lungo sospiro e aggiunse: - Ecco, prima di andarmene ho ancora qualcosa da consegnarti. E' ben poca cosa, ma è tutto ciò che mi resta: prendi! Il vecchio trasse da sotto il materasso un borsellino di cuoio tutto consumato e una grossa castagna. Con mano tremante offrì al figlio i due oggetti dicendo: - Abbine molta cura, figlio mio, e sappi farne buon uso. Ciò detto il vecchio si era voltato verso il muro, si era tirato il lenzuolo sulla testa e aveva chiuso gli occhi. La morte l'aveva colto senza che se ne accorgesse. Rimasto solo, Brunello, data degna sepoltura al padre e non avendo più nulla da fare nel paese che l'aveva visto nascere e crescere, mise le sue povere cose in un sacco, si ficcò in tasca il borsellino e la castagna e partì in cerca di fortuna. Il mondo era vasto e da qualche parte l'avrebbe trovata. Camminò a lungo e di buona lena prima di riposarsi e fu solo la vista di un ruscelletto che mormorava frusciando tra i sassi a indurlo a fermarsi per rinfrescarsi. Poi, sdraiatosi sotto un salice che affondava le radici nell'acqua del ruscello, trasse di tasca quello che suo padre gli aveva lasciato in eredità. Un borsellino e una castagna stagionata: ben misere cose in verità. Brunello palpeggiò un poco il borsellino, che non aveva ancora aperto, ma non avvertì alcun peso né tintinnì di monete. - Che strano dono mi ha lasciato mio padre! - esclamò tra sé e sé. - Che me ne farò mai di un borsellino vuoto? Almeno ci fosse dentro uno scudo! Aveva appena pronunciato quelle parole che il borsellino gli sfuggì di mano, quasi gli venisse strappato da una forza invisibile, e cadde a terra. Brunello lo raccolse, lo aprì e con stupore ne trasse fuori uno scudo d'oro lucente che - ne era sicuro - un istante prima non c'era. - O perdinci! E da dove sbuchi fuori? - disse, rigirando lo scudo tra le dita. - O dorati astri notturni, o Elios lucente, o pallida Selene, ma non vi par un poco dissennato questo giovin messere che, togliendo dal borsellino un lucente scudo, si chiede, o me tapino, dond'esso venga? Brunello balzò in piedi impaurito, guardò la mano sinistra da dove sembrava provenire la voce e vide con stupore che da un buco della castagna che teneva sul palmo spuntava, dalla cintola in su, un bacherozzo che lo guardava accigliato. L'animaletto, grassottello e panciuto, indossava una piccola maglietta a righe trasversali bianche e nere e aveva il capo coperto da un berrettino conico tutto punteggiato di stelle. - E tu chi sei? - chiese Brunello stupito, ma non certo impaurito di fronte ad un bacherozzo. - Giovannino mi nomo. Erudito io son e me ne vanto! - esclamò il baco con enfasi. - Vantati e nomati pure Giovannino, ma, se puoi, cerca un poco di spiegarmi da dove spunta fuori questo scudo d'oro. - Or dimmi: non t'erudì il paterno genitor pria della sua dipartita? - No, non m'erudì, - gli rispose Brunello facendogli il verso; e aggiunse: - Ma mi dici perché parli in modo così strano? - Se il mio dotto eloquio non t'aggrada, - fece il bacherozzo seccato, - poco mi cale. Sappi però che il tuo prudente genitor mi lasciò qual tuo mentore e consigliero. E se or ti cale saper donde lo scudo uscì, porgi orecchio al mio dire. Il borsellino è fatato e quando tu esprimerai anche un venial desìo, esso ti accontenterà. Ma bada, o inesperto giovine, che sol tre volte ubbidirà ai tuoi voleri; poscia non dovrai più farvi conto. - Quindi, se ho ben capito, - disse Brunello - potrò esprimere solo tre desideri... - Hai inteso per lo giusto verso - assentì Giovannino, dondolandosi con sussiego a destra e a sinistra. - E avrei, di conseguenza, già sprecato un desiderio chiedendo uno scudo? Uno solo! - Oh mente eccelsa, qual profonda riflessione! - Mente eccelsa un accidente, pezzo di... - Calma, giovin messere, - lo interruppe il bacherozzo. - Il turpiloquio non ti s'addice e stravolge i lineamenti del tuo viso. - Ma non potevi avvertirmi prima, - continuò Brunello - ché non mi sarei limitato a chiedere un solo scudo. - Ahimé, nelle braccia di Morfeo dormìa beato. E poi impara, messer Brunello: mai chiedere molto se il poco ti basta. - Capirai che scialo con uno scudo! Ma ormai é fatta e lasciamo perdere. Dimmi piuttosto, visto che sei il mio consigliere: dove dobbiamo andare? - Che importanza può avere la direzione per un che se ne va alla ventura? Visto però che a me lo chiedi, mentore e guida sarò per te. Orsù, stendi la mano. Brunello eseguì l'ordine e pose la castagna col bacherozzo al centro. Giovannino si arrampicò in cima al frutto poi, tiratosi il berrettino fin sugli occhi, fatti alcuni giri su se stesso, saltò, eseguì una capriola e rotolò giù cadendo a destra della castagna. - Ecco, andremo per di là - disse mostrando il bosco alla sua destra. - La sorte decise per noi. - Hai un bel modo per scegliere la direzione, - disse ridendo Brunello, per il quale una strada valeva l'altra. Si mise quindi il sacco in spalla, ripose Giovannino e la castagna in un taschino e si avviò nella direzione indicata. In capo a due giorni di cammino attraverso boscaglie e vallate, dopo aver guadato fiumi e valicato monti, il giovane giunse in prossimità di una città costruita sulle pendici di una collina in cima alla quale si ergeva un palazzo enorme dalle mura rosate che riflettevano i raggi del sole. Da lontano la città appariva piacevole e gaia, ma non appena Brunello raggiunse le prime case e s'imbatté negli abitanti, s'accorse dal loro modo di comportarsi che c'era qualcosa che li turbava e che qualche grave evento stava per accadere. Tutti erano vestiti di nero e camminavano pensierosi, a capo chino. Gli uomini, seri in volto non parlavano, mentre le donne si asciugavano gli occhi bagnati di pianto. Più il giovane si addentrava nella città, più la gente aumentava; pareva che tutti si fossero riversati nelle strade per stare uniti, in attesa di qualche avvenimento pauroso, terribile. Sotto le mura del palazzo, di fronte al portone principale, una folla enorme, compatta, parte a capo chino e parte in ginocchio, stava silenziosa in attesa che al balcone del palazzo apparisse qualcuno. Ma le finestre del balcone erano chiuse. Brunello, sempre più incuriosito, si avvicinò ad un vecchio che se ne stava appoggiato ad un bastone e gli chiese: - Nonno, che sta succedendo? Che cosa aspettate e perché siete tutti così tristi? Il vecchio lo guardò attraverso gli occhi cisposi, - Ma come, non lo sai? Oggi è il giorno nero. - Poi, vedendo che la risposta non suscitava nel giovane alcuna reazione, spiegò: - Capisco: tu sei un forestiero e non puoi saperlo. Oggi, figliolo, è un giorno infausto per la nostra città perché sta per avverarsi quanto fu predetto. Quando nacque la nostra principessa Lucina, l'astronomo di corte disse al re che, trascorse duecentosedici lune nuove da quella nascita, sarebbe accaduto un fatto strano. La luna avrebbe divorato il sole e la terra sarebbe stata immersa nel buio. La principessa Lucina si sarebbe addormentata di un sonno così profondo che solo l'odore del fiore che non ha profumo avrebbe potuto risvegliarla. Così profetizzò quel sapiente e oggi, scaduta la duecentosedicesima luna, la predizione dovrebbe avverarsi. La gente tutta ama la principessa Lucina per la sua bellezza e bontà, e così si è riunita per pregare affinché ciò non accada. Ecco perché, forestiero, ci trovi qui riuniti. Brunello stava per chiedere ancora qualcosa, quando un urlo si levò dalla folla. Tutti caddero in ginocchio e guardarono in alto verso il cielo. Il sole, che sino ad allora aveva brillato in un cielo terso, cominciò a perdere la sua lucentezza, mentre una macchia nera spuntava a destra del disco dorato. Pareva che un mostro famelico, rotondo al par della luna, un mostro dalla bocca immane, affondasse le sue fauci nell'astro lucente per rosicchiarlo lentamente. E quanto più la macchia si estendeva, tanto più la luce del giorno diminuiva. La gente terrorizzata taceva. Gli uccelli volavano impazziti e le bestie, fuggendo dalle stalle, galoppavano verso i prati su cui già si stendeva una nera ombra. A poco a poco, boccone dietro boccone, il disco del sole fu inghiottito, si spense, sparì dal cielo e la terra rimase avvolta in un'ombra cupa, orribile. Un vento furioso prese a soffiare spazzando via rami, foglie, abbattendo le messi e rovesciando ogni ostacolo. Con la scomparsa della luce la gente, impazzita dalla paura, fuggiva, si urtava, cadeva a terra e si feriva. Brunello, addossato al muro di una casa, era rimasto immobile, anche lui impaurito. Ma non passò molto tempo che, caduto di colpo il vento, uno sprazzo di luce, un sottile raggio dorato, foriero di speranza, apparve in cielo e, oh meraviglia!, il sole, quasi fosse riuscito a riemergere da quella gola infernale che l'aveva inghiottito, cominciò lentamente a ricomparire e, finalmente libero, a risplendere di nuovo in tutta la sua maestà sulla città e sulle campagne circostanti. La gente, passato il primo momento di stupore, gridava ora di gioia, si abbracciava, rideva, piangeva. Ognuno pensava in cuor suo che la profezia dell'astronomo si era avverata, ma, in fondo, si era risolta solo in un po' di paura e nient'altro. Fu il rauco suono di una tromba a gelare l'entusiasmo generale. Tutti alzarono lo sguardo verso il balcone del castello dove era apparso un araldo vestito di nero. Questi, zittita la gente con un ampio gesto, disse: - Popolo di Zamira, il vostro re, prostrato dal dolore, annuncia che la sua diletta Lucina, secondo quanto fu profetizzato, è caduta in un sonno così profondo che a nulla son valse le prime cure dei medici di corte per poterla risvegliare. Prega, o popolo, prega per la tua principessa. Ciò detto l'araldo si era ritirato a capo chino. Brunello, che aveva seguito la scena e aveva ascoltato le parole dell'araldo, si sedette su un gradino e per un poco stette ad osservare la gente che a gruppetti si allontanava parlando sottovoce. Rimasto finalmente solo, trasse dal taschino la castagna e Giovannino emerse subito dal foro. - Messer Brunello, - disse adirato - assai prima potea trar fuori la mia magion dal suo taschino! Anch'io, suo umile servitor, avea il diritto di mirar l'evento senz'essere costretto a sbirciar di tra i fori dell'abito suo, - Ti chiedo scusa, ma preso come tutti dal panico, non ho pensato a te. - Scusoti, mio baldo amico. In effetti un cotal evento ottenebra la mente, - ammise il bacherozzo, aggiustandosi il cappello che gli era andato di sghimbescio. - Giovannino,- gli chiese Brunello - immagino che avrai sentito quanto mi ha raccontato il vecchio, no? - E vedendo il bacherozzo chinare più volte il capo in segno di assenso, proseguì: - Tu che sei così saggio e colto, sapresti dirmi qual è il fiore che non ha profumo. - Un fiore non aulente...- disse tra sé e sé, meditabondo. - Ch'io sappia non vi son fiori senza olezzo, messer Brunello, come non esistono fiumi che corrono verso la sorgente. - Ma la profezia, allora? - Le parole a volte suonan diverse da ciò che intendono, - rispose Giovannino, sentenziando come al suo solito. - E poi, non sapendo che cosa aggiungere, si tolse il berretto e rientrò nella castagna. - Ah, mi hai dato proprio un bell'aiuto! - esclamò Brunello, riponendo la castagna nel taschino. - Pazienza! Fermiamoci comunque in città per qualche giorno e vedremo che succederà. I giorni cominciarono a trascorrere lentamente. La principessa Lucina, sempre addormentata, era stata posta in un'urna di cristallo dove la gente poteva vederla. Brunello era entrato più volte nel castello per ammirare Lucina, attratto da quel volto bianco, immobile, sorridente nel sonno. La principessa dormiva placidamente mentre tutt'attorno i medici fatti accorrere da tutte le parti della terra si affannavano invano per risvegliarla. Purtroppo nessuna medicina era valida; solo un fiore senza profumo, come aveva profetizzato anni prima l'astronomo, poteva operare il miracolo. Tutti i soldati del re erano partiti per i quattro venti alla ricerca d'ogni sorta di fiori esistenti e quotidianamente il palazzo ne era invaso. Ne arrivavano da tutte le parti: fiori grossi dai petali carnosi, piccoli fiorellini quasi invisibili. Alcuni avevano un forte profumo e venivano subito scartati dai medici; in altri il profumo era tenue, lieve, quasi inesistente. Venivano messi sotto il naso della principessa,ma nessuno di essi valse a risvegliarla. Dopo un mese il re disperato emise un bando: - Visto che a nulla son valse le cure sino ad oggi applicate, io, re di Zamira, dichiaro che concederò in moglie mia figlia Lucina a chi riuscirà a risvegliarla. Brunello aveva ascoltato il bando con molto interesse e stavolta si era ricordato di farlo udire anche a Giovannino che, per l'occasione, era uscito dalla castagna indossando una maglietta trapunta di stelle e s'era messo in testa un buffo cappellino conico ornato di minuscoli campanellini - Hai inteso il bando, Giovannino? - Oh ch'io son sordo forse? - rispose quello seccato. - Allora se vuoi assicurare per il futuro una vita comoda e agiata ad entrambi, occorre che tu trovi questo benedetto fiore che non ha profumo. - Mi sian testimoni gli astri che già da molti dì il problema m'angustia e credo d'aver trovato la logica soluzione. Porgimi orecchio.- Fece una pausa e poi riprese:- Io opino che se tal fiore esistesse qualcun l'avrebbe già trovato. Poiché non l'han trovato, vuol dir che non c’è. - Bravo, Giovannino! Parli bene, ma non concludi niente. Qui ci vogliono fatti, non parole. Il bacherozzo scosse il capo guardando Brunello. - O giovin impulsivo ch'attendere non sa la conclusione. S'io dico che il fior non c'è, non vuol dir che non esista: vuol dire che non è dove tutti l'han cercato. M'approvi? - T'approvo. - E dove l'han cercato? - In tutti gli angoli della terra. - Vuol dir che sulla terra non havvi fior senza profumo. - Ma la profezia dice che la principessa potrà risvegliarsi solo se odorerà tale fiore; ciò vuol dire che da qualche parte un fiore senza profumo deve pure esistere. E se non è sulla terra, dove può nascere? - Nel mare. Il giovane sbarrò gli occhi, stette un attimo a riflettere, poi disse: - Perdinci, Giovannino, hai ragione! Come sempre. - Non è che la ragion sia sempre mia, - puntualizzò il bacherozzo col suo solito tono di sussiego e aggiunse: - Il fatto è che io giammai ho torto! Ciò detto rientrò nella castagna. Il giorno dopo Brunello, resa un'ultima visita alla principessa, partì alla volta del mare di cui aveva sempre sentito parlare ma che non aveva mai visto. Una settimana appresso, quando, raggiunta la sommità di una collina vicina al mare, Brunello si trovò di fronte a una immensa distesa azzurra simile a un cielo rovesciato, fu preso dallo sconforto. Se quello era il mare, addio speranze! Cercare un fiore là sotto? Assurdo solo il pensarlo. Il giovane sconsolato si sedette ai piedi di un pino, si prese la testa tra le mani alla ricerca di qualche soluzione. Alla fine però, non riuscendo a cavare un ragno dal buco, ritenne opportuno chiamar fuori il bacherozzo dalla castagna. - Ti decidesti alfin a chiedere aita! - fece serio il bacherozzo. - Sol io so quel che occorre, messer Brunello. - E allora dimmelo! - Presta orecchio. Poiché il mio vasto saper abbraccia pure il linguaggio dei pesci, ti spiegherò il da farsi, ma pria munisciti d'un lungo calamo e di refe. - Calamo, refe! E che sono? - O giovin ignorante e indotto che m'induce ad usar volgare eloquio! Il calamo è una canna e il refe è il filo. Lega un capo del secondo alla canna e all'altro capo lega la mia magion... - E vedendo Brunello far cenno di non aver inteso, -...la castagna, messere, lega all'altro capo la castagna! Poscia, dopo ch'io mi sarò introdotto in essa, cala tutto in fondo al pelago e attendi. All'occaso del sol tirami su. Or datti da fare, messere, mentre io tinteggerò la mia cute sotto questi caldi raggi dorati, - concluse togliendosi la maglietta e il cappello e sdraiandosi in cima alla castagna. Un'ora dopo Brunello, eseguiti gli ordini, seduto su un alto scoglio con la canna in mano, calava in mare la castagna e Giovannino che per l'occasione aveva indossato un elegante costume da bagno a righe blu. Il resto della giornata passò lentamente e a sera il bacherozzo intirizzito venne tirato a galla e sistemato da Brunello in un buco scavato nella sabbia ancora calda. - Che hai saputo, Giovannino? - Calma, messere, calma! - Il bacherozzo si avvoltolò ben bene nella sabbia e poi riprese: - Ho risolto l'enigma del fior privo d'olezzo. Me lo svelò una sardella, amica mia, dopo lunga concione. Ascolta: s'erge lungi da qui, su un'isola, il Castello Nero, proprietà d'un pirata. Ivi, sotto il livello del mare, avvi un giardino fiorito e in esso nasce il fior senza profumo. - E come si fa per coglierlo? - Qui sta il dilemma, messere! Quel truce masnadiero ceder non vuol neppure un petalo. Altro non so... Ah, sì, - fece dopo una pausa, - l'amica sardella mi disse pure che il padrone del castello, uomo molto avaro cui piace solo ammassar denaro, trascorre il suo tempo nel nobile gioco degli scacchi. Brunello trascorse la notte insonne a ragionare su quanto aveva appreso e su come poterlo sfruttare. Ma non venne a capo di nulla per cui, al sorgere dell'alba si incamminò costeggiando la riva del mare e due giorni appresso giungeva in una città costruita attorno ad una baia in cui dondolavano pigre molte barche. Brunello, cammin facendo, aveva continuato a pensare e, aiutato da Giovannino, aveva tracciato un piano che, se ben condotto, gli avrebbe permesso di impadronirsi del fiore senza profumo. Dopo aver girato a lungo per le strade della la città odorose di salmastro e aver chiesto a molte persone, riuscì alla fine a scovare l'uomo adatto al suo scopo. Era costui un mercante che si era completamente rovinato con commerci sbagliati. Viveva stentatamente con quel poco che gli era rimasto e amava trascorrere le sue giornate giocando a scacchi, un gioco al quale, si diceva, non avesse rivali. - Signore, - gli chiese Brunello non appena gli fu davanti, - sarebbe capace di battere agli scacchi il pirata del Castello Nero, naturalmente dietro lauto compenso. - Quanto? - chiese il mercante. - Dica lei il prezzo. - Cento scudi d'oro. - Sta bene. Allora si procuri una barca per raggiungere il Castello Nero. - Per la barca voglio altri cinquanta scudi d'oro. - Sia! - disse Brunello cui il prezzo interessava poco. E, tratto di tasca il borsellino di cuoio, disse: - Voglio centocinquanta scudi d'oro. Un istante dopo gli scudi stavano impilati sul tavolo davanti al mercante sbalordito. L'indomani Brunello e l'ex mercante si imbarcavano alla volta dell'isola dove sorgeva il Castello Nero. Il pirata dall'alto della torre del castello aveva visto la barca avvicinarsi, e aveva accolto i passeggeri con una certa diffidenza, ma poi, saputo che il mercante era addirittura venuto per sfidarlo ad una partita a scacchi, si rallegrò. Non gli accadeva sovente di poter affrontare avversari degni della sua fama per cui li invitò ad entrare nel castello. Brunello, prima che la partita avesse inizio disse: - Io avrei una proposta da fare. Perché non ravvivare la sfida con una scommessa? Se vince il mio amico mercante lei mi darà il fiore senza profumo che nasce nel suo giardino in fondo al mare. Se, invece, vincerà lei io le darò questo borsellino di cuoio. A quella proposta il pirata si infuriò. - Vuoi prendermi in giro, giovincello? Il mio fiore contro un borsellino usato! - Calmatevi, signore, questo non è un borsellino comune. Questo è fatato. Guardi! Brunello prese il borsellino tra le mani e, tenendolo capovolto, ordinò: - Borsellino, voglio mille scudi d'oro. Una cascatella di monete prese a sgorgare dalla bocca del borsellino e ad ammucchiarsi sul tavolo. A quella vista gli occhi del pirata si accesero di cupidigia. - Accetto, - disse e subito batté le mani. Al servo prontamente accorso ordinò: - Porta qui il mio tavolo da scacchi e i pezzi per giocare. Poi va dal giardiniere e digli di portarmi il fiore senza profumo. Va! Poco dopo alcuni servi entravano recando un elegante tavolino di madreperla,su cui era disegnata una scacchiera, una scatola di scacchi in avorio bianco e nero e un vaso dal quale spuntava un fiore rosso simile ad una rosa, con il gambo di corallo e i petali di spugna. Brunello rimase per un poco estasiato a guardare quella meraviglia, la sola al mondo che avrebbe potuto risvegliare la principessa Lucina, mentre il mercante e il pirata, presi dalla passione del gioco, davano inizio alla partita. Poi distolse gli occhi dal fiore per seguire i due contendenti che muovevano i pezzi in silenzio e solo dopo lunghi ragionamenti. Anche Giovannino, uscito dalla castagna e sistematosi su una spalla del giovane, seguiva le fasi del gioco. Le ore cominciarono a passare lentamente mentre un silenzio pesante era caduto nella stanza. Verso sera Giovannino, che aveva seguìto attentamente tutte le mosse, sussurrò in un orecchio al suo amico: - Messere, temo che la singolar tenzone volga per noi al peggio. - Vuoi dire che il mercante sta perdendo? - Intendesti il vero. - Giovannino, ti supplico! Aiutami tu se no Lucina è perduta per sempre. Il bacherozzo si agitò a lungo prima di rispondere. Si mise il cappello sulle ventitre, se lo tolse, se lo rimise di nuovo e poi disse: - Se la sardella il ver mi confidò, messer pirata è uomo molto avaro. Ordunque, dice un vecchio adagio “Se all'avaro fai sentire il suono del denaro, diventa peggio d’un un somaro”. Quindi, mio giovine amico, principia a rallegrar il silenzio col dolce suono dei dorati scudi. Brunello capì al volo. Affondate le mani tra le monete che erano rimaste sul tavolo, prese a farle tintinnare ogni volta che toccava al pirata fare una mossa e quello, perdendo il filo del ragionamento, cominciò a sbagliare, a confondersi a tal punto che l'improvviso e roboante grido di “Scacco matto!”, lanciato dal mercante, lo mise con le spalle al muro. - Avete perso, messere, - gli disse Brunello prendendo il vaso e lasciando il borsellino che, ormai esauditi i tre desideri, non serviva più. Poi rivolto al mercante: - Ora possiamo anche andare. Stavano per avviarsi quando il pirata, sbarrando loro il passo, cominciò a urlare: - Ah no! non sia mai detto che io mi lasci portar via il fiore più prezioso del mio giardino. A me, guardie! Afferrate costoro! Alcune guardie si precipitarono nella stanza e fecero per gettarsi addosso ai due uomini quando Brunello, afferrati a manciate gli scudi che stavano sul tavolo, si diede a gettarli verso i nuovi arrivati i quali, dapprima sorpresi e poi interessati da quei nuovi proiettili, si gettarono a terra per raccoglierli, dimenticando gli ordini del loro padrone, pure lui, in ginocchioni. - State tutti lontano! - urlava. - Gli scudi sono miei e guai a chi li tocca! I fuggitivi intanto, non più inseguiti, raggiunsero la barca e levata la vela, si diressero verso terra. Dieci giorni dopo Brunello e Giovannino facevano ritorno a Zamira. Si presentarono al re e gli chiesero di aprire l'urna dove la principessa Lucina continuava a dormire. Non appena Brunello le pose lo strano fiore tra le mani, si vide la fanciulla muoversi lentamente, portarlo vicino al viso, odorarlo e spalancare gli occhi sorridendo ai presenti. Il re dalla gioia abbracciò così strettamente il giovane che quasi lo soffocò. Giovannino nel vedere la scena, scosse il capo con un atteggiamento di sufficienza. - Mio Dio, che ineducato quel sire! Qual mancanza di tatto regale! E' pur vero che l'uom talvolta perde il ritegno per cose di poco conto. In fondo, che era successo? Una fanciulla dormìa; or s'è svegliata. Tutto qui. E rientrò nella castagna, sdegnato nel vedere il suo protetto abbracciare la principessa e ancor più nel vedere il re che, saltellando attorno ad essi, batteva le mani dalla gioia come un bambino.
Titino aveva molti difetti, ma il più evidente era quello di dimenticare sempre qualcosa. Quando stava in compagnia degli amici si dimenticava che il tempo passa e giungeva a casa quando tutti avevano già mangiato; dimenticava a scuola libri e quaderni (ma forse questa era una dimenticanza voluta perché così evitava di fare i compiti a casa); quando giocava a calcio o a pallacanestro non ricordava mai la squadra di cui faceva parte per cui non era raro che facesse degli autogol o degli autocanestri... Insomma, Titino dimenticava sempre le cose essenziali. Una sera, dopo aver visto un film horror alla TV si ricordò all'improvviso di... essersi dimenticato di fare i compiti - Dai, Lucia, - disse alla sorella, una secchiona, prima della classe, sempre col naso sui libri, - dai, dammi una mano. Ho due problemi da fare. Dai, aiutami! - Quanto mi paghi? Questo, invece, era il difetto di sua sorella: non faceva mai niente per niente. Per lei ogni lavoro doveva essere pagato e profumatamente. - Che vuoi che ti dia! Lo sai che non ho niente. - E le mille lire che papi ti ha rifilato stamani? Altro difetto di Lucia era la curiosità. Non accadeva nulla che lei non vedesse e non sapesse. - Ma quelle mi servono per comperare una biro. - O mi dai le mille lire o non ti aiuto. - E poi io con che cosa scrivo? - Te la regalo io una biro. Proprio stamattina ne ho trovata una andando a scuola. - Sempre la solita fortunata! Ma sei sicura che scriva? - L'ho provata e scrive. Allora, Titino, prendi o lasci? Titino avrebbe fatto volentieri a botte piuttosto che consegnare le mille lire a quell'arpia, ma c'erano alcuni motivi che lo trattenevano, primo fra tutti il fatto che Lucia giocava spesso a pallavolo e aveva una schiacciata micidiale. Possedeva delle mani che sembravano racchette e un suo manrovescio lasciava sempre il segno e poi... e poi perché stare ad elencare gli altri motivi quando il primo bastava? Per cui Titino, tirato fuori di tasca un piccolo borsellino in cui custodiva gli spiccioli e le mille lire, prese il biglietto e, con un sospiro degno del re degli avari, lo porse alla sorella assieme al quaderno. Lucia afferrò il biglietto, lo mise nella scollatura della camicetta e poi prese il quaderno, l'aprì, lesse il testo dei due problemi e cominciò subito a scrivere. Quattro minuti dopo aveva finito. - Eccoti il quaderno, Titino. Era troppo facile: anche un asino li avrebbe risolti. - E la biro non me la dai? - rispose il fratello senza rilevare l'insulto alla sua intelligenza. Prese la biro e, con un sospiro disse: - Però, Lucia, potresti anche farmi uno sconto: ci hai messo quattro minuti per risolvere i problemi.Duecentocinquanta lire a minuto, mi sembra una esagerazione. - Ah sì? E allora un'altra volta risolviteli da solo. L'indomani in classe Titino con lo sguardo rivolto al soffitto rimuginava sulle mille lire perdute: il maestro non l'aveva nemmeno interrogato. - Titino, che fai? - gli chiese all'improvviso il maestro. - Calcoli la velocità delle mosche? La battuta del maestro fece ridere i compagni. - E visto che la matematica ti diverte - continuò quella carogna che stava dietro la cattedra, scrivi sul quaderno la seguente divisione: settecentonovantasettemilaquattrocentotredici virgola trecentoundici diviso trentasette virgola centoventuno. Quando avrai finito, mi darai la soluzione. Noi, intanto, - concluse, sorridendo, rivolto alla classe - noi abbiamo tutto il tempo per commentare la poesia di... - Signor maestro, - lo interruppe Titino - fa esattamente ventunmilaquattrocentottantuno col resto di diciassettemila centodieci. Il maestro lo guardò dapprima senza capire e poi, scattando infuriato: - Titino, non essere insolente. Per punizione ti metto un due sul registro. - Ma guardi che la divisione è giusta! - piagnucolò Titino. - Almeno faccia la prova, signor maestro, - insistette con le lacrime agli occhi, - mi ha detto di fare la divisione e a me viene così. - Ma se non hai nemmeno avuto il tempo di scrivere i numeri e già mi dai la soluzione? Comunque vediamo. Il maestro andò alla lavagna e cominciò a scrivere. Ci mise qualche minuto a scrivere tutti i numeri che la divisione richiedeva e alla fine si voltò col atteggiamento meravigliato. - Hai ragione: è giusto. Mi dici come hai fatto? - Be', io ho scritto subito la soluzione. M'è venuta così. - Ti è venuta così, vero?- ripeté il maestro, facendogli il verso. E poi, con un cipiglio feroce, disse: - E allora scrivi! Se sei metri e mezzo di tappezzeria costano ventiseimila lire, quanto costeranno tre metri e mezzo? Hai scritto? - Sì, - disse Titino - costeranno quattordicimilalire, Il maestro guardò il libro dal quale aveva tratto il problemino e che conteneva anche la soluzione. Poi guardò sempre più stupito Titino che si era messo la biro in bocca. Poco convinto, scese dalla cattedra portando con sé il libro dei problemi e si avvicinò al banco del ragazzo. - Scrivi, - gli ordinò cominciando a dettare.- Se sette uomini su cento sono criminali, quanti uomini su cinquecento non sono criminali? Titino scrisse velocemente e dopo l'ultima parola "criminali" aggiunse il segno di uguale e subito dopo, senza apparentemente pensarci, scrisse: 465. - Quattrocentosessantacinque, signor maestro, - fece Titino alzando il viso. - Ah, questa poi! - Il maestro era trasecolato... ma non ancora convinto, - Adesso non scrivere e ascoltami soltanto. A dieci navi occorrono dieci giorni per consumare dieci serbatoi di petrolio. Quanti giorni occorreranno ad una nave per consumare un serbatoio? Titino, con la biro in mano e la mano appoggiata al quaderno, fissò il maestro con occhi stupiti. Non aveva capito niente: giorni, navi,serbatoi, petrolio, dieci... Le parole gli turbinavano in testa e creavano una grande confusione. Chinò gli occhi sul quaderno, guardò l'ultimo numero che aveva scritto e lo lesse ad alta voce. - Dieci - disse. Stavolta il maestro non aggiunse altro e si diresse verso la cattedra, voltandosi di tanto in tanto a guardare il ragazzo il quale, a sua volta lo guardava con una faccia inespressiva. Ma chi l'avrebbe mai detto, pensava l'insegnante, che quel moccioso avesse il pallino della matematica! Non se n'era mai accorto. Sfogliò il registro e in corrispondenza del nome Rossi Titino non trovò altro che delle insufficienze in tutte le materie, matematica compresa. - Signor maestro, me lo mette lo stesso il due? - No, per questa volta passi. Ma sta più attento. All'uscita della scuola i compagni lo accerchiarono. Volevano sapere come aveva fatto a risolvere i problemi così velocemente. Per fortuna venne Lucia a liberarlo perché non avrebbe saputo che cosa rispondere. Non capiva nemmeno lui che cos'era successo. O meglio, era stata una cosa semplice: il maestro dettava il problema e lui subito aggiungeva la soluzione. Però quando il problema non l'aveva scritto ma solo udito dalla voce del maestro, la soluzione non gli era venuta. Perché? Per fortuna aveva detto un numero a vanvera, l'ultimo che aveva visto scritto sul quaderno: quel dieci che, guarda caso!, era la soluzione. Titino si fermò di colpo ricordandosi all'improvviso di una cosa che aveva dimenticato. Aprì la cartella e prese a sfogliare velocemente il quaderno. Ecco, sì era proprio come pensava. L'ultimo numero che aveva scritto sul quaderno era quattrocentosessantacinque: e allora, da dove sbucava fuori quel dieci, cioè la risposta alla domanda del maestro? Chi l'aveva scritto? - Dai, Titino, ti vuoi muovere? Sbrigati, se no oggi le buschi! - gli gridò la sorella che si era voltata e l'aveva visto fermo col quaderno in mano. - Ai compiti penserai dopo. Con la testa in tumulto Titino riprese a camminare. Che cosa gli succedeva? Chi o che cosa l'aveva aiutato a risolvere i problemi? Eppure non c'era stato nulla di diverso dai giorni precedenti. Nulla di nuovo ... tranne la biro che Lucia gli aveva dato il giorno precedente in cambio delle mille lire. “Che c'entrasse la biro?” pensò. “Che sciocchezza!” E si diede dello stupido per aver pensato ad una cosa così... così stupida. Raggiunse velocemente la sorella e, guardando verso il cielo che minacciava pioggia, le disse: - Guarda, Luci, sta per piovere: che ne dici di una corsetta a chi arriva primo al portone di casa? Naturalmente giunse secondo e col fiatone. Ma Titino non se la prese perché succedeva sempre così. Lucia con quelle gambe da trampoliere era imbattibile nella corsa. L'unica cosa che l'amareggiò fu che quel pomeriggio, se continuava a piovere, non avrebbe potuto andarsene a giocare in cortile. La pioggia continuò per cui fu giocoforza mettersi a fare i compiti prima di guardare la TV. Titino si sedette al tavolino e sfogliò il diario. Per l'indomani doveva svolgere un tema e risolvere alcuni problemi. Ricordando la fortuna del mattino, cominciò con quelli. Chissà: forse il momento magico perdurava! Trascrisse i problemi sul quaderno. Evviva! La fortuna era ancora dalla sua parte perché subito dopo le domande, sentì che la sua mano era spinta a scrivere immediatamente le risposte. Titino non stava più in sé dalla gioia. Si voltò contento verso la sorella intenta a leggere un romanzo rosa per svelarle quanto gli stava accadendo, ma se ne astenne. Se Lucia l'avesse saputo avrebbe preteso la restituzione della biro. Meglio mantenere il segreto e non farne partecipe nessuno. Prese il quaderno a righe e trascrisse il titolo del tema. Si augurò che la magia funzionasse anche nello svolgimento dei temi! Infatti, se la matematica per lui presentava molte difficoltà, ancor più ne presentava l'affrontare un tema. Stava delle ore di fronte al foglio bianco in attesa di qualche idea e quelle poche che germogliavano dopo sforzi immani erano così sciocche, banali e peregrine da meritarsi l'insufficienza che immancabilmente il maestro gli appioppava. Ma quel pomeriggio non fu così. Dopo aver dato una occhiata oltre i vetri rigati dalla pioggia, Titino appoggiò la punta della biro sul foglio e vide la sua mano correre veloce. Sembrava che la biro scrivesse da sola. E che frasi! Nemmeno Lucia, la secchiona, sarebbe riuscita a scrivere quelle cose. Quando la biro smise di scrivere, (perché Titino finalmente l'aveva capito: a fare tutto era quella biro magica regalatagli dalla sorella il giorno prima), si trovò di fronte ad un compito perfetto. Lo testimoniò persino il maestro quando all'indomani lesse il suo tema a tutta la classe - Chi ti ha aiutato, Titino? - gli chiese con una punta di sospetto. - Nessuno. Ho fatto tutto da solo. Può chiederlo a mia sorella: era presente mentre lo scrivevo. - Vedremo - fece quello scettico, scuotendo il capo. E da quel giorno Titino diventò famoso per la sua bravura tanto da essere elogiato persino dal maestro che aveva sempre dubitato di lui. Beninteso il ragazzo si guardò bene dallo svelare a qualcuno la fonte della sua bravura... e continuò a vivere di rendita. Ai compiti non ci pensava più perché la biro magica glieli risolveva velocemente; i temi gli venivano che era un incanto. Perché, dunque, sforzarsi a studiare? Era meglio trascorrere la maggior parte del tempo a giocare in cortile. Le giornate si erano allungate e il sole sembrava aver preso perenne possesso del cielo. Quell'anno la scuola sarebbe durata una diecina di giorni in più perché c'era da superare l'esame per il passaggio alla scuola media. L’esame impauriva tutti i suoi compagni, ma faceva ridere Titino. Quando qualcuno gliene parlava, rideva. Lui aveva l'arma segreta: la biro magica. - Non preoccupatevi per il problema, - diceva agli amici. - Sedetevi vicino al mio banco e per mille lire vi suggerirò la soluzione. L’idea delle mille lire gli era venuta dalla precedente esperienza con sua sorella. - E per altre mille aggiungeva - vi faccio pure il tema. Molti suoi compagni si erano prenotati, tanto che il maestro si stupì il giorno dell'esame nel constatare che tutti facevano a gara per sedersi nei banchi attorno a quello di Titino. Finalmente venne il direttore con un foglietto in mano per dettare il titolo del tema. Sventolandolo tra le dita, disse: - Ragazzi, la commissione ha scelto un tema facile. Vi faccio una sola raccomandazione: pensate bene prima di scrivere e se avete dei dubbi su qualche parola non esitate a consultare il vocabolario che abbiamo messo sulla cattedra. Nei limiti del lecito potrete anche consultarvi con il vostro insegnante, ma non prendetevela con lui se non potrà esservi di aiuto come faceva durante l'anno scolastico. Quello di oggi è un esame e tutti devono fare da soli e dare il meglio di sé. Ed ora scrivete il tema. "Un anno di scuola è terminato. Speranze e progetti per il futuro". Cari ragazzi, buon lavoro. Titino, appena scritto il titolo del tema, si guardò attorno. Vide i volti corrucciati dei compagni i quali, nonostante l'affermazione del direttore, avevano trovato il tema non proprio facile. Sorrise con sufficienza, guardò attraverso la finestra il cielo sereno e, appoggiata la mano sul foglio, scrisse: "Svolgimento". Poi, fiducioso, toccò la prima riga con la punta della biro e attese. La biro rimase immobile. Provò a premere sulla carta e a tirare una riga, ma non rimase sul foglio che un solco bianco. La biro non scriveva. "Ma che succede? " pensò. E in quel momento gli venne un dubbio atroce. Il suo difetto! Il suo tremendo difetto! La dimenticanza. Come al solito, Titino aveva dimenticato una cosa molto semplice. Si era dimenticato che anche le biro, come tutte le cose di questo mondo, si consumano e dopo un po' di tempo non scrivono più. La biro di Titino era completamente vuota, scarica, priva di inchiostro e non avrebbe mai più scritto! Con gli occhi sgranati e la mente completamente assente, Titino rimase a fissare il cielo sereno e le rondini che volavano alte e si perdevano nell'azzurro. Le guardava con la bocca spalancata incurante di quanto accadeva attorno. E così rimase sino al suono della campana.
Aveva visitato il paese di Fratta di Sopra (200 metri di altezza sul mare, 3000 abitanti) una sola volta durante i suoi lunghi giri in macchina e quel borgo popoloso gli era piaciuto, tanto da eleggerlo sua ultima dimora il giorno in cui aveva deciso di andare in pensione. E così, l’esimio professor Servadei, buttatosi alle spalle i clamori e soprattutto gli odori della città, si era trasferito in una villa con giardino, portando con sé oltre ai mobili cui era affezionato anche la sua ricca biblioteca dalla quale solo la morte l’avrebbe diviso. Una villa accogliente, un giardino con molti alberi, lo studio profumato dall’odor dei libri, una anziana governante che lo accudiva come un figlio: che volere di più? Il professor Servadei aveva trovato il suo Eden e avrebbe tenuto tutti fuori da esso se non fosse stato per una forma di cortesia verso gli altri e per i buoni rapporti con il vicinato. Il primo a fargli visita dopo il suo arrivo era stato il sindaco di Fratta di Sopra. Era venuto a trovarlo in compagnia della moglie per portargli il saluto suo e di tutti i frattesi. La coppia, quando la governante l’aveva introdotta nel salotto, aveva subito destato la curiosità del professore. Lui, il sindaco, era vestito austeramente, in giacca grigia, camicia bianca con colletto rigido, un’austera cravatta, cappello a lobbia e scarpe scure, lucidissime. La moglie paludata in uno sgargiante abito a fiori rossi e blu con un cappellino di paglia di Firenze dal quale, appeso ad un nastro giallo, pendeva un grappolo di ciliege. Ma non era stato tanto l’abbigliamento dei due a colpire il professore, quanto la loro corporatura: lui secco, secco come una acciuga, e lei rotonda, simile ad un porcellino rosato. Quale ex insegnante di italiano al professor Servadei era subito balenato davanti agli occhi il pronome “IO” (una bella I magra magra e una O tonda come un barilotto) cui subito si era affiancata, rovesciando le lettere, l’interiezione “OI”, nel senso di “Oilà, che strana coppia!”. Ma, ovviamente, non aveva lasciato trasparire nulla dei suoi pensieri e si era limitato a fare il perfetto padrone di casa. Li fece accomodare e poi chiese alla governante di portare dei pasticcini e del rosolio. I due uomini trascorsero un’oretta piacevole, parlando un po’ di tutto e il professore lodò il sindaco per la sua cultura e per le sue ampie conoscenze letterarie. La moglie, invece, non aprì quasi bocca, tranne che per ingozzarsi di pasticcini e per bere il rosolio. Alla visita del sindaco ne erano seguite altre. Venne il medico, il farmacista, il notaio, il prete, due avvocati, alcuni insegnanti delle scuole elementari e della scuola media. Tutti i rappresentanti più autorevoli di Fratta di Sopra. Dapprima il professor Servadei non ci fece caso, ma alla lunga la cosa non poteva passare inosservata, tanto più che il professore era un acuto osservatore. Un giorno, mentre se ne stava seduto in giardino a guardare gli uccelli volare, passando in rassegna tutta l’élite culturale di Fratta di Sopra che gli aveva fatto visita, si accorse di un fatto strano: tutte, ma proprio tutte le persone più autorevoli del paese erano magre, di una magrezza impressionante. Nel numero dei visitatori non includeva le mogli o i mariti degli intellettuali di Fratta di Sopra perché, lo aveva constatato di persona, quelli erano tutti grassottelli o decisamente grassi e avevano tutti un basso livello culturale “To! Ma guarda un po’ che stranezza! Sembra che a Fratta di Sopra gli intelligenti e gli eruditi siano solo i magri.” - pensò tra sé e sé. - “Che la magrezza sia la prerogativa degli intelligenti?”. Pensò ai suoi colleghi di Università e se li vide passare tutti davanti, alcuni di corporatura normale, altri rotondetti e altri decisamente grassi. I magri erano una minoranza. Distolse gli occhi dal volo degli uccelli e lo abbassò sulla sua pancetta. “No, - concluse mentalmente - l’intelligenza non è una prerogativa dei magri. E allora perché a Fratta di Sopra gli intelligenti erano tutti magri? Il problema lo affascinava e, dato il suo amore per l’enigmistica, risolvere i problemi lo stuzzicava. E cominciò a pensare. Una prima soluzione gli si affacciò subito alla mente: il clima del luogo e l’aria salubre agivano e producevano un effetto particolare sulle cellule grigie. Ma l’aria la respiravano tutti, quindi la soluzione non consisteva nel clima e nell’aria. Doveva trovarsi in qualcos’altro che agiva solo su determinati individui e non su tutti Decise di recarsi nella piazza principale del paese dove, sotto il tendone del Bar degli Amici, sostavano in permanenza molte persone anziane. Forse, parlando con loro, avrebbe potuto capire qualcosa. Si sedette a fianco di alcuni vecchietti che lo conoscevano per averlo visto spesso passeggiare per il paese e, dopo i convenevoli d’uso, chiese: - Mi sapete dire se esiste qui vicino una sorgente d’acqua potabile? - Certo che esiste! C’è la Fonte della Dragorina. Dicono sia una sorgente miracolosa. Si figuri, professore, vengono persino dai paesi vicini per riempire fiaschi, bottiglie, alcuni anche damigiane. - Miracolosa perché? - Fa pisciare molto - disse un vecchio mezzo sdentato. - Giosuè, non essere volgare col professore! - lo redarguì il vicino. - E che ho detto di male! Io ogni sera me ne bevo mezza bottiglia e di notte debbo alzarmi più volte... per fare la pipì. Ti sta bene quest’ultima parola? - disse al vicino che lo aveva redarguito. Quello gli rispose con un’alzata di spalle. Il professor Servadei ci pensò un poco. La soluzione non gli calzava. Come l’aria che tutti respiravano, anche l’acqua era bevuta da tutti. No. Ci voleva qualcosa che limitasse, che restringesse la cerchia di chi ne faceva uso. - Giosuè, - disse un vecchietto - se prima di andare a letto tu bevessi qualche bicchiere di Parrosso invece di acqua, forse non ti alzeresti tanto spesso. - Che cos’è il Parrosso? - domandò il professor Servadei. - Non conosce il Parrosso, professore? - Mai sentito nominare. - Il Parrosso è un vino locale. Ha un profumo da far resuscitare i morti. - Strano nome. - Il nome ha dietro di sé una storia, - prese a raccontare un vecchietto che se n’era stato sino ad allora in silenzio. - Me la raccontò il mio bisnonno. Deve sapere, professore, che nel 1797 quando Napoleone venne in Italia per combattere contro i cruchi, passò da queste parti. Era molto accaldato e un contadino di Fratta di Sopra gli offrì un bicchiere di vino. Il Generale lo bevve tutto e, dopo aver ripreso fiato, con un sorriso e un cenno di meraviglia, esclamò: “Parbleu!”. Al che il contadino stupito (era stato in Francia e masticava un po’ di francese), dopo aver guardato attraverso la bottiglia che teneva in mano, osservò: “Ma che ‘par bleu’, generale, a me ‘par rosso’! “ E da allora il vino si chiama così. Dopo aver ascoltato il racconto del vecchio, il professore pensò: “ E se le proprietà che sto cercando di individuare stessero proprio nel vino locale? Ne voglio subito parlare col medico.” Ringraziati i vecchietti si diresse verso l’ambulatorio, deserto a quell’ora del pomeriggio. - Salve dottor Parenzi. - Professore! I miei omaggi. Non si sente bene? - Faccio gli scongiuri ma mi sento benissimo. Sono venuto per rivolgerle alcune domande e solo lei può fornirmele. - Mi dica. - Ecco: io so che esistono ormoni che determinano la crescita degli individui, vorrei sapere se esistono anche ormoni che influiscono sul corpo facendolo dimagrire. - Ormoni specifici non saprei, dovrei fare qualche ricerca. Posso, comunque dirle che se una persona è affetta da malattie depressive o da ipertiroidismo può dimagrire in breve tempo. - Il vino può far dimagrire? - Non credo proprio. Guardi me come sono magro. Se il vino facesse dimagrire, qualcuno, vedendomi potrebbe pensare che io sono un incallito bevitore: e, invece, sono totalmente astemio. Perché mi pone queste domande? - A dir la verità non lo so neppure io. Dopo averlo salutato, il professor Servadei si accommiatò per ritornare a casa. Camminava a testa bassa quando una voce nota, quella del sindaco, interruppe i suoi pensieri. - Caro professore, beato lei che se ne va a passeggio! Io, purtroppo, debbo andare a rintanarmi in Comune. - Non la invidio. Con questa bella giornata non mi andava di starmene rintanato tra i libri. Si suda troppo. Beato lei che non suda mai! - aggiunse il professor Servadei, detergendosi la fronte con un fazzoletto e guardando il viso del sindaco, magro, quasi scheletrico, completamente asciutto. - Mi dica, signor sindaco, - aggiunse, seguendo una idea improvvisa balzatagli alla mente, - dove potrei trovare delle fotografie del passato su Fratta di Sopra e sui suoi abitanti? L’uomo ci pensò un poco e poi rispose: - L’unico che la possa aiutare è il fotografo Gaudenzi. Quello è un poco l’anima di Fratta di Sopra. E’ un ricercatore locale: si figuri, conserva fotografie che risalgono addirittura ai dagherrotipi dell’800. Se vuol sapere qualcosa, lui conosce tutto sulla storia del paese. Lasciato il sindaco, il professor Servadei si diresse verso il negozio del fotografo. Lo trovò nel retrobottega intento a sistemare foto in un album. Dopo avergli esposto il problema i due si diedero a sfogliare vecchi album. Dentro c’era di tutto, ma in quel momento non era la fotografia in sé ad interessare il professore, quanto la corporatura dei soggetti fotografati. Per ognuno chiese al fotografo chi fosse, e anche il grado di intelligenza. Sulle prime il Gaudenzi, un omettino piccolo, rinsecchito, magro da far paura, lo guardò stupito, poi rispose senza porsi domande. Il risultato di quella visita e di quelle domande fu infruttuoso: anzi confermò l’idea che non vi erano differenze tra grassi e magri per quanto concerneva il grado di preparazione intellettuale e di intelligenza. Allora, perché, attualmente, nel paese di Fratta di Sopra, solo i magri erano intelligenti, mentre gli altri, normali o grassi che fossero, erano gente comune che non brillava certo per acume e per conoscenze generali o particolari? - Forse, professore, potrà trovare notizie utili nella biblioteca comunale - gli aveva suggerito il fotografo quando si erano salutati. “Già, la biblioteca comunale!” - pensò. Sapeva della sua esistenza per averne sentito parlare, ma non era mai andato a visitarla. Gli bastava la sua che, per i suoi bisogni e studi, era fornitissima e sufficiente. Si recò in comune dove era certo di trovare il sindaco. - Finita la passeggiata, professore? - lo accolse il primo cittadino. - Quasi, ma prima di concluderla mi è venuto il desiderio di visitare la biblioteca. Il signor Gaudenzi, il fotografo, mi ha assicurato che è fornitissima. - Altroché se lo è: con tutti i soldi che spendiamo! Si dice sia la più fornita di tutto il circondario. - Si può visitare? - Attenda che le chiamo l’usciere. - Non si disturbi: mi rivolgerò al bibliotecario. - Ma non esiste un bibliotecario. C’è solo l’usciere. Il professor Servadei non insistette con le domande. Gli parve strano che una biblioteca ‘fornitissima’, come aveva detto il sindaco, non avesse un bibliotecario, ma non lo disse. Talete, l’usciere, si presentò strascicando i piedi e borbottando. Guardò il professore e gli fece cenno di seguirlo. La biblioteca si trovava poco distante dal municipio, sistemata a piano terra di un edificio a due piani. L’usciere aprì il portone. Dava su un ingresso illuminato da un’ampia finestra. La luce batteva su alcuni tavoli circondati da seggiole. - Questa è la sala di lettura, - disse l’usciere Talete. - Così l’ha lasciata il Marchese Vivaldi e così è rimasta da tanti, molti anni. - Chi è il Marchese Vivaldi? - Non lo sa? Si segga e glielo spiego. Si sedettero attorno al tavolo e l’usciere cominciò a raccontare. - Il Marchese Vivaldi era un uomo strano, eccentrico. Viveva appartato in questa casa. Aveva diseredato tutti i suoi parenti e impiegava le sue sostanze solo per comperar libri, grandi quantità di libri e per ammassarli nella sua biblioteca. Sosteneva che i libri danno la cultura e l’intelligenza e solo chi li legge può farsi strada nel mondo. Chi non legge rimane ignorante: è uno che non vive ma vegeta. Il bello è che il Marchese Vivaldi non aveva mai letto nessuno dei suoi libri. Quando morì lasciò in eredità la sua biblioteca a tutti gli abitanti di Fratta di Sopra, lasciò questa villa e lasciò anche una cospicua somma con la quale stipendiare un bibliotecario e continuare ad acquistare sempre nuovi libri per incrementare quelli gia esistenti. - Un’ottima idea. - Ottima sì, solo che col passar del tempo gli interessi dei soldi da lui lasciati non bastarono più per entrambe le cose e il Consiglio Comunale si trovò di fronte ad un problema: o continuava a pagare il bibliotecario, ma allora non si potevano più acquistare libri o si acquistavano i libri e si mandava a spasso il bibliotecario. Il Consiglio Comunale scelse la seconda soluzione. Così da anni si continuano ad acquistare libri. - E alla biblioteca chi ci pensa? - Io. Il professor Servadei lo squadrò dall’alto in basso. Pensò a tutte le biblioteche da lui frequentate, ai metodi di conservazione, di catalogazione, all’esperienza e alla capacità che occorreva per condurre una biblioteca. Sennonché l’usciere Talete era grassottello, quindi, secondo quanto accadeva a Fratta di Sopra, non doveva certo essere eccessivamente intelligente Chissà come faceva! Non glielo chiese: non erano affari suoi.. L’uomo riprese a parlare. - Ma se il Consiglio Comunale aveva pensato di aver risolto il problema, si era illuso perché dopo alcuni anni ne sorse un altro. I libri continuavano ad affluire regolarmente e occorreva sistemarli negli scaffali. E metti oggi, metti domani, ad un certo punto ce li ritrovammo strapieni. Fu l’assessore alla cultura a suggerire una soluzione. “Semplice, - disse in Consiglio Comunale - occorre solo acquistare altri scaffali”. “Già - disse uno dell’opposizione - e poi dove li mettiamo se lo spazio è poco?” “Semplice, - ripeté l’assessore alla cultura - basterà ridurre lo spazio tra uno scaffale e l’altro”. E così fu fatto. - E hanno risolto il problema? - Giudichi lei: venga, le faccio strada così si renderà conto che il problema continua a rimanere irrisolto perché ogni anno continuano ad arrivare mucchi di libri. L’usciere si alzò, si avvicinò alla porta che dava nel deposito dove erano collocati gli scaffali contenenti i libri e l’aprì. Lo spettacolo lasciò stupefatto il professor Servadei. Gli scaffali, alti sino al soffitto, stavano allineati ordinatamente in lunghe file poste le une di fronte alle altre. Parevano alte muraglie che col passar degli anni si erano sempre più avvicinate tanto da ridurre tra esse lo spazio al punto che lui, con la sua pancetta, neppure mettendosi di fianco, sarebbe riuscito a penetrare. Solo una sogliola o un contorsionista molto magro potevano destreggiarsi con qualche risultato per riuscire a cercare e a tirar fuori i libri. E allora il professor Servadei capì. Capì perché gli intellettuali di Fratta di Sopra erano tutti magri come acciughe. SOLAMENTE LORO CON QUEI CORPI ESILI E RINSECCHITI POTEVANO PENETRARE TRA GLI SCAFFALI PER TROVARE I LIBRI DA UTILIZZARE PER FARSI UNA CULTURA. Ai grassi tale possibilità era preclusa. Solo i magri potevano godere dei benefici della cultura. - Con i prossimi arrivi di libri, saremo costretti ad avvicinare ancora di più gli scaffali, chissà come andrà a finire, - disse l’usciere Talete, parlando tra sé e sé. - Già, chissà come andrà a finire, - gli fece eco il professore, pensando al momento in cui tra uno scaffale e l’altro sarebbe scomparso lo spazio per poter passare. Ma queste sono cose che accadono solo a Fratta di Sopra dove, per ora, i magri sono istruiti e i grassi no. A pensarci bene, è proprio così necessario essere tanto istruiti?.
Questa storia è accaduta su Sigma, uno sperduto pianeta della Galassia, lontano migliaia di anni luce dal Sole. Steso sul letto di morte, Massimiano, l'imperatore di tutto il pianeta e sovrano di tutte le genti, teneva stretta tra le sue una mano dell'unico figlio e con voce flebile e malsicura gli stava dando gli ultimi consigli. - Massimino, figlio mio, ricordati sempre che governare è un compito difficile, in particolar modo governare con saggezza. Spesso gli uomini, quelli più sprovveduti, quelli di scarsa cultura, gli analfabeti, non saranno in grado di capirti. Gli altri, invece, coloro che sanno leggere e scrivere, non di rado ti creeranno difficoltà così grandi che solo un monarca previdente, accorto e avveduto saprà superare. Usa, quindi, figlio mio, accortezza e giudizio nell'applicare le leggi e cerca sempre di capire quale potrà essere il bene comune. Ciò detto, morì. Non appena avverti la stretta allentarsi, Massimino, ritirò bruscamente la mano da quelle ormai senza vita del padre; se la pulì accuratamente con un fazzoletto, poi, rivolto ai cortigiani e ai dignitari di corte che facevano corona intorno al letto dell'imperatore morto, con voce sicura e senza ombra di commozione, disse: - Da questo momento sono io il nuovo imperatore e assumo il nome di Massimino il Grande. Così d'ora in poi mi chiamerete. - Guardò altezzosamente i presenti che si erano inginocchiati in segno di omaggio e, puntando un dito verso di loro, aggiunse: - Fulberto, ti nomino mio confidente privato. Seguimi! Ed era uscito dalla stanza senza più voltarsi verso il letto su cui giaceva il padre morto, lasciando stupefatti i cortigiani e i dignitari di corte, prostrati ai piedi del letto. - Questa è fatta, Fulberto! Sono contento di me stesso, - disse appena furono soli, senza specificare se era contento perché il padre era finalmente morto e , quindi, lui era libero di fare quello che voleva o perchè aveva ereditato un intero pianeta. poi, aggiunse: - Però, Fulberto mi devi spiegare le ultime parole di mio padre, perché non ho ben capito che cosa abbia voluto dire. Nello scegliere Fulberto come consigliere fra tutti i cortigiani, Massimino aveva avuto mano felice. Non esisteva, infatti, su tutto il pianeta una persona più astuta, più subdola, più intrigante, più capace di aiutare un sovrano a governare. E' noto che le persone che detengono il potere hanno sempre bisogno di qualcuno che le guidi e che le consigli, perciò a governare sono sempre in due, sebbene il padrone vero non se ne accorga. Il potere assoluto non esiste. - Vedi, maestà, - rispose Fulberto stropicciandosi le mani e guardando Massimino attraverso le spesse lenti degli occhiali, - vedi, durante tutto il periodo di regno di tuo padre i fastidi più grossi gli sono sempre venuti dagli intellettuali, dai filosofi, dagli scienziati, dagli studenti, tutta gente che trascorre buona parte dell'esistenza con una penna in mano e con un libro sotto gli occhi. Maestà, è legge di natura che chi impara pensa; chi pensa ragiona e chi ragiona avanza diritti. Ora se i diritti sono quelli che Sua Maestà ha benevolmente concesso, nulla di male; ma se sono altri... - Allora, - lo interruppe Massimino, - se ho bene inteso, più un popolo è analfabeta, più è facile da governare. Fulberto mandò più volte le labbra in dentro e in fuori, poi rispose: - Direi di sì, anche se talvolta con un popolo ignorante occorre usare il bastone e qualche carota per condurlo dove si vuole. Massimino rimase un poco soprappensiero, quel tanto che gli permise di assimilare la risposta, poi il suo volto si illuminò. - Fulberto, - esclamò - non capisco dove stia il problema dato che la soluzione è tanto facile. Se gli intellettuali creano fastidi, occorre semplicemente che tutti rimangano analfabeti. Perché mio padre non ci ha mai pensato? - Per pensare ci ha pensato, ma qualcuno lo ha sempre dissuaso dal prendere decisioni e poi tuo padre aveva, se mi permetti di dirlo, un gran difetto. - Quale? - Era troppo onesto per governare. - Ma io non sono mio padre. Io sono Massimino il Grande! - disse il giovane ergendosi tutto. - Nessuno oserà dissuadermi. Prendi nota, Fulberto, questa sarà la mia prima decisione: da domani tutte le scuole pubbliche e private del pianeta saranno chiuse. E' fatto divieto a chiunque di imparare a leggere e a scrivere. La pena per ogni trasgressione sarà la prigione. Fulberto scosse il capo. - Cosa c'è che non va? - chiese Massimino guardando accigliato il suo consigliere. - Due cose, Maestà: la prima è che dalla prigione prima o poi si esce... una amnistia, un condono, un po' di buona condotta, un indulto e l'ex prigioniero, dato che le brutte abitudini non si perdono nemmeno con la prigionia, una volta libero, riprende a leggere, a scrivere e così siamo punto e a capo. - E allora, che proponi? - L'esilio invece della prigionia. - L'esilio! E dove? - C'è un isola in mezzo all'Oceano delle Tempeste che è stata visitata una sola volta. Se quell'unico visitatore l'abbia battezzata non si sa, comunque il nome si è ormai perduto nella memoria delle genti tanto che oggi viene chiamata l'Isola Senza Nome. E' così fuori da ogni rotta che nessuna nave vi fa mai scalo. - E come faranno gli esiliati a viverci? - chiese Massimino. - Non intendo certo provvedere a loro, ma non vorrei neppure essere accusato di aver mandato della gente a morire. - Non preoccuparti, Maestà, dalle casse dello Stato non uscirà nemmeno una moneta. Si dice che l'Isola Senza Nome sia molto fertile. Vorrà dire che gli esiliati dovranno fare i contadini, coltiveranno la terra e vivranno di caccia e di pesca. Non avranno così più il tempo di leggere, di scrivere e di insegnare ai loro figli i quali cresceranno analfabeti. Solo allora tu potrai mostrare la tua magnanimità. - In che modo? - Facendo ritornare in patria tutti i giovani nati nell'isola, gente, cioè, incapace di leggere e di scrivere. Che te ne pare? L'imperatore abbozzò un largo sorriso. - Astuto il mio Fulberto, - mormorò tra sé e sé. E poi, ritornato serio, disse: - Sono d'accordo. Provvedi subito ad emanare un bando in tal senso e a diffonderlo. Tu, però, poco fa hai accennato a due cose: qual è l'altra? - I libri, Maestà, i libri! Chiudere le scuole non basta: non è la scuola che dà la cultura, ma il libro. Sono i libri a divulgare le idee, a diffonderle in chi legge,Hai detto giusto! Allora vietiamo anche la pubblicazione dei libri - E quelli già stampati? La risposta di Massimino fu pronta, immediata. Da ragazzo era sempre stato attratto dal fuoco; gli piaceva vedere le fiamme rosse , sibilanti come lingue di serpente, lambire le cose, incenerirle, distruggerle. Quante volte non aveva appiccato il fuoco a stoppie e ad arbusti nel vasto giardino che circondava il castello, rimanendo affascinato a guardare finché non erano accorsi i giardinieri a spegnere ogni cosa! E quelle volte, pur essendo il figlio dell'imperatore, non aveva potuto evitare che si gettasse acqua sul fuoco, perché suo padre aveva sempre dato ragione ai giardinieri Ma ora l'imperatore era lui! Si stropicciò le mani con forza e disse: - Ed ecco la mia seconda legge: Ordino che tutte le tipografie, le librerie, le biblioteche dell'impero siano date alle fiamme e, affinché il mio ordine sia eseguito, dispongo la creazione di un corpo speciale di agenti a cui affidare il compito di bruciar i libri, anche quelli che i cittadini conservano in casa. Voglio vedere fiamme in ogni piazza, fiamme alte fino al cielo. Gli occhi di Massimino, mentre parlava, erano spiritati. Forse vedeva già le sue amate fiamme diffondersi, svilupparsi in un immane rogo che avrebbe arso, ridotto in cenere un patrimonio millenario di idee e di informazioni preziose che sarebbero andate irrimediabilmente perdute. - Chiameremo il corpo speciale degli agenti "La Prometeo", in onore di chi per primo rapì il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. Fulberto si guardò bene dal far notare a Sua Maestà che le intenzioni di Prometeo non erano per nulla simili a quelle di Massimino: ma un buon consigliere sa che non si deve mai dire ai padroni tutto quello che si pensa. Quando la visione di immani roghi svanì dalla mente di Massimino, l'imperatore, guardando attraverso la finestra gli alberi del parco, domandò: - Fulberto, quale pensi che sarà la reazione del popolo alle mie prime leggi? - Di che ti preoccupi, Maestà, solo una minima parte del popolo protesterà: quella degli intellettuali. Ma per quella (che è una minoranza) c'è il bastone. La maggior parte della popolazione del tuo impero già non legge o legge poco e male per cui se farai bruciare tutti i libri nessuno ci farà caso, anzi si divertirà a vederli ardere. Si divertirà come sempre gli uomini sono pronti a divertirsi di fronte ad uno spettacolo inaspettato e fuori del comune. E poi, Maestà, c'è sempre la carota per chi non vedrà di buon occhio le tue leggi... salvo poi a passare anche per loro al bastone, - aggiunse sottovoce. - Dovrai semplicemente ricordare ai tuoi sudditi che imparare a leggere e a scrivere costa fatica e sudore. - Non sarà un’operazione facile, - disse Massimino, tentennando il capo. - E chi lo dice? Basterà trovare le persone adatte. Non è difficile reperire imbonitori pronti ad urlare ai quattro venti che la cultura non serve per zappare la terra, per lavorare nelle fabbriche. Basterà che riescano ad inculcare nella mente di tutti che per leggere e per scrivere occorrerà conoscere un mucchio di segni, ricordare dei simboli, comprendere e meditare su una parola, prima di impadronirsi di una idea. Imparare è faticoso perché la testa ronza, si appesantisce, comincia a dolere; imparare è un dispendio inutile di forze, inutile dal momento che già esiste qualcos'altro di più facile, di più agevole per apprendere ciò che si deve sapere. - E che cos'è? - lo interruppe Massimino incuriosito. - La televisione, Maestà, la televisione! Chi oggi non possiede un apparecchio televisivo? Chi, uomo o donna o bambino non trascorre ore e ore davanti al magico schermo, beandosi di quello che vede e imparando quello che viene raccontato? Il popolo ti sarà più amico se, mentre da un lato vieterai le scuole e la lettura, dall'altro incrementerai la televisione. Pensa: un televisore in ogni stanza, " LA " RAI.CU. " AL SERVIZIO DI TUTTI ". Ecco lo slogan che dovremo diffondere! - La "RAI.CU."! E che cos'è? - La "RAI.CU.", Maestà sarà la Rete Audizioni Imperiali a Canale Unico. A che vale che mille persone diffondano mille idee in mille libri. Non serve ad altro che a confondere la mente. In fondo, per governare bene, ne basta una - disse Fulberto che si era lasciato trasportare dalle sue visioni e concluse: - E ricorda sempre, Maestà, la massima dei tuoi antenati : AUT CAESAR AUT NIHIL. Massimino il Grande, anche lui assorbito dal suo sogno di grandezza e di potere assoluto, non si soffermò a chiedere al suo confidente che cosa significassero le ultime parole che (guarda caso!) Fulberto aveva attinto in un libro vecchio di millenni. §§§§§§§§§§§§§§§§ Passarono gli anni e gli anni si accumularono in decenni. Massimino il Grande, allontanato tutti coloro che sapevano leggere e scrivere, chiuse la scuole, bruciate le biblioteche e spazzati via i libri in enormi falò, invecchiò regnando senza problemi su un popolo passivo che si divertiva solamente assistendo agli spettacoli televisivi che la "RAI.CU." propinava, alle competizioni sportive e a una infinità di giochi che, dietro consiglio di Fulberto, l'imperatore aveva sapientemente diffuso in tutte le città e in tutti i paesi. Anche per gli esiliati dell'Isola Senza Nome Fulberto aveva visto giusto. Dimenticati da tutti, tagliati fuori da ogni contatto con l'impero, privi totalmente di libri e nell'impossibilità sia di scriverli che di stamparli, furono costretti dalle necessità della vita a dedicarsi solamente al duro e spossante lavoro destinato a bonificare l'isola in cui erano stati relegati. Dovettero imparare a coltivare i campi, a cacciare, ad allevare il bestiame e ad abbandonare così tutti i sogni e le loro fantasie. E' legge di natura che quanto più una persona non esercita un’attività, tanto più perde la capacità sia manuale sia mentale di riprenderla a distanza di tempo. Di essa non rimane che un ricordo sempre più vago e sbiadito, sempre più sfumato e lontano che, alla lunga, diventa quasi un bagaglio inutile. Il tempo passò e i figli piccoli degli esiliati, nonché i nati in esilio crebbero imparando i lavori utili, quelli che servivano a sopravvivere in un ambiente che, seppur prodigo e capace di fornire in abbondanza quanto occorreva, aveva purtuttavia bisogno di cure assidue e di un costante lavoro. E la lettura e la scrittura furono così dimenticate. Ma un giorno...
Una leggera brezza proveniente dal mare faceva ondeggiare un vasto campo di grano prossimo ad essere mietuto. Le spighe agitate parevano onde gialle che lentamente si abbassavano e lentamente si rialzavano dando un senso palese di vita a tutta la natura. Il sole alto nel cielo riversava dappertutto un caldo giallo dorato che si fondeva con quello delle spighe e degli steli. Un vecchio, uno dei pochi sopravvissuti all'esilio, in compagnia di due nipoti, se ne stava all'ombra di un'ampia quercia, seduto con le spalle appoggiate al tronco. Guardava davanti a sè. - Dio, che bellezza! - disse quasi a conclusione di una muta preghiera e poi aggiunse, socchiudendo gli occhi come se andasse faticosamente a ripescare nella memoria un ricordo lontano: - Tu sì, amico Vincent, tu sì che hai saputo coglierla e fissarla. I nipoti lo guardarono senza capire. - Che vuoi dire, nonno? Chi era Vincent? - Chi era, figliolo, chi era... Lo conobbi durante la mia giovinezza. Era uno che sapeva usare il colore per fissare momenti come questo, - spiegò il vecchio facendo un ampio gesto che abbracciò tutto l'orizzonte. - Vincent era un pittore il quale per esprimersi usava tutti i colori dell'arcobaleno, come altri usavano la penna. Vedete, figlioli, non tutti hanno il privilegio di godere delle bellezze della natura, ma tutti hanno la possibilità di immaginarle attraverso la loro fantasia. La fantasia è come un'ascia: ma perché possa entrare in funzione occorre che ci siano tronchi e alberi su cui usarla. Ai tempi della mia giovinezza i tronchi e gli alberi erano rappresentati dai quadri e dai libri. Da quelli ricavavi le idee che poi plasmavi come volevi. - Ti ricordi ancora dei libri, nonno? Parlacene. - E chi potrà mai dimenticarli! Colui che volle esiliarci qui, colui che distrusse tutti i libri, credette pure di distruggere la fantasia dell'uomo e la sua capacità di ragionare. Ma si sbagliò e dimenticò una cosa essenziale e cioè che i ricordi non potranno mai essere distrutti. Anche se sbiaditi od offuscati i ricordi vivranno finché l'uomo vivrà. - Parlaci dei libri, nonno, - insistettero i ragazzi. - Raccontaci quello che contenevano. E in quella calda giornata estiva, di fronte ad un mare di luce, davanti alla superficie giallo dorata del grano che si piegava come un mare di onde al soffio del vento, il vecchio cominciò a raccontare ai nipoti le trame dei libri da lui letti in gioventù, a recitarne brani che per la loro bellezza erano rimasti impressi nella memoria. E i ragazzi rimasero per ore ad ascoltare a bocca aperta. Impararono. Tutto ciò che Massimino il Grande aveva sperato di distruggere per sempre col fuoco, ora riprendeva vita. Il vecchio riversava e affidava i suoi ricordi ai nipoti che a loro volta li avrebbero affidati ai loro figli. Da quel giorno in tutta l'isola, a cura dei vecchi, iniziò l'operazione che qualcuno battezzò "il recupero dei ricordi", e il ricordo dei libri, di quei libri che avevano sempre affascinato gli uomini per la loro bellezza, tornò a rivivere. E quando la grande nave imperiale, inviata dall'ormai vecchio imperatore Massimino per riportare in patria i figli degli esiliati, secondo la promessa fatta, attraccò in una rada dell'isola, l'imperatore non avrebbe certo immaginato che quanto pensava di aver distrutto con le fiamme, come un'Araba Fenice rinascente dalle ceneri, stava ritornando nel suo impero dove avrebbe di nuovo offerto agli uomini la possibilità di pensare e la facoltà di usare la fantasia.
L’avventura di Dria mi è stata raccontata dallo stesso protagonista durante una mia vacanza in un piccolo paese di mare vicino a Carloforte, in Sardegna. Incontrai Dria un mattino in cui i pescherecci non erano partiti per la pesca a causa del mare in tempesta. Il ragazzo se ne stava seduto in cima ad una scogliera e guardava il mare sottostante, gli occhi fissi sulle onde biancastre, rotolanti dal largo verso la riva. Mi accorsi subito che lo spettacolo lo attraeva in modo particolare e faceva affiorare alla sua memoria ricordi poco piacevoli. Essere fisionomisti e avere la capacità di leggere sul volto altrui il tormento interiore, fanno parte del bagaglio di un giornalista. Per cui guardando Dria, il suo viso aggrondato, gli occhi socchiusi quasi a mettere a fuoco particolari e vicende accadute in passato, intuii i suoi pensieri. Era il mare in tempesta a farli affiorare. Mi è sempre piaciuto parlare con i giovani: sono schietti, aperti, pronti a parlare di se stessi e a criticare i grandi, perciò, incuriosito dal suo aspetto pensieroso, lo abbordai. - Tristi pensieri, amico? Si voltò a guardarmi. Non mi chiese chi fossi e perché gli avessi rivolto la parola. Mi rispose semplicemente: - Qualcuno. - Come ti chiami? - Dria. - Sei in vacanza? - No, io vivo qui. D’estate, quando la scuola è chiusa, aiuto mio padre. E’ un pescatore. - Ti piace pescare? - Sì, mi piace anche se talvolta... Non finì la frase e si rimise a guardare le onde. - Hanno un fascino particolare quando sono infuriate - dissi. - Un fascino sì, ma solo a guardarle da lontano. Da vicino è diverso e non pensi al fascino, ma a salvare la pelle. - Ti è già capitato? - Una volta, quando mio padre aveva la paranza. - Ti va di raccontare? E la storia di Dria venne fuori lentamente, accompagnata dal sottofondo del rumore del mare infuriato. Una storia priva della magia del canto: non c’erano sirene, né donne dal dolce canto. C’era solo la musica feroce, rimbombante del mare il quale, quando produce quella musica, fa tremare chiunque si trovi a suo contatto. Ecco quanto Dria mi raccontò.
**********
Nonostante ai più dispiaccia mutar nome alle cose a cui sono affezionati, quasi il mutamento presagisse qualche calamità vicina o lontana, purtuttavia Padron Beppe non aveva protestato quando tutti cominciarono a chiamare la sua paranza, notoriamente conosciuta con il nome di ‘La Mena’ (e così registrata presso la Capitaneria di Porto), con il nuovo nome di ‘La Miniarca’. Né, d’altronde, avrebbe potuto impedirlo, quand’anche l’avesse voluto. Il nome era nato spontaneamente il giorno in cui suo figlio Dria l’accompagnò per la prima volta a pesca. Dria, un robusto ragazzotto di quasi quattordici anni, rosso di pelo al par di un vichingo e sempre così spettinato da essere da tutti chiamato ‘Dria il riccio’, col viso picchiettato di efelidi scure che risaltavano stranamente e spiccavano sulla sua pelle chiara, quell’estate aveva iniziato, per volontà paterna, a lavorare a bordo della paranza in qualità di mozzo. Sebbene il mare gli piacesse, non era stato lui a proporlo. Era stato il destino e un banale, un banalissimo incidente: si era fatto bocciare agli esami di terza media. - Pezzo d’asino, le vedi queste mani? - gli aveva detto Padron Beppe quando aveva visto i risultati appesi alla parete di un corridoio semibuio della scuola, - Le vedi? - Erano due manone incallite, dure, incise dal lavoro e dalla salsedine. - Ebbene, non passerà l’estate e le tue, se non saranno peggio, saranno almeno uguali a queste. E ora fila a casa! Da tua madre avrai il resto. Il resto c’era stato e sodo perché Carmela, se anche non andava a pesca e non tirava reti e funi, purtuttavia possedeva due mani ossute, rese legnose dai continui lavori domestici a cui si aggiungevano quelli del piccolo orto, più sassi che terra, ricavato dietro la casa. Era stata una bella libecciata a suon di sberle, con uno strascico poco piacevole: un bruciore persistente sulle guance e sul fondo della schiena e, in più, l’ordine perentorio con cui Padron Beppe aveva chiuso la questione. - Da domani, quando ‘La Mena’ uscirà in mare per la pesca, tu mi seguirai. Ti accorgerai come il mare sa essere salato!. Carmela non aveva mosso obiezioni, anzi aveva fatto cenno di sì col capo; approvava in pieno la severità del marito e la ribadì con regole più dure e più rigide. Sottovoce, però, il mattino seguente, alle quattro, dopo una abbondante colazione, il ragazzo ancora semiaddormentato la sentì sussurrare sottovoce al marito: - Mi raccomando, Beppe, fa’ attenzione al ragazzo; non lasciargli prendere qualche colpo di sole e tienigli gli occhi addosso ché non caschi in mare o non gli capiti qualche guaio. - Se vuoi lo chiudo al sicuro nella stiva? - celiò il marito, ridendo. - No, ma bada a non farlo stancare molto. Appena fuori dell’uscio, sbucato da chissà dove, Annibale gli era balzato addosso e gli aveva appoggiato le zampe sulle spalle, mentre con la lingua calda, appiccicosa, gli andava lavando ora l’una ora l’altra guancia. - Pussa via, Annibale! - aveva esclamato Dria, spingendo lontano da sé il cane, un bastardone dal pelo lungo e arruffato il quale uggiolava felice. - Lo portiamo con noi, pa’? - Ci manca solo Annibale a bordo! Già sopporto Scipione ed è tutto dire! Scipione era un gatto dal pelo rossiccio come la capigliatura di Dria e dagli occhi verdi simili a smeraldi. Di notte, sul mare, quando le nubi nascondevano la luna, quegli occhi brillavano come fiammelle fatue o fuochi di Sant’Elmo. Scipione era di casa sulla paranza. Sin da piccolo un marinaio l’aveva portato a bordo e il gatto non si era mai mosso. E dove avrebbe potuto trovare più pesce se non su una barca da pesca? Il nome di Scipione glielo aveva appioppato Dria il giorno in cui Annibale era salito a bordo. Il gatto, se ne stava acciambellato al sole vicino ad una galloccia e non appena aveva visto il cane, considerandolo un intruso e un probabile pericolo, gli era piombato d’un sol balzo in groppa, e, affondati gli unghioni nella schiena del malcapitato, aveva cominciato a soffiare minacciosamente. Il cane, colto di sorpresa, incapace di liberarsi da quell’incomodo peso, si era messo a galoppare sul ponte, urtando canapi e reti e se non fosse intervenuto un marinaio con un bugliolo d’acqua ad incappellare i due contendenti e a mettere fine alla lotta, forse sarebbe anche saltato in mare, nonostante le onde gli mettessero addosso una fifa matta. - Che batosta, Annibale! - aveva esclamato il ragazzo. - L’hai trovato stavolta il tuo Scipione, eh! Da quel giorno sulla ‘Mena’ non vi erano più state lotte e i due animali, pur conservando una pace armata e stando alla larga l’uno dall’altro, avevano imparato a convivere e a godere dell’ospitalità accordata loro da Padron Beppe: a Scipione in permanenza; ad Annibale saltuariamente. - Dai, pa’, lasciamelo portare! Vedrai: non ci darà fastidio. - Fa’ un po’ come ti pare: però t’avverto, se mi viene tra i piedi quando tireremo su le reti, te lo scaravento in mare. Dria sorrise: era solo una minaccia. Suo padre non l’avrebbe mai attuata. E così anche Annibale era salito a bordo. Quando la paranza lasciò il porto, il sole si era già alzato di qualche grado sull’orizzonte e la costa, investita obliquamente dai raggi, simile ad un diamante colpito dalla luce, scintillava di mille sprazzi, specie nei punti in cui i vetri delle case, illuminati, mandavano vividi bagliori. Il verde delle terrazze coltivate spiccava lungo i dorsali delle colline. Le siepi sempreverdi, i bassi tamerici, folti in alcuni punti e in altri radi, acquistavano uno strano colore smeraldino in mezzo ad una leggera, impercettibile foschia che sembrava salire da qualche umido anfratto o dai piccoli, scarsi ruscelli i quali, faticosamente, tentavano di aprirsi la strada verso il mare e si perdevano a mezza costa nel terreno ghiaioso e arido. Il mare attorno, increspato da lievi onde, lameggiava e ‘La Mena’ pareva scivolare sulla superficie di un enorme, sconfinato calderone pieno di materia pastosa e incandescente. Dria, seduto a prua, con a fianco Annibale che gli aveva posato il muso sulle ginocchia, guardava il mare aprirsi davanti alla paranza. Spinta da una leggera brezza proveniente da terra, la barca procedeva lentamente con un lieve dondolio. Padron Beppe con le mani sul timone gridava ordini ai marinai indaffarati con le reti e al tempo stesso non perdeva di vista l’ampia vela latina, pronto a cogliere quanto più vento possibile per giungere presto là dove le reti dovevano essere calate. Da anni batteva quel tratto di mare che va dalle isole dell’arcipelago toscano sino a quelle della costa ligure. Conosceva acque, correnti e fondali come le sue tasche e avrebbe potuto guidare qualunque barca ‘con delle fette di salame sugli occhi’, come era solito vantarsi. L’esperienza poi gli aveva insegnato a conoscere i punti più pescosi, le zone, i fondali ricchi di prede, quei fondali dove, con una semplice tartanella, si poteva in breve tempo riempire tutte le ceste. Quel giorno Padron Beppe aveva appunto deciso di calare la tartanella. L’altra barca gemella, quella del Purpettu, con cui era solito far coppia, se n’era andata in cantiere per alcune riparazioni. Ma era destino: la tartanella se ne sarebbe rimasta inoperosa, ammucchiata in bell’ordine sul ponte. Padron Beppe però questo non poteva prevederlo e, avendo fretta di raggiungere il punto da lui scelto, aveva fatto spiegare anche il polaccone sul buttafuori di prua per avere più velocità. Dria, lasciato Annibale, era salito sull’albero a calcese e si era sistemato nella piccola coffa da dove poteva avere una visione completa di quanto accadeva sul ponte sottostante e sul mare tutto attorno. Fu, quindi, lui a notare un natante all’orizzonte. Un avvistamento di poco interesse. Era cosa di tutti i giorni incrociare navi di linea, yachts, barche da pesca, motoscafi da crociera e il ragazzo si sarebbe disinteressato della cosa se, diminuita la distanza, non si fosse accorto che qualcosa a bordo della barca avvistata non andava. - Pa’ - gridò il ragazzo, - pa’, quelli fanno dei segnali! - Quali segnali! - rispose il padre. - Quelli ci stanno semplicemente salutando. - Pa’, quelli non solo saluti: vogliono dirci qualche cosa, ma io non capisco. Padron Beppe lasciò il timone, si sporse dalla murata e, facendosi solecchio con una mano, guardò anche lui. Si trattava di un grosso motoscafo d’alto mare, tutto bianco tranne una striscia rossa che lo tagliava in due longitudinalmente. - Sandro, che ne dici? - chiese ad un marinaio, un giovane piccoletto, abbronzato e ricciuto. - A dir la verità mi sembra uno strano modo di salutare quello! - rispose l’interpellato. - Ho capito, ho capito, - bofonchiò Padron Beppe, andando a riprendere il timone. - Sei anche tu curioso come quello lassù - aggiunse, indicando il figlio. - E va bene: bada alle vele ché io cambio rotta e andiamo a vedere di che si tratta. Poco dopo ‘La Mena’, con un’abile virata, giungeva a portata di voce col motoscafo. - Ehi, laggiù, tutto bene? - gridò Sandro, salito sul bordo della murata per vedere meglio e lasciandosi penzolare fuori bordo, appeso ad una sartia. - No, siamo in panne - rispose una voce d’uomo. “Quello non è un marinaio!” - pensò subito Padron Beppe, vedendo un tizio tutto vestito di bianco come un gelataio, con un cappello da capitano in testa. - Grazie di essere accorsi; da ieri andiamo alla deriva. Il motore si è surriscaldato e non ha più voluto saperne di funzionare. - Non avete un motorista a bordo? O qualcuno esperto di motori? - E no, è una cosa lunga da spiegarsi. - E da ieri non avete incontrato nessuna barca? - Oh sì: navi da pesca, yachts, motoscafi, ma devono aver scambiato i nostri segnali per saluti e nessuno si è accostato, accidenti a loro! - si arrabbiò quello. - E la radio di bordo? - Neppure quella funziona. - Un bel guaio. La situazione fu presto chiarita. Il motoscafo, di proprietà dell’uomo vestito da gelataio e col berretto da capitano (un ricco industriale messinese), era partito dalle coste siciliane alla volta del porto di La Spezia con a bordo la moglie e due figlie. C’era pure un motorista, l’unico in grado di guidare quella stupenda imbarcazione. Sennonché era dovuto sbarcare a Napoli per essere immediatamente ricoverato in ospedale a causa di una improvvisa peritonite. L’industriale si era, quindi, autonominato capitano, guida, timoniere e meccanico. Perdinci, aveva pensato, se riusciva a mandare avanti intere squadre di operai, per lui, sarebbe stato un giochetto condurre il motoscafo a La Spezia e, nonostante il motorista avesse tentato di dissuaderlo, era partito lo stesso, ottenendo quel logico risultato. - Tonio - fece Padron Beppe, rivolto ad un marinaio, - vedi un po’ tu che si può fare. Tonio aveva viaggiato a lungo come macchinista a bordo di una vecchia petroliera e di motori se ne intendeva. Balzò giù dalla murata non appena Padron Beppe ebbe accostata ‘La Mena’ al motoscafo sin quasi a toccarlo e sparì nel ventre dell’imbarcazione, seguito dall’azzimato ‘capitano’. Dria, sceso dalla coffa, si era seduto a cavalcioni della murata per vedere più da vicino il motoscafo e subito la sua attenzione era stata attratta da due ragazze intente a giocare con una scimmia e un pappagallo. La prima, una bertuccia legata ad un anello con una cordicella passante attorno alle reni, balzava a destra e a sinistra squittendo e afferrando al volo le noccioline gettate dalle due ragazze. Il pappagallo se ne stava invece appollaiato sulla sbarra traversale di una antenna e si dondolava pigramente come un orso, scuotendo il capo. - Quello parla? - volle sapere Dria. - Certo che Purcheddu parla! - rispose la più piccola. - Vero, Purcheddu? Su, fa’ sentire la tua voce! - aggiunse, rivolta all’animale Il pappagallo arrestò i movimenti del capo, lo storse un poco a destra e a sinistra e, infine, fece sentire la sua voce. - Purrr-cheddu, Purrr-cheddu. Dria rimase a bocca aperta. Lo sapeva che i pappagalli parlano, ma non ne aveva mai sentito uno e la cosa lo sbalordiva e lo meravigliava. - E sa anche altre parole, sai! - aggiunse la ragazza. - Guarda! Prese la scimmia tra le braccia e l’avvicinò all’uccello. Il pappagallo dapprima si ritrasse e poi partì fulmineo cercando di colpire la bertuccia la quale, a sua volta, si schivò squittendo. - Musss-fa, Musss-fa - gracchiò il pappagallo. - E che vuol dire? - chiese Dria ridendo. - E’ il nome della scimmia: si chiama Mustafà. In quel momento riapparve Tonio con le mani sporche di morchia. - Niente da fare, Padron Beppe; c’è l’asse di trasmissione spezzato; il motore è grippato perché non c’è più una goccia di lubrificante. Dobbiamo prenderlo a rimorchio. - Non c’è proprio niente da fare? A Padron Beppe garbava poco rinunciare alla pesca e glielo si leggeva apertamente in viso, tanto apertamente che il ‘capitano’, sorridendo, disse: - Suvvia, amico, non prendertela, non vorrai mica lasciarci qui, no? Rimorchiaci a La Spezia e non te ne pentirai. E sparò una cifra allettante. Si poteva forse dubitare sulle sue qualità di capitano, ma non si poteva mettere in dubbio che quell’uomo sapeva subito come trarsi d’impaccio e risolvere una situazione. Un quarto d’ora dopo le due imbarcazioni procedevano in fila, unite da un lungo cavo, alla volta di La Spezia. Dria aveva ottenuto il permesso di passare sul motoscafo per divertirsi con i due animali ai quali dedicò tutto il suo tempo, incurante degli uggiolii gelosi di Annibale e delle occhiate di Scipione, sistematisi a poppa, vicini una volta tanto e senza alcuna intenzione di darsi battaglia. A La Spezia ci fu, poi, un’altra novità. Il ‘capitano’ e la sua famiglia avevano deciso di fare un giro turistico attraverso l’Europa Centrale e non sapevano a chi lasciare i due animali. Ci fosse stato almeno il motorista, ma... La conclusione fu, comunque, presto trovata o, per meglio dire, la trovò l’azzimato ‘capitano’ messinese. Dria si sarebbe occupato di Purcheddu e Mustafà. Padron Beppe protestò un poco, sino a quando l’industriale non sparò un’alta cifra a bruciapelo e ‘La Mena’, quella sera, rientrò in porto con un cane, un gatto, una scimmia e un pappagallo. E volevate che qualche buontempone non la soprannominasse subito ‘La Miniarca’? Trascorsero due mesi caldi, afosi, durante i quali Dria si divertì e faticò a bordo della paranza. Al mattino all’alba ‘La Miniarca’ prendeva il largo e a volte rimaneva anche più giorni senza rientrare in porto. A parte l’avventura col motoscafo in avaria, non era più accaduto nulla di strano e il ragazzo cominciava a dubitare di quanto i marinai, nelle pause di lavoro gli raccontavano: avventure impreviste, fortunali, tempeste, naufragi... Ne dubitò sino alla prima settimana di settembre. L’ultima domenica di agosto il Purpettu e Padron Beppe, seduti ad un tavolo dell’osteria con vista sul mare, davanti a un litro di rosso, avevano preso la decisione di spingersi sino alla Bocche di Bonifacio dove, a dire di Padron Beppe, c’erano fondali adatti per gettare le reti a strascico. - Non preoccuparti per la distanza - lo aveva tranquillizzato il Purpettu, vedendo l’amico un poco incerto. - Ho fatto installare un nuovo motore e ti rimorchierò fino sul posto. Erano partiti di buon’ora, quando appena un lontano chiarore all’orizzonte vinceva le ombre della notte. Poche nubi rossastre verso ponente avevano fatto aggrottare le fronte di qualche marinaio che poi, con una alzata di spalle, s’era messo al lavoro. Per tutto il giorno non era accaduto nulla, tranne l’addensarsi delle nuvole. Il mare si era fatto mosso e ‘La Miniarca’, trainata da un lungo cavo, era costretta a tagliare le onde di punta. Caracollava come un cavallo brado e spesso si tuffava col muso in avanti, sollevando montagne di schiuma. - Se aumenta il vento, taglio il cavo - aveva detto Padron Beppe ai marinai. - Tenetevi pronti ad alzare la cecarola. Dria l’aveva capito subito: in quel momento era di troppo e aveva per prima cosa rinchiuso nella stiva gli animali perchè non dessero fastidio. Poi, avvicinatosi all’albero, l’aveva abbracciato per evitare di essere sbattuto sul ponte da qualche raffica violenta. Il vento di grecale era andato sempre più aumentando di intensità e soffiava a forti raffiche, mentre in cielo le nubi, in densi banchi, scendevano basse e si aggrovigliavano l’una all’altra, spinte da correnti diverse. - Taglia! Taglia! - urlò d’un tratto Padron Beppe, raddrizzando al tempo stesso la paranza che di colpo aveva scarrocciato a sinistra. - E tu, Tonio, tienti pronto ad alzare la vela. Un istante appresso la piccola cecarola, solidamente legata all’albero, si gonfiava di colpo, fecendo gemere la carcassa della ‘Miniarca’ e imprimendole velocità. La cappa plumbea delle nubi si andava sempre più abbassando e pareva che la notte fosse calata di colpo. La paranza a motore del Purpettu non si vedeva più, inghiottita dall’oscurità e dalle onde, levatesi all’improvviso altissime. Lo scafo procedeva veloce, sospinto dal vento. A volte, investito a tradimento di fianco, si piegava, mentre la vela si afflosciava un istante per poi gonfiarsi con un colpo secco, come di frusta. E in quegli attimi Dria sentiva le sartie fischiare e vibrare quasi fossero corde di un violino. L’improvviso zigzagare di un lampo illividì il cielo e il successivo scoppio del tuono fecero sussultare il ragazzo. - Pa’! - gridò impaurito - Pa’! - Scendi nella stiva e porta su i salvagente. Indossane uno! - gli gridò suo padre nel vento e Dria, aggrappandosi a ciò che poteva, prese a strisciare verso il boccaporto, incurante delle ondate che, prendendo di prora la paranza, ne inondavano a tratti il ponte. Non appena ebbe aperto il boccaporto, la bertuccia gli saltò al collo, squittendo. - Calma, Mustafà, - disse, sciogliendola dalla catena - e anche voi state calmi - aggiunse, rivolto agli altri animali agitati. Ci mise del tempo a trovare i salvagente e quando uscì di nuovo all’aperto si accorse del diluvio aggiuntosi alle ondate. Un vero lavacro si abbatteva sulla vela, appesantendola come una spugna. Padron Beppe lo si vedeva appena; stava come un’ombra abbarbicata al timone. Dria non lo immaginava, ma suo padre in quel momento stava pregando e come lui gli altri marinai, intenti a precludere alle onde la via della stiva. Tacevano tutti nonostante intuissero che Padron Beppe, pur non volendolo ammettere, aveva perso l’orientamento. Di sicuro tutti sapevano una sola cosa: la costa non doveva essere lontana. Ma dov’era? E quanto ne distavano? La paranza pareva impazzita. A tratti volava sulla cresta delle onde come un fringuello per poi tuffarsi giù nell’abisso tra onda e onda. Solo un violento colpo di barra e un’abile straorzata le impedivano di venire semisommersa. - Risacca a dritta! - gridò d’un tratto Sandro, aggrappato ad una sartia. L’aveva intravista, proteggendosi gli occhi con una mano. ‘La Miniarca’ correva rapida verso l’orrido ribollire di schiuma, là dove gli scogli affioravano. - Taglia la vela! - gridò Padron Beppe. - Presto, taglia! La cecarola liberata alla base da un preciso colpo d’ascia, fu spinta verso l’alto dal vento e rimase appesa come una enorme bandiera all’albero, all’altezza della coffa; sventolò per qualche istante e poi una più forte raffica la strappò, facendola volteggiare per l’aria come un immenso aquilone. Ma non servì a nulla. Un’onda altissima, simile ad una mano gigantesca, afferrò la ‘La Miniarca’ e la catapultò sugli scogli. Dria avvertì l’urto tremendo. Lo scafo si sfasciò sotto i suoi piedi. La bertuccia lo serrava stretto stretto al collo, quasi a soffocarlo e poco c’era mancato che il contraccolpo non lo strappasse dall’albero cui stava aggrappato, ma, all’istante dell’urto aveva avvertito un braccio, quello del padre, cingerlo fortemente alla vita. - Indossate le cinture e gettatevi a mare! - gridò Padron Beppe ai marinai, cercando di vincere l’urlo del vento. - La barca è perduta! Precisazione inutile perché tutti avvertivano le punte aguzze degli scogli penetrare ad ogni ondata nelle fiancate e tutta la carcassa gemere e scricchiolare sordamente, mentre l’inclinazione del ponte diventava sempre più impossibile. Ciononostante Padron Beppe non se la sentiva di abbandonare spontaneamente la sua ‘Miniarca’. Fu il mare stesso a deciderlo. Di colpo una massa d’acqua percorse il relitto da poppa a prua e l’istante appresso Dria, con sempre al collo Mustafà fradicio e tremante, si trovava in balìa delle onde a oltre una diecina di metri dall’imbarcazione. Poco distante suo padre nuotava vigorosamente per raggiungerlo. Gli altri marinai non si vedevano. Quando Padron Beppe lo raggiunse non disse nulla; si limitò ad afferrarlo e a nuotare con lui. Nemmeno Dria parlò. Quando il mare urla in quel modo, le parole degli uomini non contano nulla. Si lasciava trasportare dal moto ondoso ora in basso, ora sulla cresta spumeggiante di un’onda da dove poteva vedere i resti della paranza spezzata tra un ribollire schiumoso. Forse fu la fantasia o forse vide davvero due ombre muoversi a poca distanza. - Annibale, Scipione! - gridò, mentre l’onda lo trascinava verso il basso. Quando ritornò sulla cresta, il cane e il gatto erano spariti. - Chissà che fine avrà fatto Purcheddu - pensò. Si consolò dicendosi che un pappagallo può volare e la costa non doveva essere lontana. L’indomani mattina, quando ormai il mare si era calmato, una motovedetta della guardia costiera raccolse i naufraghi e anche una scimmia. Per tutto il tempo, pur mezzo soffocata, non si era staccata dal collo del ragazzo. Il cane, il gatto e il pappagallo non furono più trovati. Alcuni pescatori corsi, soliti a frequentare con le loro barchette le cale e le piccole insenature della costa sarda, affermano, però, di aver veduto un cane e un gatto aggirarsi lungo la costa, uno a fianco dell’altro, come amici inseparabili. Dicono pure di aver notato un uccello di color verde e rosso, con ampie ali, sorvolare i due animali. Qualcuno afferma di aver udito quell’uccello parlare, ma nessuno gli ha creduto. Della ‘Miniarca’ non si trovò più nulla, tranne qualche tavola galleggiante sulle le onde.
Racconto vincitore del 3° premio "Future Shock" - VI Edizione Ma in che mondo sono capitato? (dis di D.Cattaneo) di Marino Cassini "Chissà se nonno sarà alla stazione ad aspettarmi? Se c'è giuro che mi faccio comperare un gelato alla menta. Giacomo, ormai Mino per tutti, se
ne stava col naso appoggiato al finestrino del treno a guardare i pali
della luce che parevano inseguirsi senza sosta. Ormai quel tratto di linea
ferroviaria che dalla città dove abitava arrivava al paese dei nonni, lo
conosceva come le sue tasche e non faceva più caso al paesaggio. Tanto lo
sapeva che dopo il cavalcavia c'era sulla destra una casa signorile col
tetto sormontato da una specie di torretta e sulla sinistra un vasto prato
recintato dove, si solito, pascolavano alcuni cavalli. Poi c'era un lungo
tratto in cui i binari correvano so Sempre lo stesso paesaggio. Unico divertimento era quello di guardare i pali della luce e immaginare che si trattasse di striminziti giganti, impegnati in una continua rincorsa. - Biglietto! La voce del controllore gli fece allontanare il naso dal finestrino. Mino pescò in una tasca il tagliandino che suo padre gli aveva consegnato quando l'aveva accompagnato in treno e attese che l'uomo lo forasse. - Viaggi solo? - chiese il controllore guardandosi attorno. - Sì, per andare dai nonni viaggio sempre solo. Ho dodici anni e posso farlo. - Non ne dubito. Be', buon viaggio. Ricordati che la prossima fermata è la tua. - Mi sa dire l'ora per favore? - Sono le quindici, ne hai ancora per un quarto d'ora. Il controllore se ne andò e Mino riprese a guardare attraverso il finestrino. Era bello allontanarsi il sabato dalla città per andare dai nonni. Quelli erano felici di ospitarlo per due giorni e lui era felice perché si sentiva libero, lontano dai brontolii del padre, dalle lamentele di sua madre e ancor più dal continuo frignare di Sandra, la sorellina che da poco aveva compiuto un anno. I nonni gli lasciavano fare tutto quello che voleva nella bella casa circondata dal giardino. Oltre a divertirsi come un matto, aveva pure la sua stanzetta personale con un enorme lettone su cui fare salti a non finire. - Non vedo l'ora di arrivare - esclamò ad alta voce. Tanto nello scompartimento era solo. - Tra poco entreremo nella galleria e subito dopo c'è la stazione di Perentola. Neppure quando il treno imboccò la galleria Mino cessò di guardar dal finestrino. Non c'erano più i pali a rincorrersi, ma in compenso c'era una striscia bianca e continua dipinta sulla parete della galleria la quale saliva e scendeva a zig zag come un toboga senza fine. Una leggera scossa lo avvertì che il treno stava rallentando. E, infatti, poco dopo si fermò tra uno stridìo di freni. Mino si sporse per vedere se c'erano lavori in corso, ma in quel tratto i binari correvano in leggera curva e lui si trovava nella penultima vettura per cui non vide nulla. Con una alzata di spalle si sedette e attese. L'attesa durò a lungo tanto che si alzò per sbirciare nel corridoio e vedere se c'era qualcuno a cui chiedere il perché di quella fermata. Intravide solo alcuni passeggeri che se ne stavano tranquillamente a leggere qualche rivista o intenti a risolvere parole incrociate. Stava ancora sbirciando quando le luci si spensero e altrettanto all'improvviso si riaccesero qualche minuto dopo. Il treno riprese la corsa uscendo dalla galleria. Mino lasciò lo scompartimento e si avvicinò alla porta d'uscita. Sapeva che il treno dopo la galleria, avrebbe impiegato pochi minuti per raggiungere la stazione di Perentola. Attraverso il finestrino guardò per vedere il villino con la facciata dipinta in blu-cobalto, un colore che lo aveva sempre affascinato. Vide il villino passargli velocemente davanti agli occhi. - Oh guarda, che peccato! - esclamò. - Gli hanno cambiato il colore. Era meglio prima. Poi il treno rallentò fino a fermarsi. Mino era l'unico viaggiatore ad essere sceso alla stazione di Perentola. Si guardò attorno per vedere se c'era il nonno. Non lo vide. Poco male. La strada per andare a casa dei nonni la conosceva. Si avviò verso il punto dove sapeva esserci il sottopassaggio per l'uscita, ma per quanto guardasse a monte e a valle della pensilina, non riuscì a trovarlo. - Che strano! - borbottò. - Non c'è più il sottopassaggio. Chissà perché l'anno soppresso. Mi toccherà attraversare i binari. Guardò a destra e a sinistra per vedere se arrivava qualche treno e poi attraversò i binari e uscì dalla stazione. La casa dei nonni non era molto distante, ma la voglia di un gelato alla menta gli era rimasta in bocca. Si voltò verso il bar della stazione e l'occhio gli cadde sulla facciata della stazione su cui campeggiava il nome. Il ragazzo piegò un poco la testa da un lato, quasi per leggerlo meglio: PIRETOLI - Oh bella! - esclamò rivolto ad un autista che se stava appoggiato al suo taxi. - Gli hanno cambiato nome. - A che cosa? - chiese l'autista. - Ma alla stazione: non si è sempre chiamata PERENTOLA? - Oh bimbo! Che dici? Da quando son nato quella è sempre stata la stazione di PIRETOLI. Ti piace scherzare, eh? Mino non rispose. Gli piaceva scherzare, ma in quel momento non ne aveva alcuna voglia, per cui imboccò la strada che conduceva alla casa dei nonni, rinunciando al gelato alla menta. Trovò Nonno Livio seduto su una poltrona di vimini, sotto la veranda, proprio accanto all'uscio. Il nonno lo accolse con un abbraccio e così pure Nonna Maria che si affacciò appena sentì la sua voce. Per Mino fu come rientrare nella normalità. La casa blu-cobalto, il sottopassaggio che non c'era più, il nome della stazione, l'autista, furono subito dimenticati. Corse in camera sua a farsi quattro salti sul letto e poi raggiunse la nonna in cucina dove avrebbe potuto sgraffignare qualche leccornia. - Hai spostato la credenza, nonna? - chiese entrando e vedendo che il mobile, da sempre troneggiante di fronte al camino, si trovava ora appoggiato al muro, vicino alla finestra che dava sul giardino. - Ma che dici, sciocco! Sono anni che sta lì. Mino la guardò e non disse nulla anche perché la donna gli porgeva un vassoio su cui c'erano brioche e una caraffa di acqua zuccherata e menta. - Tieni, Mino avrai fame. Questo è tutto per te. Vai sulla veranda dal nonno e mangia in pace. Mi raccomando, non fare come al solito bocconi grossi, se no finisci per strozzarti come qualche volta ti è capitato. Mino pensò che non si era mai abboffato, né strozzato, ma anche stavolta non rispose nulla. Si avviò per raggiungere il nonno, reggendo tra le mani il vassoio. Si sedette su uno scalino accanto alla poltrona di vimini. Addentò una brioche e disse: - Nonno, che fa il governo? Quali guai ha combinato? Mino sapeva che, quando si toccava il tasto 'governo', il nonno si inalberava, si arrabbiava contro quelli di Roma e imbastiva lunghi sproloqui, prendendosela con questo o quel ministro, rei di non farne mai una bene. - Mino, - lo redarguì severamente il nonno. - lo sai che non si deve parlare male del governo. Quello che fa è sempre ben fatto. Il ragazzo rimase a bocca aperta e lo guardò trasecolato. Si era aspettato una bella sfuriata, condita da qualche colorita parolaccia che l'avrebbe divertito e, invece, il nonno, dopo essersi guardato attorno con circospezione, aveva posato il giornale che stava leggendo. Mino lo prese e guardò la prima pagina. - Ma non hai sempre comprato "La Stampa", nonno? - chiese dopo aver letto la testata del giornale che portava a grandi lettere il titolo INFORM. - Questo titolo mi è nuovo. Non l'ho mai sentito né visto nelle edicole. E' uscito da poco? - Ma che dici, Mino? Sono anni che leggo l'INFORM. Non ho mai letto altri giornali. "Certo, pensò Mino, che i nonni sono molto cambiati dall'ultima volta che li ho visti. Però è solo un mese che non vengo a Perentola! Si vede che ha ragione papà quando dice che hanno l'arteriosclerosi galoppante. Vuoi vedere che non ricorda nemmeno il nome del paese in cui abita." - Nonno, come si chiama questo paese? - Ma che strane domande mi fai oggi! Vuoi che non sappia il nome del paese? Si chiama Piretoli. "Alè, pensò il ragazzo è proprio arteriosclerosi galoppante" e per poco non scoppiò a ridere. Povero nonno, stava proprio perdendo la memoria! Però, a pensarci bene, anche l'autista della stazione aveva detto la stessa cosa, e quello non era vecchio. Che stessero diventando tutti matti a Perentola! Per rendersene conto non rimaneva che fare un giretto per il paese. Riportò in cucina il vassoio e poi ritornò dal vecchio. - Nonno, posso andare a fare un giretto? - Ma sì caro, però fa' attenzione alle motauto. "Eccone una nuova, pensò Mino, le motauto! Chissà che cos'è una motauto!" Ma forse quella non era una stranezza né una novità perché il nonno, spesso avaro di parole, era portato a fare d'ogni erba un fascio e inventava lì per lì parole strane che solo lui usava, come 'cangatto' per dire cane e gatto, i 'marchiodi' per indicare il martelli e i chiodi, la 'poletti' per indicare la polenta agli uccelletti. Uscito dal cancello Mino prese la strada che conduceva alla piazza e quando vi giunse si accorse che anche lì c'era qualcosa che non quadrava con i suoi ricordi. Il monumento a Salvo Calvi, una eminente personalità che aveva dato lustro a Perentola per aver costruito una grande vetreria dove lavorava la maggior parte del Perentolesi, era stato sostituito dalla statua di un uomo a cavallo, di certo più suggestiva della figura pensosa di Salvo Carli scolpita nel marmo, ma a lui, Mino, quell'uomo era un perfetto sconosciuto. Sul marmo del basamento lesse: "A Walter Allori. I suoi concittadini con affetto" Il ragazzo si chiese chi mai fosse questo Walter Allori a cui i Perentolesi manifestavano tanto affetto. - Ciao, Mino! Una voce giovanile lo distrasse. Finalmente qualcuno che lo conosceva. Si voltò a guardare il ragazzo che lo aveva salutato. Stentò un poco a riconoscerlo, poi ricordò che doveva essere il figlio del macellaio col quale in passato aveva qualche volta giocato a pallone. - Sei dei nostri, Mino? - Sì, almeno fino a domani. Sono venuto a trascorrere il fine settimana dai nonni. - Bravo. Mi offriresti un gelato? Sai mio padre da un po' di tempo non mi dà la paghetta. - E perché no! Da chi andiamo? - Alla Gelateria Aurora. Dopo il cambio di gestione fanno certi coni gelato che nemmeno te li sogni. Una delizia! - Hanno cambiato il nome al negozio? Non l'ho mai sentito. - Ma no, si chiama Gelateria Aurora da quando è nata, trent'anni fa. Vieni, andiamo! - E l'amico lo prese per un braccio, trascinandolo lontano dal monumento, verso una delle strade che confluivano nella piazza. Mino dovette dargliene atto: il gelato era ottimo, squisito, celestiale tanto che fecero il bis. Stettero un poco a guardare un giovanotto che giocava a flipper e Mino constatò che flipper di quel tipo non ne aveva ancora veduti. Anche i suoni che fuoriuscivano dalla macchina erano diversi da quelli consueti. E dire che lui se ne intendeva di flipper! Conosceva tutte le marche e aveva trascorso ore a pigiare i pulsanti e a manovrare leve tanto da essere addentro ad ogni segreto e a non andare mai in tilt. Ma quel tipo di flipper della Gelateria Aurora era diverso da tutti quelli che aveva conosciuto. Avrebbe voluto provare a giocarci almeno una partita, ma sembrava che il giocatore non avesse l'intenzione di lasciare il posto libero e poi il suo amico gli disse che doveva tornare a casa. Mino si diresse verso la cassa e consegnò alla cassiera una banconota da diecimila lire che suo padre gli aveva dato per le piccole spese e attese il resto. - Che cosa vuoi , ragazzo? - gli chiese la bionda dietro la cassa. - Pagare, signorina, le ho dato un deca. - Che cosa mi hai dato? - Un deca, signorina, diecimila lire - rispose indicando la banconota. - E che me ne faccio di questo foglietto? - disse la bionda che aveva preso le diecimila lire e le rigirava tra le mani come se fosse la prima volta che le vedeva. - Ma... ma... - cominciò a balbettare Mino, guardandosi attorno e poi, fissando l'amico, disse: - Ma questi sono soldi, signorina! - Senti ragazzino, non farmi perdere tempo e tira fuori dalle tasche qualche credito, qualche tall o qualche den. Questo te lo puoi riprendere, - aggiunse restituendogli il biglietto da diecimila. - Io ho solo questo, signorina! - ripeté Mino che cominciava a non capire più nulla. Per fortuna intervenne l'amico a salvarlo da una situazione incresciosa. - Signorina Carla, non ci faccia caso. Il mio amico Mino viene dalla città e gli piace scherzare. Sa, è il nipote di Nonno Livio, lo conosce no? - E chi non conosce Nonno Livio. Sta bene, mi farò pagare da lui quando verrà. Ma tu, ragazzino non tentare più con me scherzi del genere! Come hai chiamato quel biglietto, un deca? Ne hai della fantasia, - concluse ridendo. Mino si lasciò trascinare fuori dall'amico. Camminava come in trance. - Perché non mi hai detto che non avevi soldi? - Ma io li ho i soldi: eccoli! - insistette mostrando all'amico la banconota che aveva fatto saltare la mosca al naso alla cassiera. - Ma che razza di soldi sono quelli lì! Chissà dove li hai presi, forse in un gioco di Monopoli. Mino infilò le diecimila in tasca. - Che fai stasera? - chiese l'amico. E senza attendere la risposta, aggiunse: - Al Rexon c'è un film che è uno sballo. "La montagna incantata" con Maximilian Prescott e Dona Carue. Uno schianto tutti due. Non ho mai perso uno dei loro film; sono sulla breccia da dieci anni. - Maximilian Prescott e Dona Carue! Mai sentiti nominare. L'amico lo guardò con aria stupita. - Ma siete così ignoranti voi della città! Dove vivi, Mino! Due divi così noti che quest'anno si sono pure beccati l'Oscar! Tu hai ancora voglia di scherzare. E poi se non li conosci va' pure a vedere le locandine e le foto davanti al cinema. - E se ne andò correndo. Mino si voltò verso la facciata del cinema davanti alla quale facevano bella mostra alcuni vistosi cartelloni. Si avvicinò. Però, che strano! Aveva sempre creduto che il cinema fosse in fondo alla piazza e che si chiamasse Rex. Ma forse si era sbagliato. Guardò i cartelloni colorati, osservò i volti dei due protagonisti: due visi completamente sconosciuti. E sì che lui al cinema andava spesso con suo padre! Guardò di nuovo tutti i cartelloni e poi, con una alzata di spalle, si avviò verso la casa dei nonni. Cominciava il frescolino della sera e Nonno Livio non era più sotto la veranda. Lo trovò in salotto seduto sull'ampio divano, di fronte alla televisione che trasmetteva un poliziesco. In silenzio prese posto al suo fianco e si immerse nella trama. Anche se aveva perso l'inizio non era poi così difficile ricostruirlo a grandi linee. Quando il telefilm finì, Nonna Maria li chiamò a tavola che Mino trovò già apparecchiata con al centro una zuppiera fumante. Nonna era imbattibile nel fare zuppe di verdura dal gusto squisito, E anche quella sera fu all'altezza della sua fama. - Nonno, - chiese Mino tra una portata e l'altra - stasera alla TV c'è l'incontro Inter-Milan, lo guardiamo? - E quando mai in TV trasmettono partite di serie C! - Ma. nonno, Inter e Milan in serie C! Che stai dicendo? - No, stasera ci vediamo sul primo canale il film che stanno strombazzando da un mese: "Pugno di ferro", col grande Stan Gilford. Mai visto un attore simile! Sembra un gigante ed è bello come un dio greco, vero Marta? - disse rivolto alla moglie che, sorridendo, fece spallucce. - Lo so che Stan Gilford ti piace e che per lui hai un debole - la stuzzicò il vecchio ridacchiando. "Alè, - pensò Mino sentendo il nome dell'attore che gli giunse completamente nuovo. "Eccone un altro che si affianca a quel Prescott vattelapesca e a quella Dona che era sì una bella bionda, ma che lui non aveva mai sentito nominare. Che stava accadendo in quel paese da un mese a questa parte? - Su, andiamo - disse Nonno Livio alzandosi da tavola, - tra poco comincia il film. - C'è ancora tempo, sono solo le otto, nonno. Adesso trasmetteranno il notiziario. - Mino, alle otto sul primo canale non c'è mai stato alcun notiziario - rispose perentorio il vecchio. - Su, andiamo! Mino lo seguì in salotto e si sedette di nuovo sul divano. Dopo aver lavato i piatti, li raggiunse pure la nonna che in silenzio si accomodò nella sua poltrona preferita. Prese la maglia e, con gli occhi fissi sullo schermo, cominciò a sferruzzare. Mino guardò le sue mani che si muovevano veloci e agili. Non si era mai capacitato di come facesse ad intrecciare il filo di lana con due ferri aguzzi senza guardare e senza imbrogliarli. Il film non era poi così avvincente come il nonno aveva preannunciato. Solo le scene d'azione lo interessarono; per il resto era melenso, sciropposo e con troppe scene d'amore, tanto che ad un tratto si addormentò. * * * Quando al mattino seguente si svegliò, il sole era già alto. Non ricordava come avesse raggiunto il letto. Forse l'avevano portato di peso mentre era addormentato. Rimase a crogiolarsi nel tepore delle lenzuola e alla fine si decise ad alzarsi. C'era un rito da cui nonna non derogava mai: andare alla Messa delle undici. Ancora in pigiama scese in cucina e trovò sul tavolo il piatto di morbide brioche e sul fuoco un bricco di latte. Accese il fornello e attese che il latte si scaldasse. Dalla porta finestra che dava in giardino vide la nonna che stava raccogliendo alcune verdure in un piccolo appezzamento di terreno che nonno aveva adibito ad orto. Mino spense la fiamma un istante prima che il latte uscisse dal bricco. Gli piaceva aspettare fino all'ultimo momento, quando la schiuma raggiungeva quasi l'orlo del recipiente. Guardò il latte sgonfiarsi e poi lo versò in una tazza. Era bollente. Aggiunse del latte freddo finché la temperatura fu quella desiderata e cominciò a inzupparvi le brioche. Quando Nonna Marta rientrò, aveva appena terminato e si stava pulendo un baffo di latte che gli era rimasto sul labbro superiore. - 'giorno, nonna. Ottime le brioche, tra quanto andiamo? - Andiamo dove? - A Messa. - Eh, la Messa! Quella è già finita da un pezzo. Io ci sono stata e tu no. Sei un dormiglione, Mino. Volevo svegliarti, ma dormivi così sodo che non me la sono sentita. - Non c'è più la Messa alle undici? - Non c'è mai stata una messa alle undici. Don Ubaldo preferisce fare la funzione alle otto e lasciare che i fedeli si godano in santa pace tutta la giornata festiva. Ma ora lascia stare la Messa e aiutami. Oggi ti farò il riso al cinnamomo con una spruzzatina di Nuoc-Mam. - E' una nuova ricetta? - No, lo faccio spesso per tuo nonno. A lui piace molto. - Che cos'è il cinnamomo? - E' una pianta che cresce nell'Estremo Oriente. Ha un po' il gusto della cannella. - E il Nuoc-Mam? - Quello serve ad insaporire il riso. E' un estratto di pesce lasciato a macerare per qualche tempo. Ha un gusto delizioso, ma un pessimo odore. Non ti consiglio di annusarlo. - Me lo fai odorare? - Se proprio vuoi! - disse Nonna Marta prendendo dalla credenza un boccettino contenente un liquido di colore scuro. Lo aprì e con un sorriso malizioso glielo mise sotto il naso. Mino diede una bella annusata e strabuzzò gli occhi. Aveva fatto male a non dar ascolto alla nonna perché l'odore era veramente schifoso e nauseabondo. Sapeva di pesce marcio. - E mi fai mangiare questa porcheria, nonna? - Sentirai che delizia. La mattinata passò velocemente; il pranzo un po' meno perché a tavola si sta sempre volentieri specie quando le portate sono gustose e il pranzo che nonna aveva preparato era veramente delizioso. Persino il Nuoc-Mam che, mescolato agli altri ingredienti, aveva un ottimo sapore. Dopo il pranzo Mino, seduto sul divano in compagnia del nonno, prese pure lui il caffè. Una tazzina, la sua, piena di caffè molto diluito con acqua, ma in compenso assai zuccherato. Poi lasciò che nonno si leggesse in pace il suo INFORM e raggiunse Nonna Maria in cucina per aiutarla ad asciugare i piatti. - Mi fa piacere, Mino, averti ogni tanto attorno. Rompi la monotonia. Perché non vieni ogni sabato? Una volta al mese è troppo poco, Che ne pensi? - Per me, nonna, verrei addirittura a vivere stabilmente con voi. Ma lo sai che devo andare a scuola anche il sabato. Ieri ho saltato le lezioni e stasera dovrò telefonare ad un amico per farmi dare i compiti. - Già, la scuola - fece nonna, strofinando la pentola e poi risciacquandola sotto il rubinetto. - Non vedo l'ora che Sandro abbia qualche anno di più così vi potrete alternare e noi avremo sempre qualcuno a farci compagnia. "Alè, altro colpo di arteriosclerosi!" pensò Mino. "Ha detto Sandro come se si trattasse di un maschio. Magari lo fosse così tra qualche anno avrei qualcuno con cui giocare. Ma con una femmina, sai che barba!" Le ore passarono veloci e presto giunse il momento del commiato. Nonno l'avrebbe accompagnato fino alla stazione e nonna, prima di abbracciarlo, gli avrebbe consegnato come di consueto il solito pacchetto per la mamma, contenente qualche marmellata confezionata da lei. - Ecco, Mino, qui ci sono dei biscottini, della marmellata e due barattoli di miele. Vedrai, vi piaceranno. Specie il miele. Di' a mamma di dare a Sandro un cucchiaio di miele al giorno. Dicono che faccia bene alle ossa. Con Nonno Livio si avviò alla volta della stazione e presero la strada che passava proprio di fronte alla Gelateria Aurora. Solo in quel momento si ricordò di dire al nonno che aveva lasciato un debito da pagare. - Hai fatto bene a dirmelo, Mino. Non si debbono lasciare debiti in giro. Vieni, andiamo a pagare. Entrarono e si avvicinarono alla cassa. - Buongiorno, signor Livio, - li accolse la cassiera con un sorriso. - Lo sa che suo nipote è un bel burlone? Forse ha preso da lei. Dicono che anche lei ai suoi tempi lo fosse. Si figuri che voleva pagarmi i gelati con una specie di biglietto colorato con sopra scritto il numero diecimila. Se lo immagina lei un biglietto da diecimila crediti! Non so nemmeno se esistono. Nonno Livio sorrise, pagò e poi, preso per mano il nipote, uscì. In stazione gli comprò il biglietto e glielo mise in tasca con una busta. Se la nonna pensava alle leccornie, Nonno Livio era sempre pronto a fargli scivolare in tasca qualche soldarello per le minute spese. Mentre la busta gli scivolava in tasca, guardò il vecchio con un sorriso che significava al tempo stesso "Grazie , nonno, ne terrò conto e non dirò nulla alla mamma. Questi sono miei e me li gestisco come voglio". Il treno arrivò puntuale e Mino, affacciato al finestrino, salutò il nonno e lo vide rimpicciolire a poco a poco in quella stazione che, anche dalla parte dei binari, portava la scritta Piretoli. Seduto in uno scompartimento di fronte ad una suora, il ragazzo riandava con la mente alle ore trascorse con i nonni, alle stranezze che aveva notato nel paese e non riusciva a capacitarsene. Possibile che nello spazio di un mese dalla sua ultima visita si fossero verificati tanti cambiamenti... "come questa casa, pensò, che da blu-cobalto è diventata interamente bianca". E la guardò mentre il treno le passava davanti. Poi il convoglio si immerse nella galleria e Mino fu distratto dal saliscendi delle linee bianche tracciate sul muro. All'improvviso, come era avvenuto all'andata, il treno cominciò a rallentare e si fermò. "Ma che matti alle Ferrovie dello Stato, - pensò - far lavorare gli operai anche di domenica. E adesso che succederà ancora? Mancherà di nuovo la corrente?" Quasi fosse stato un indovino, la luce si spense per poco più di un minuto e poi ritornò. Subito dopo il treno riprese la corsa e acquistò velocità quasi a volersi sottrarre al buio della galleria. E il chiarore del giorno esplose nuovamente. Il ragazzo si alzò e se ne andò nel corridoio, tenendo tra le mani il pacchettino che la nonna gli aveva dato. Voleva aprire il finestrino e non aveva osato farlo nello scompartimento per non disturbare la suora che pregava. Ma non fece in tempo perché avvertì alle sue spalle la voce del controllore. - Biglietto, ragazzo. Mino trasse di tasca il biglietto che Nonno Livio gli aveva consegnato unitamente alla busta con i soldi e lo porse al controllore. - Dico, ragazzo, vuoi scherzare? Che cos'è questo tagliando? - E' il biglietto, signore. Me l'ha comperato mio nonno alla stazione di Piretoli. - Ma che Piretoli! Perentola vorrai dire. - Faccia un po' lei. Prima si chiamava Perentola, ma oggi si chiama Piretoli. Guardi, c'è scritto persino sul biglietto. - Dove l'hai preso? - gli chiese l'uomo dopo averlo rigirato più volte tra le dita. - Gliel'ho detto: è stato mio nonno a comprarmelo. - Come ti chiami? - Giacomo Soriano, ma tutti mi chiamano Mino Il controllore lo guardò fisso, poi, tratto di tasca un giornale, guardò la prima pagina. - Dei dell'Olimpo! Ma guarda chi mi è capitato tra le mani! Sei proprio Giacomo Soriano? - Sì. - E dove sei stato in questi due ultimi giorno? - Sono stato dai nonni. - Senti, Mino, io ho tre figli giovani e capisco subito quando dicono bugie e tu stai dicendomene una. - Glielo assicuro, signore, - lo interruppe - le sto dicendo la verità. - E allora come mi spieghi questo? - Il controllore gli mise sotto il naso il giornale sulla cui prima pagina, a caratteri grossi, si leggeva: FUGA? RAPIMENTO? NESSUNA NOTIZIA DEL BAMBINO SCOMPARSO. Seguiva un lungo articolo completato da una fotografia. La sua. - Qui, - continuò il controllore - si dice che hai preso il treno per andare dai nonni a Perentola, ma da loro non sei mai arrivato. Caro il mio ometto, quando arriveremo in stazione ti dovrò consegnare alla Polizia Ferroviaria. Sapranno loro che farsene di te. - Ma io non ho fatto niente! - cominciò a piagnucolare. - Io sono stato dai nonni. - Su non piangere. Non c'è niente di cui vergognarsi per una scappatella. Vedrai che te la caverai con una semplice sculacciata. Quando il treno arrivò in stazione il controllore accompagnò Mino nell'ufficio della polizia e lo affidò ad un agente dopo avergli spiegato il fatto. Gli consegnò il biglietto e se ne andò. L'agente fece sedere il ragazzo e cominciò a fare una serie di telefonate. Dopo un quarto d'ora arrivò un funzionario della polizia, poi il questore e, infine, Mino vide suo padre, sua madre e suo nonno precipitarsi verso l'ufficio di polizia. Sua madre entrò come un bolide e Mino si sentì soffocare tra le braccia della donna che rideva e piangeva al tempo stesso. Suo padre più composto gli passava una mano tra i capelli scompigliandoglieli. Nonno Livio guardava la scena. Si vedeva che era contento, come se gli avessero tolto un peso dallo stomaco. Il funzionario e il questore se ne stavano immobili da una parte. - Ma nonno, - fece il ragazzo, guardando con occhi stupiti il vecchio - come hai fatto ad essere già qui? Se hai viaggiato sul mio stesso treno, perché non ti sei fatto vedere? E come hai fatto a salire se stavi sul marciapiede quando il treno è partito? - Ma che dici, Mino! E' da stamattina che mi trovo in città. Ti abbiamo cercato come disperati. "Alè, altro attacco di arteriosclerosi. Oh, è proprio galoppante nei vecchi!" pensò Mino. E poi ad alta voce disse: - Sentite io non ci capisco più niente. Alle cinque di questo pomeriggio tu, nonno, mi hai accompagnato alla stazione per prendere il treno e mi hai anche messo in tasca il biglietto. - Della busta con i soldi non disse nulla perché quello era un segreto tra lui e il nonno e gli altri non dovevano saperlo. - Eccolo là il biglietto! E' quello che mi ha confiscato il controllore. Nonno Livio si avvicinò al nipote e gli pose una mano sulla fronte. Mino, che teneva la testa bassa, vide un giornale spuntargli dalla tasca. Lo prese e lesse " La Stampa" - Allora continui a leggere "La Stampa", nonno! - Ho sempre letto "La Stampa", - rispose il vecchio, stupito per quella domanda insolita. - Nonno, non dire bugie. Proprio questo pomeriggio ti ho visto mentre leggevi l'INFORM e così pure ieri. - L' INFORM! Mai sentito nominare - rispose il nonno, togliendogli la mano dalla fronte che non scottava affatto come aveva temuto. "Alè - pensò Mino - altra bordata di arteriosclerosi! Nonno sta proprio perdendo la memoria." Fu a questo punto che intervenne il questore. - Signori, gradiremmo anche noi parlare col ragazzo. Vi prego di lasciarci soli. Ormai avete constatato che il ragazzo sta bene. Noi dobbiamo portare avanti e concludere le indagini e dobbiamo porre parecchie domande al ragazzo. Accomodatevi nella sala a fianco. Potrete condurlo a casa non appena avremo finito. Con una certa riluttanza i genitori e il nonno uscirono e lui rimase in compagnia di un agente che teneva un registratore tra le mani, del questore e del funzionario di polizia. - Allora, Mino, sei calmo? Hai bisogno di qualcosa? - gli chiese il funzionario con fare paterno. Mino fece cenno di no col capo- - Bene, allora ascoltami: tu ora mi devi raccontare per filo e per segno tutto quello che ricordi dal momento in cui, ieri, hai lasciato la stazione fino a quando il controllore ti ha accompagnato in questa stanza: ti va? - Ma certo, sarà come scrivere un diario. I presenti si guardarono e sorrisero. - Allora comincio. Ieri, sabato, papà mi accompagnò al treno perché mi recassi dai nonni, come faccio di solito, ogni mese. Ho viaggiato in uno scompartimento vuoto e ho continuamente guardato dal finestrino, salvo quando un controllore, diverso da quello di oggi, mi ha chiesto il biglietto. Ricordo che il treno si è fermato in una galleria. Pensavo che ci fossero lavori in corso. E' mancata la luce per un minuto circa e poi il treno è ripartito. E' stato dopo l'uscita dalla galleria che ho cominciato a notare alcune stranezze. - Quali stranezze?- chiese il funzionario. - Ho visto una casa che aveva la facciata bianca, mentre nei precedenti viaggi avevo notato che era dipinta in blu-cobalto. - E ti sembra questa una stranezza? - gli fece notare il questore - No, ma è stata una cosa che mi ha colpito. Poi c'è stato il nome della stazione. Qualcuno l'aveva cambiato in Piretoli. Non sapevo che fosse così facile cambiare il nome ad un paese! - In verità non lo è - disse il questore. - E tra l'altro non mi risulta che nelle vicinanze ci sia un paese di nome Piretoli. - Poi - continuò Mino - quando sono arrivato a casa dei nonni, ho visto che la credenza era stata spostata: l'ho fatto notare alla nonna, ma quella mi ha risposto che quel mobile era sempre stato lì dove lo vedevo. Ho pensato, come dice mio padre, che nonna soffrisse un poco di arteriosclerosi, e allora sono andato dal nonno per stuzzicarlo parlandogli del governo. So che quando si tocca quel tasto lui si accende come uno zolfanello, incomincia ad inveire contro questo o quel ministro, tirando moccoli colorati che mi fanno ridere. Ma mi sembrò che nonno avesse fatto pace col governo e non volesse più parlarne. Fu allora che gli vidi in mano un giornale diverso da quello che leggeva sempre. - Quale giornale? - chiese il questore. - Nonno ha sempre letto "La Stampa", ma ieri aveva tra le mani l'INFORM. E' un giornale che non ho mai visto nelle edicole. E sì che il mio giornalaio ci tiene ad esporli tutti. - Ti ricordi di aver letto qualche notizia? - No, non l'ho letto: ho visto solo il titolo. - Va avanti. - Siccome nonno non sembrava disposto a chiacchierare, sono andato a fare un giro per il paese. Mentre passeggiavo mi accorsi che qualcosa era cambiato. Ad esempio: la statua di Salvo Calvi era stata sostituita da un uomo a cavallo di nome Walter Allori. Il funzionario di polizia guardò il questore che scosse il capo. - C'era qualcosa di scritto sul basamento della statua? - C'era scritto: "I cittadini con affetto" e nient'altro. Nemmeno una data. Fu mentre guardavo la statua che il figlio del macellaio mi salutò. E' un ragazzo della mia età col quale gioco quando vado dai nonni. Mi portò in una gelateria che si chiama Aurora e che non conoscevo, anche se mi disse che era lì da anni. Non avevo ragione per non credergli perché lui in quel paese ci abita dalla nascita. E poi c'è l'episodio dei soldi. - Raccontalo! - C'è poco da dire. Quando ho dato alla cassiera diecimila lire per pagare i gelati, quella mi ha guardato di brutto perché credeva che scherzassi. Si è messa a parlare di crediti, di den, di tall. A me sembrava che fosse lei a scherzare. Ma il mio amico mi ha trascinato via dicendole che i gelati li avrebbe pagati mio nonno. E siamo usciti. A proposito, conoscete Maximilian Prescott, Dona Carue e Stan Gilford? - Dovremmo conoscerli? - Sembra che siano divi del cinema molto noti. I primi due hanno preso l'Oscar quest'anno. I due funzionari si guardarono scuotendo il capo. - Hai notato altre stranezze? - Sì, cose di poco conto come il fatto che mio nonno, che di sport e in particolare di calcio se ne intende, mi ha detto che le squadre del Milan e dell'Inter si trovano entrambe in serie C. Vi risulta? - Ci mancherebbe pure questa! - sbottò l'agente che di certo tifava per una delle due. - Ho saputo, continuò il ragazzo - che il notiziario delle venti sul primo canale non c'è più; che la Messa delle undici è stata soppressa e che nonna ha una nuova mania: quella di cucinare cibi all'orientale. Figuratevi che mi ha fatto il riso al cinnamomo e al Nuoc-Mam. - Erano buoni? - chiese l'agente che teneva il registratore acceso in mano. I due funzionari lo fulminarono con uno sguardo. - Perdinci! Ah, ora che ci penso, non capisco come nonna possa sostenere che mia sorella Sandra è un maschio. E dire che è stata proprio lei a tenerla tra le braccia durante il battesimo! - Ti ricordi altro? - No, è tutto quello che ho visto e sentito. - La stazione era sempre uguale? Non hai notato nulla di diverso oltre il nome? - Ora che mi ci fate pensare, sì: non c'è più il sotto passaggio: devono averlo riempito. - E nella vettura del treno hai notato qualcosa di diverso? Mino ci pensò un poco e poi scosse la testa. - Per me il treno era simile a quelli che stanno là fuori, - disse, indicando il via vai dei convogli lungo i binari. - E poi potete chiedere agli operai che lavorano nella galleria. Ci hanno costretto ad attendere una decina di minuti, durante i quali è pure mancata la corrente elettrica. Tutto proprio come all'andata. All'osservazione di Mino i due funzionari tornarono a guardarsi, quasi entrambi ricordassero qualche particolare che solo loro conoscevano e che doveva essere tenuto segreto. - Mino, è tutto vero quello che ci hai raccontato? Non hai dimenticato nulla? Mino si mise la mano in tasca e, sentendo tra le dita la busta di Nonno Silvio, arrossì. - Sì, vi ho detto tutto. - Proprio tutto? - chiese il funzionario di polizia che, come il questore, aveva colto l'improvviso rossore. Mino ricordò che una volta suo padre gli aveva detto che alla polizia si deve sempre dire la verità. "Pazienza, si disse, se si viene a sapere che avevo un piccolo segreto col nonno. Vuol dire che ci rimetterò il gruzzoletto che nonno mi ha dato." Trasse di tasca la busta dicendo: - Vedete, nonno, ogni volta che vado a trovarlo, mi dà qualche soldino per i miei capricci e non vuole che lo dica ai miei. E' il nostro segreto. Posò la busta sul tavolo a fianco del biglietto ferroviario. Il questore la prese, l'aprì e ne trasse alcune banconote. Le guardò e poi con un gesto meccanico le passò al funzionario di polizia. Si trattava di alcuni foglietti. Il più grande era simile alle nostre diecimila lire, ma era di color rosso cupo, con molti fregi e due figure, una per lato. In mezzo c'era scritto "Stato Taliano. Vale 20 crediti"; un altro foglietto più piccolo era di color verde con gli stessi fregi, ma figure diverse. Portava la dicitura "10 tall". E, infine, due bigliettini delle dimensioni delle nostre mille lire recavano la scritta "5 den" - Quant'è? - volle sapere Mino. - Con tutto quello che mi è capitato non ho neppure avuto il tempo di controllare. - Diecimila lire - rispose distrattamente il funzionario di polizia. E proseguì: - Queste dobbiamo tenerle noi. Ti darò io diecimila lire in un solo biglietto. - Trasse di tasca il portafogli dove pescò un biglietto da diecimila e lo porse al ragazzo. Mino si affrettò ad intascarlo. Era stato generoso il nonno: di solito gliene dava solo cinquemila. I due uomini si appartarono in un angolo e parlarono fitto fitto, ma a voce così bassa che Mino, per quanto tendesse le orecchie, non riuscì ad afferrare una parola. Poi si voltarono verso l'agente e gli dissero di far rientrare i genitori e il nonno. - Sentite, signori Soriano, - disse il funzionario di polizia, - abbiamo interrogato vostro figlio e l'abbiamo trovato in forte stato confusionale. Ci ha fornito un resoconto molto confuso, per lo più inventato. Sarebbe opportuno che non parlasse con i giornalisti. Tenetelo per qualche giorno in casa finché la notizia della sua scappatella non si sarà spenta. Se volete potete farlo visitare da uno psichiatra. - No, - lo interruppe Mino - io da uno strizzacervelli non ci voglio andare. (che bello poter dire 'strizzacervelli' davanti a tanta gente! Un bel vocabolo che aveva imparato da un film in TV) - E allora, Mino, se proprio non ci vuoi andare, non devi raccontare a nessuno la storia strampalata che ci hai propinato poco fa. - Ma io ho detto la verità! - E allora vi consiglio di portarlo da uno strizzacervelli - disse con volto serio il funzionario di polizia rivolto ai parenti. - Va bene, va bene, farò come dite voi. Non racconterò niente a nessuno. - Molto bravo, Mino. Potrai dire ai giornalisti che invece di andare dai nonni sei sceso dal treno, te ne sei andato in giro per la città per conto tuo e poi, finiti i soldi, hai deciso di tornare a casa. E se ti chiedono dove hai trascorso la notte, puoi rispondere che l'hai trascorsa in stazione. E mentre parlava il funzionario guardava i parenti quasi volesse far loro capire che dovevano attenersi a quella versione. - Ora potete portare il bambino a casa. Lei, signor Soriano, venga domattina nel mio ufficio. Le debbo parlare in privato. Con Mino in mezzo e il nonno di retroguardia, la famiglia Soriano si affrettò ad uscire dal posto di polizia per dirigersi verso casa. - L'ha trattato un po' duramente il ragazzo - disse il questore. - In fondo è stato sincero con noi e ci ha raccontato tutto quello che sapeva. Altro che stato confusionale! Quello era oltremodo lucido. - Ho dovuto farlo - si scusò il funzionario. - Se la stampa venisse a sapere che questa è la terza volta che si verifica un fatto del genere, saremmo in un bel pasticcio. - E domani che cosa dirà al padre? Penso che abbia diritto ad una spiegazione. - Troverò qualcosa. Ma lei, signor questore, che cosa ne pensa di questi fatti? L'uomo tergiversò un poco prima di rispondere. - Dare una spiegazione logica del fenomeno è impossibile. Io mi attengo ad una teoria, forse fantastica, la quale prevede l'esistenza contemporanea di mondi paralleli. - E cosa sono? - Sono mondi simili al nostro, i quali esistono contemporaneamente al nostro e nei quali le differenze col mondo in cui viviamo sono minime. - Se ho ben capito, signor questore, in questo momento esisterebbe un mondo parallelo, uguale al nostro, ma da noi separato da una barriera invisibile e che, quindi, non possiamo vedere, nel quale ci siamo noi due in una stanza a discutere di un ragazzino, e c'è pure tutta la stazione che ci circonda. Il questore sorrise. - E' difficile credere, ma io penso che sia così. Anch'io ero scettico quando un mio amico scienziato cercò di spiegarmi la situazione, ma mi convinse con un esempio. Mi disse: "Quando ti guardi in uno specchio, che vedi?" Gli risposi: "Vedo me stesso in una stanza che mi guarda". "Quindi in quel momento ci sono due persone uguali che si trovano in due stanze uguali. Due mondi diversi ma paralleli. Capito?" "Già. Ma se mi allontano di lato, nello specchio non ci sono più" gli feci notare. "Giusta osservazione, mi rispose, però nello specchio rimane sempre la stanza. E chi ti dice che quando sei 'uscito dallo specchio' tu sia anche uscito da quell'altro universo in cui ti trovavi un istante prima? Non potresti essertene andato per i fatti tuoi proprio in quell'universo parallelo. Il funzionario di polizia era perplesso. - E la faccenda del ragazzino, come la spiega? Nella galleria del treno non c'erano specchi. - Be', lo specchio era solo un esempio. Noi non sappiamo come sono fatte e dove sono le 'porte di passaggio' che mettono in comunicazione due mondi paralleli. Forse ce n'è una in quella galleria che immette in un altro mondo in cui esiste la stazione di Piretoli e il paese in cui Mino ha vissuto quel fine settimana. Lui, durante il minuto di buio trascorso sul treno è passato senza volerlo e senza saperlo da un mondo all'altro e, al ritorno, sempre in galleria e sempre nel buio, è ritornato nel nostro. Questo potrebbe spiegare le differenze che lui ha notato. - E' difficile da credere. - Non tanto: guardi le prove su quel tavolo. Entrambi guardarono le strane banconote su cui stava scritto: "credi, tall, den" invece di lire; "Stato Taliano" invece di Italiano e il biglietto del treno con l'intestazione di "Stazione di Piretoli" Chissà da che mondo parallelo erano giunti!
IL SOLDATO DI VENTURA
di Marino Cassini
Un soldato di ventura, attraversando un campo di grano in cui le messi crescevano rigogliose e sugli steli le spighe erano ormai mature e pronte al raccolto, si stupì nel non vedere alcun uccello volteggiare o posarsi a terra in cerca di chicchi. Ne comprese la ragione quando vide troneggiare nel bel mezzo del campo uno spaventapasseri. Il soldato si avvicinò per vederlo meglio. Lo spaventapasseri, imponente e minaccioso, si ergeva ritto, appeso ad un palo in modo da potersi muovere al minimo soffio di vento. Un ampio cappellaccio di paglia gli copriva la testa da cui pendevano lunghi cappelli fatti con fili di erba secca, grigiastri e scuri. Sotto la fronte in due buchi neri erano incastrate due biglie di vetro rosso che, quando erano colpite dai raggi del sole mandavano all’intorno bagliori purpurei. Nella bocca semiaperta, sormontata da un lungo naso adunco, si vedevano denti nerastri e appuntiti. Sembrava un teschio appena uscito dalla tomba. Una giacca rosso porpora ricoperta da lucenti alamari e da scintillanti medaglie appuntate sul petto, riflettevano i raggi del sole. Indossava un paio di pantaloni logori, sdruciti, sfrangiati in basso, con le tasche rivoltate. Faceva paura tanto che nessun uccello osava avvicinarsi. Il soldato, dopo averlo ben squadrato dall’alto in basso, gli chiese: “Ma tu, non ti stanchi mai di startene esposto alla pioggia, alla grandine, alla neve, al vento, al caldo, al freddo? Deve essere ben terribile la tua vita!”. Lo spaventapasseri gli diede una occhiata da far paura. Era un po’ stupito che un essere umano gli rivolgesse la parola. Lo ritenne un essere inoffensivo e anche curioso. Gli rispose: “No, io non mi stanco mai e la mia vita non è affatto terribile”. “Che gusto trovi nel tuo lavoro? “La gioia che mi procura il poter incutere la paura negli uomini e negli animali. Un piacere così grande e intenso che mi ripaga di ogni sforzo e di ogni disagio che debbo sopportare. Ma che ne puoi sapere tu! La gente come te non può capire”. E, senza aggiungere altro, si voltò verso uno stormo di passeri che stava per posarsi tra il grano matuto. I suoi occhi lanciarono lampi di luce e gli uccelli fuggirono terrorizzati. Il soldato si allontanò scuotendo il capo e non vide il piacere che affiorava sul volto spettrale dello spaventapasseri. Passarono anni prima che il soldato, appoggiato ad un bastone, ormai vecchio e ingobbito, ripassasse da quelle parti. Rivide lo spaventapasseri sempre al suo posto, sempre in mezzo al campo, sempre vestito allo stesso modo, anche se gli abiti erano diventati più logori e cadenti. Gli si avvicinò, voleva salutarlo per chiedergli molte cose. Lo guardò. Il loro sguardi si incrociarono. Bastò solo quello perché il soldato avesse la risposta alle sue domande. Con un sorriso sul suo volto ormai rugoso, si allontanò senza porgli alcuna domanda. Aveva capito dopo aver notato che sull’ampio cappello di paglia dello spaventapasseri alcuni uccelli avevano costruito il nido. Aveva visto i piccoli con la testa rivolta verso l’alto, i becchi aperti, pronti ad ingoiare i chicchi e gli insetti che i genitori portavano loro, volando attorno allo spaventapasseri senza alcun timore. Il soldato aveva compreso che il cuore di ognuno, col passare degli anni e con le esperienze della vita, si ammordisce. Aveva compreso che non si può trovare gioia nell’incutere la paura agli altri. Questo avevano capito sia il soldato, sia lo spaventapasseri.
PER ALTRI RACCONTI GIA’ EDITI VEDI:
La vera storia dei cento ciuchini in Antologia di fiabe e leggende (vol.I), Milano, ed. L'Ariete, 1965. Il fiore di fuoco, in Antologia di fiabe e leggende (vol.II), Milano, ed. L'Ariete, 1967. Il vecchio e il pescespada, Alessandria, Tip. Occella, 1970. Il vecchio e il pescespada, in Racconti navali (vol.V), Roma. ed ANMI, 1974. Carusiello e la libertà, in Racconti della buona notte (vol.V), Milano, ed. AMZ, 1975. Le valvole dispettose, in "Sfoglialibro", n. 2/1989. La grande nube, in "Il giornale dei bambini", n. 6/1992. Il barattolo, in "Il giornale dei bambini", n. 9, 1993. I due presidenti, in "Il giornale dei bambini", n. 11-1993. Un piccolo equivoco, in "Future shock", n. 26-1998. Come nacque il mare, in "Popotus", inserto settimanale per ragazzi del giornale "L'Avvenire", agosto 1998. Il colore della pelle, in "Popotus", gennaio 1999. L'ultima avventura di Robinson Crusoè, in "Popotus", dicembre 1999. Paisha, Robottino e il Genietto che cavalca i raggi di sole, Genova, Centro sistema bibliotecario provinciale, 2001. Non si uccidono gli editori, Genova, Centro Sistema Bibliotecario Provinciale, 2001 L’eco di Grottafratta, in “Popotus”, 28 aprile 2001 La mia amica Cirò, in “Popotus”, maggio 2002. Fine senza principio in “Future Shock”, n. 38, 2002. La pergamena rossa nel sito Internet, 2005, www.associazioneletteraturagiovanile.it Cino e Oliva, 2005 idem Le due madri, 2005 idem Il club della risata, 2005 idem Una mattinata in pretura, 2005 idem Spadanera, 2006-12-06 idem I due presidenti 2006 idem Barzerime, 2005, 2006 idem Limerick, 2005, 2006 idem La vispa Teresa , parodia idem
Racconti per ragazzi - Marino Cassini |
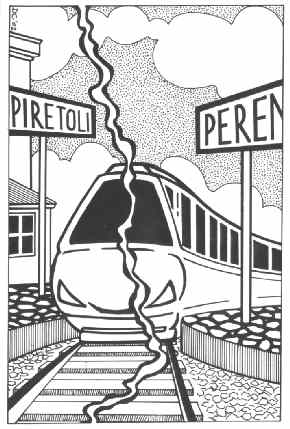 praelevati
su un terrapieno che faceva da sponda ad un torrente dove in primavera si
poteva vedere lungo le sue sponde qualche pescatore. Durante l'estate il
flusso dell'acqua si riduceva ad un rigagnolo giallastro che alimentava
piccole pozze d'acqua melmastra dove i pesci boccheggiavano in assenza di
ossigeno. E poi c'erano gli orti, le vigne a pergolato e qualche
appezzamento più vasto, coltivato a patate e a granoturco.
praelevati
su un terrapieno che faceva da sponda ad un torrente dove in primavera si
poteva vedere lungo le sue sponde qualche pescatore. Durante l'estate il
flusso dell'acqua si riduceva ad un rigagnolo giallastro che alimentava
piccole pozze d'acqua melmastra dove i pesci boccheggiavano in assenza di
ossigeno. E poi c'erano gli orti, le vigne a pergolato e qualche
appezzamento più vasto, coltivato a patate e a granoturco.